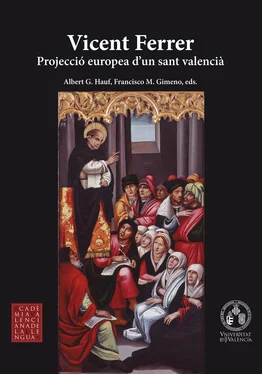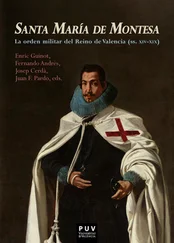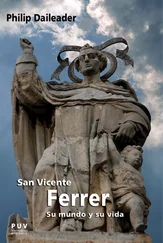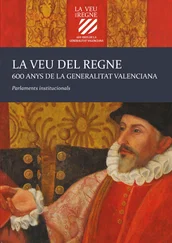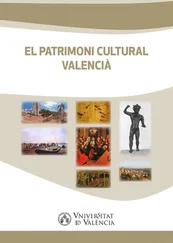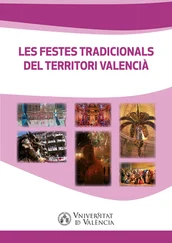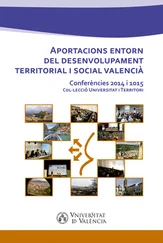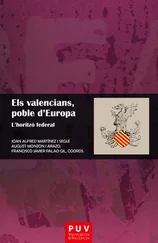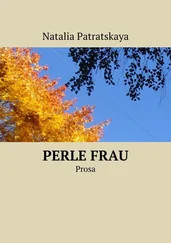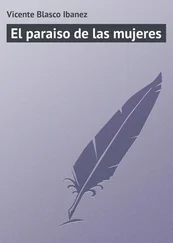Negli anni di preparazione passati negli Studia di València, Lérida, Barcelona, e poi nel periodo trascorso alla corte pontificia di Avignone e nelle missioni in Italia, Ferrer dovette conoscere in tutta la sua ampia e varia tradizione l’ ars praedicandi elaborata dai Mendicanti, ed ebbe familiarità con gli strumenti di lavoro preparati dai Domenicani, a cominciare dai sermoni modello, ai quali. come si è visto nel sermone Colligite , egli allude esplicitamente. Non si può escludere che egli avesse notizia dell’ Ars predicandi populo di Francesco Eiximenis, una delle prime opere del famoso frate francescano; non potevano lasciarlo indifferente la trattazione delle forme retoriche adatte alla predicazione ai laici, la dettagliata esposizione dell’ ars memorativa che cattura l’attenzione con le immagini ( imagines agentes ). 4Tuttavia si è notato che Ferrer, rivolgendosi al pubblico, ricorre proprio ad una formula («Bona gent») in uso nell’oratoria civile (Fuster, 1995: 125, nota 144) e censurata dal trattato di Eiximenis (Martínez Romero, 2002: 56). Non pochi studiosi (De Garganta, 1980: 156; Robles Sierra in Ferrer, 1995, 24) hanno piuttosto richiamato l’attenzione sull’influsso decisivo della tradizione retorica propria dell’ordine dei Predicatori, in particolare del De modo componendi sermones di Tommaso Waleys, che si ispirava alla propria esperienza di insegnamento negli Studia dell’Ordine («secundum ea quae in Ordine Praedicatorum a pueritia enutritus et in diversis studiis generalibus ac provinciis conversatus de arte huiusmodi comprehendo») (Charland, 1936: 95 e 328), oltre che alla conoscenza diretta della predicazione italiana e avignonese. 5Nemico del formalismo, Waleys prova simpatia per gli schemi popolari che danno spazio alle narrazioni evangeliche, e pone una netta distinzione tra le artificiose e complesse strutture del sermone universitario e il più semplice disegno che procede per distinctiones , adatto all’uditorio laico, e prediletto –come subito vedremo – da Ferrer. La predicazione di san Vicente Ferrer è documentata da uno straordinario corpus di testi: dagli schemi brevissimi ad uso proprio e dei suoi discepoli alle reportationes latine e catalane fino alla raccolta dei manoscritti di Tolosa preparata in vista della canonizzazione, dalla quale probabilmente deriva la serie dei sermonari latini a stampa (Gimeno Blay, 2019: 155).
La varia sperimentazione delle forme retoriche del sermone medievale e le scelte decisive di Ferrer sono documentate nel codice del convento domenicano di Perugia (ms. 477) che contiene ben 477 schedulae raccolte a cominciare dal 1407, con successive aggiunte fino ad una data posteriore al 1412, anno della già citata lettera a Benedetto XIII copiata sotto il num 430. 6Il sermonario riflette una lunga esperienza: copiato quando il santo è ancora attivo, è uno strumento messo a disposizione dei suoi discepoli. Già l’osservazione di una parte, sia pure ridotta, delle schede (le prime 150), permette di identificare una linea netta di tendenza e di scelte retoriche: si tratta degli schemi per le prediche di Avvento, del periodo natalizio, della Quaresima fino alla settimana dopo l’ottava di Pasqua; si aggiungono, ad apertura del sermonario, i sermoni dalla domenica XXII alla domenica XXIV post Trinitatem 7. Solo 14 sermoni sono costruiti mediante divisio del versetto tematico 8, secondo le norme del sermone moderno o scolastico, «iuxta singula verba» come si esprime Ferrer all’inizio dello schema «De beato Thoma apostolo» (num. 45) o «iuxta verbum thematis» come si legge nella divisione del sermone per la domenica infra Octavam Epiphanie (num. 64). Thema ovvero fondamento del discorso, in questo caso, è il versetto Proficiebat sapientia et etate et gratia (Lc 2, 52), articolato in tre membri che riprendono le tre parole (o dictiones ) «sapientia», «etate», «gratia». Gran parte di questi 14 schemi sono ripetuti nei cicli di predicazione di Ferrer, ma alcuni sono abbandonati, forse perché troppo complicati 9.
Ben più frequentemente Ferrer ricorre ad un altro modo di articolazione del discorso, che fa riferimento non alle singole parole del thema, ma all’intera pericope, percorsa per intero e suddivisa con criteri analoghi a quelli in uso nell’esegesi biblica e nelle antiche omelie. Basti un esempio, la scheda per il lunedì dopo la domenica delle Palme (num. 136): un abbozzo che Ferrer sviluppò e colorì molte volte nella sua predicazione effettiva (Perarnau i Espelt,1999b; 791, num. 875). Il versetto tematico è Venit vox de celo dicens: Et clarificavi, et iterum clarificabo (Io 12, 28), e il sermone riguarda le forme di onore secondo le quali Cristo è glorificato: con l’amicizia («ex amicabili dilectione»), con l’ammirazione («ex intellectuali admiratione»), con la devozione («ex spirituali devotione»), per la voce del Padre («ex celestiali loqutione»). Questi punti sono esposti e illustrati «iuxta seriem Evangelii hodierni», percorrendo per intero il capitolo 12 del vangelo di Giovanni (la cena di Betania e l’unzione dei piedi di Gesù, il suo ingresso trionfale in Gerusalemme, la richiesta dei Gentili di vedere Gesù, e infine la proclamazione dall’alto).
Nelle prime 150 schede del codice di Perugia, che abbiamo scelto come campione, il modello «iuxta seriem evangelii» ricorre 36 volte, con una frequenza particolare nei sermoni di quaresima 10. Un tale disegno narrativo era singolarmente adatto alla presentazione dei vangeli quaresimali incentrati su scene e episodi noti al pubblico laico. Non è un caso che sia costantemente usato nelle domeniche della Quaresima 11, quando la presenza dei fedeli doveva essere più numerosa: si tratta allora delle tentazioni nel deserto (num. 99), della preghiera della donna Cananea (num. 106), dell’ingresso trionfale in Geruslemma (num. 135), episodi notissimi, che si prestavano a veicolare e memorizzare efficacemente gli insegnamenti dottrinali e morali del santo 12.
Questo metodo espositivo che tempera il rigore delle enumerazioni con l’esposizione omiletica dei racconti evangelici era ben nota ai Mendicanti e soprattutto era in uso nella scuola domenicana. Sembra ben noto a Parigi, come documentano alcune reportationes del 1272-73: un sermone tenuto a Saint Gervais dal domenicano Gilles d’Orléans 13, e un sermone di un anonimo francescano alle beghine nella domenica delle Palme 14. Ma una testimonianza più antica e autorevole si trova nella predicazione di Tommaso d’Aquino, il quale costruisce i suoi sermoni dividendo il versetto tematico, ma poi, sviluppando il discorso, richiama l’intera pericope. Conviene riflettere su quanto dice padre Bataillon nell’Introduzione alla sua edizione critica: «Thomas, tout en explicant le verset choisi, souvent le premier de la péricope évangelique, en le divisant et le developpant, arrive à donner également une explication de tout le passage liturgique»(Tommaso d’Aquino, 2014:137*). Se ne può vedere un esempio nel sermone per la prima domenica di Avvento, svolto a Parigi il 1 dicembre 1269: Osanna filio David. Benedictus qui venit in nomine Domini. Osanna in excelsis (Mt 21, 9). La tavola del sermone ( divisio sermonis ) premessa al testo dall’editore permette di constatare che san Tommaso ha sì diviso in tre parti il versetto tematico, ma in seguito tratta l’argomento con suddivisioni che permettono di richiamare e di raccontare l’intero evangelo. È una scelta bilanciata tra sermo modernus , commentario biblico e antica omelia che è accolta nei sermonari dei primi discepoli italiani di san Tommaso, ad esempio Remigio de’ Girolami e il suo allievo Giordano da Pisa, Ambrogio Sansedoni e Aldobrandino da Toscanella (Delcorno, 1975:102-103; Delcorno, 2015: 516-517). Meritano particolare attenzione i sermoni modello di Aldobrandino, attivo nella Provincia Romana nell’ultimo ventennio del secolo XIII e autore di strumenti per la predicazione molto diffusi in tutta Europa (Kaeppeli, 1970: 239-246). Nel suo sermonario De Tempore la formula in tota serie evangelii è usata sistematicamente, si direbbe col valore di un termine tecnico. Si veda, ad esempio, il sermone per la domenica II di Avvento, sulla ‘piccola apocalisse’ di Luca: Erunt signa in sole et luna et stellis (Lc 21, 25-33). costruito appunto su quattro punti che toccano ordinatamente l’intera pericope evangelica. «In tota serie huius evangelii domenicalis de quatuor agitur» è la proposizione iniziale che si riferisce a v. 25 ( Erunt signa ), v. 27 ( tunc videbunt filium hominis ), v. 28 ( hiis autem fieri incipientibus ), v. 29 ( videte ficulneam ) (Aldobrandino da Toscanella: 14va; cfr. Schneyer, 1969: 223, num. 5). È un modulo compositivo che trova ulteriore testimonianza nella predicazione domenicana fra Tre e Quattrocento, ed esattamente tra i sermoni latini di un altro illustre predicatore, Giovanni Dominici (1355-1419), contemporaneo di Vicent Ferrer (Colosio,1970: 9-48; Ben Aryeh Debby, 2001; Delcorno, 2018: 175-179). In un codice miscellaneo di fine Trecento che contiene sermoni de Tempore e de sanctis attribuiti al Dominici si legge un panegirico per santo Stefano che ha per thema un versetto della invettiva di Cristo contro scribi e farisei, Ierusalem, Ierusalem que occidis prophetas etc . (Mt 23, 37). L’incipit ricorre alla nota formula: «Ex serie huius evangeli aggravatur peccatum Iudeorum circa necem sanctorum ex quinque», cioè «a bonitate interfectorum», «a modo interficiendi», «diuturnitate temporis», «a sanctitate loci», «a cause iniustitia»; argomenti svolti con rinvio ai versetti 34a, 34b, 32 e 35, 37 15.
Читать дальше