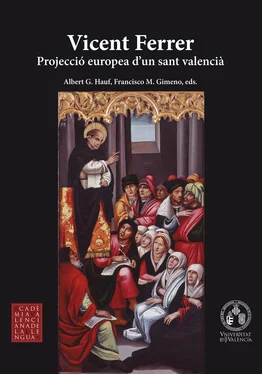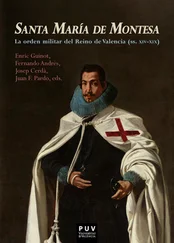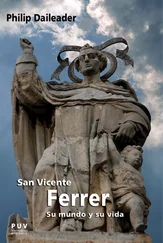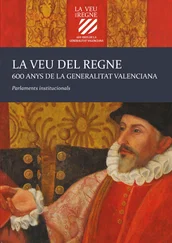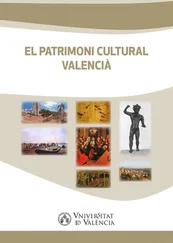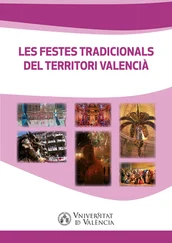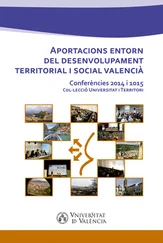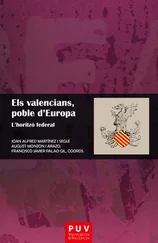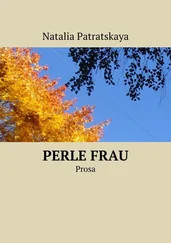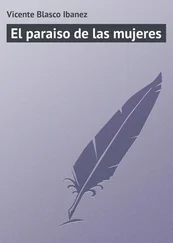A Vicent Ferrer si deve riconoscere innanzitutto la singolare consapevolezza della funzione storica che l’Ordine dei Predicatori, congiuntamente a quello dei Minori, ebbe lungo i quasi due secoli trascorsi dal momento della fondazione; e in quel quadro spicca la convinzione ferma del proprio compito di missionario della penitenza e della conversione nell’attesa escatologica. La famosa visione avvenuta nel convento domenicano di Avignone il 3 ottobre 1398, e raccontata da Ferrer nella lettera inviata a Benedetto XIII da Alcaňiz il 27 luglio 1412, mette in scena i due santi fondatori, Domenico e Francesco, in preghiera ai piedi di Cristo, e Cristo stesso che, da loro accompagnato, scende al letto del «religiosus valde infirmus» cioè frate Vicent, tocca la sua mascella quasi accarezzandolo, con un gesto che indica il compito di riprendere e rilanciare la predicazione itinerante dei Mendicanti: «maxillam eius tangens quasi demulcendo, manifeste innuebat eidem religioso infirmo, quod ipse iret per mundum apostolice predicando quemadmodum predicti sancti fecerant» (Ferrer, 2002: 559). È noto che lo stesso Benedetto XIII provvide a diffondere questo testo, ed è significativo che un’ampia parte sia dipinta alle spalle di uno dei più antichi ritratti di Ferrer, precedenti la canonizzazione, in un affresco della cappella di Santa Maria Assunta di La Stella (Macello, Pinerolo) (Rusconi 2016, 310). La visione di Ferrer è modellata sulla cosiddetta visione delle tre frecce, l’episodio fondante dell’Ordine dei Predicatori. Cristo - così si legge ad esempio nella Legenda aurea (cap. CIX D e sancto Dominico ) - nel punto in cui sta per scagliare tre frecce sul mondo irrimediabilmente corrotto è trattenuto dalla Madre, e concede una proroga, un breve tempo prima della fine del mondo, in cui trova spazio la predicazione di penitenza dei Mendicanti (Iacopo da Varazze, 1998: 724). Nella situazione fallimentare della società, della Chiesa ferita dallo Scisma, degli stessi Ordini Mendicanti, tale prorogatio è rinnovata nella persona di frate Vicent, predicatore apostolico «a latere Christi» (De Garganta, 1980:138), identificato con il primo degli angeli dell’Apocalisse che, inviato «ante diem iuditii» grida: «Timete Dominum […] quia venit hora iudicii eius» (Apc 14, 6). Questo evento, che dà l’avvio alla ventennale itineranza apostolica di Ferrer, è più volte ricordato nella sua predicazione, ben prima della sopra citata lettera di Alcaňiz. Così nel sermone sull’Anticristo recitato a Toledo l’8 luglio 1411 egli racconta la visione, la «revelación a un religioso que es vivo», sempre riferendola ad una terza persona: «E yo lo conosco e yo he fablado con él e me lo dixo por muchas vezes» (Catedra, 1994: 571). Ferrer rilanciava in termini nuovi la predicazione escatologica che connota l’ordine domenicano fin dalle origini, come documentano la bolla di canonizzazione di s. Domenico, la Fons sapientiae (3 luglio 1234), animata da accenti gioachimiti (De Fraja, 1999: 397-398; Rainini, 2002: 307-342; Bériou-Hodel, 2019: 766)¸ e la tradizione dei panegirici in suo onore. Così in uno dei sermoni di Iacopo da Varazze per la festa del santo, egli è identificato con la stella della sera contrapposta a quella del mattino, cioè Giovanni Battista (Iacopo da Varazze, De sanctis : 8ra; cfr. Delcorno, 1986, 59):
Sicut enim Johannes Baptista huius previum prenunpciavit adventum, sic et iste vicinum creditur prevenisse judicium (Luc. XIIII ‘misit servum suum’ idest, secundum Gregorium, ordinem predicatorum, ‘hora cene’, idest in fine seculi). Missus est ergo iste servus in extremo temporum quia, sicut dicitur 1 Cor. X ‘Nos sumus in quos fines seculorum devenerunt’[…] Missus est ab extremis terre, idest de finibus Yspanie […] Missus est usque ad extremum terre […] Missus pro extremo fine, pro assequendo extremum finem idest ipsum Deum.
Predicare la penitenza nell’imminenza della fine e del Giudizio è idea ben radicata nella tradizione domenicana e nell’ambiente in cui cresce Ferrer (Esponera Cerdan, 1998: 351). La tensione emozionale nell’attesa della fine che incombe «cito, et bene cito, ac valde breviter» (Ferrer, 2002: 562) è il ‘motore’ della sua predicazione (Ysern i Lagarda, 2015: 33) poiché l’esortazione alla conversione e alla battaglia contro i vizi acquista una specifica urgenza proprio perché il tempo è ormai brevissimo. È, questo, il messaggio trasmesso dalla iconografia diffusa dall’ordine dei Predicatori dopo la canonizzazione: il santo alza l’indice della destra verso la scena sovrastante del Giudizio ultimo, e con la sinistra regge un libro aperto su Apocalisse 14, 7; ma talvolta su altri testi, come nel celebre polittico dipinto (c. 1472) dai ferraresi Francesco del Cossa e Ercole de’ Roberti, un tempo nella cappella della famiglia Griffoni in S. Petronio, a Bologna, e ricomposto in occasione di una mostra al Palazzo Fava della stessa città (Natale-Cavalca, 2020: 212).
«Que predicaba san Vicente Ferrer?» era la questione che Josep Maria de Garganta poneva in una memorabile relazione tenuta a Roma nel 1979 presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, e rispondeva con un rapido e completo elenco dei temi dottrinali e morali della predicazione di Ferrer, che in gran parte coincidono con gli argomenti comuni alla predicazione ‘nuova’ degli Ordini Mendicanti, e peraltro sottolineava la specifica preoccupazione ‘apostolica’ per le minoranze religiose, le comunità ebraiche e islamiche («la presencia de moros y judios»), 1così vive e importanti nella società contemporanea (De Garganta, 1980: 147). Lungo questa direttiva altri recenti studiosi, e in particolare alcuni autori di notevoli antologie della predicazione di Ferrer, hanno messo in rilievo la sua tendenza a rinnovare originalmente un sistema dottrinale e pastorale ereditato dalla cultura e dalla spiritualità domenicana, un complesso di argomenti già indicati sommariamente nelle Constitutiones dell’Ordine dei Predicatori e nel commento di Umberto di Romans (De Garganta, 1980: 148-149). Orientata dal versetto tematico suggerito dalla liturgia, la predicazione di san Vicente è «un cosmos perfectamente cerrado» che accoglie gli argomenti più diversi con sorprendente libertà (Ysern i Lagarda, 2015: 99). Egli ha per fine la divulgazione delle verità della fede opposta alla deriva delle pratiche magiche e superstiziose, l’educazione ai sacramenti (a cominciare dalla confessione) e alla preghiera; su questa base è costruito l’insegnamento propriamente morale, che riguarda a tutto campo la società del suo tempo negli aspetti pubblici e privati: dall’amministrazione della giustizia al commercio e al lavoro; dal comportamento sessuale al gioco, alla bestemmia. Tuttavia quello che può sembrare un repertorio comune alla predicazione dei Mendicanti è proposto con una straordinaria tensione spirituale, con una partecipazione attenta alle vicende politiche, con un’oratoria inimitabile che unisce l’abilità retorica, le doti di un giullare e l’uso della lingua parlata. In questo mio contributo vorrei mettere in rilievo, sia pur sommariamente e per campioni, l’intreccio di tradizione e innovazione nella architettura del sermone, nell’uso degli strumenti di lavoro, e nella drammatizzazione del racconto agiografico.
La predicazione è una delle forme più complesse e, per certi aspetti, più raffinate della retorica medievale, e se ne ha conferma dal corpus dei sermoni volgari e latini di Ferrer. Componente non trascurabile del suo successo è la cura esigente della parola in tutti i suoi aspetti, la sua «conciencia estilistica» (Ysern i Lagarda, 2015: 76). Non di rado egli richiama la necessità di preparare accuratamente il sermone, con l’atteggiamento del buon artista che si compiace dell’efficacia e della bellezza della sua parola, e prova a suo modo «una punta de satisfació literaria» (Fuster, 1975: 141). In un sermone inedito sulla «vera dilectio» - Audistis quia dictum est: Diligite inimicos vestros [Mt 5,43] - alla vanagloria che rovina le iniziative virtuose si contrappone l’ onesta soddisfazione di chi vede il felice compimento della propria iniziativa; in particolare del predicatore che prova «quoddam gaudium mentis et complacentia cordis» 2. In una predica sulla moltiplicazione dei pani - Colligite que superaverunt fragmenta (Io 6, 12) – uno dei pani è allegoricamente inteso come la «providencia intellectualis» della quale Cristo dà esempio chiedendo consiglio a Filippo, che pure è il meno acuto tra gli apostoli, «ut in dubiis non verecundemur petere consilium ab illis qui sciunt»; e ciò per ammonire i cattivi predicatori «qui nunquam studuerunt theologiam» e si vergognano di usare i sermonari preparati da altri, «ymo verecundantur studere in sermonibus aliorum vel petere auctoritatum declaraciones». 3
Читать дальше