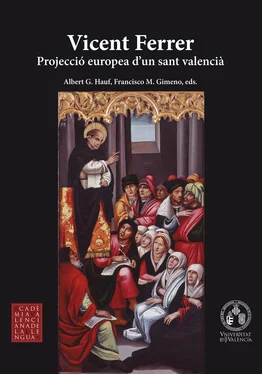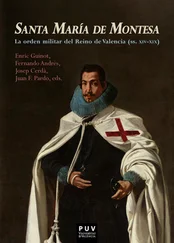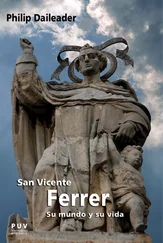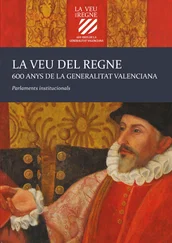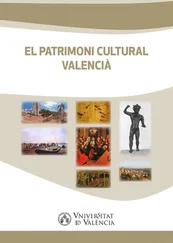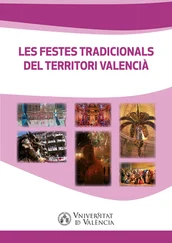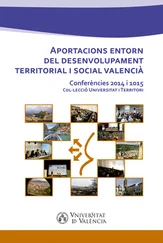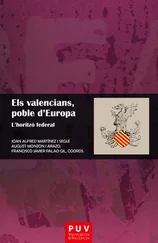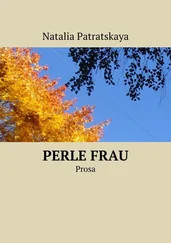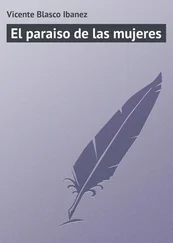Merita ricordare le variazioni introdotte nella redazione del medesimo sermone secondo la reportatio latina – un latino ampiamente mescidato col volgare - registrata nel codice di Ayora, un interessante caso di diffrazione della parola del predicatore, simile ad altri documentati dalle reportationes delle prediche di Bernardino da Siena (Delcorno, 2009). Nel prothema, regolarmente concluso dalla preghiera alla Vergine, si ricorda che san Giorgio soccorse i cristiani «in conquesta istius Regni tempore regis Iacobi bone memorie», si intende Giacomo I il Conquistatore (Ferrer, 1995: 380). La condanna dei moderni cavalieri è molto più insistita: «Non erat de militibus que sodegan les portes a les dones maridades et alias ara», anzi «emparabat mulieres iuvenes». Si direbbe che in questa redazione si presti particolare attenzione ai movimenti del drago. Mentre i due giovani scambiano le battute del concitato dialogo, il drago «elevavit caput» - particolare ripreso esattamente da Iacopo da Varazze, 1998: 393 («Dum hec loquerentur, ecce, draco veniens caput de lacu levavit») - e pensa: «pensavit inter se ‘Iste miles vult venire contra me’ « 22. Non vi sono dubbi sull’immediata uccisione del drago: «arripuit ensem et dedit sibi unum ictum taliter quod ipse occidit draconem». La principessa non solo desidera le nozze, ma chiede al padre di darle per marito il cavaliere, il quale però non viene meno alla sua verginità. «Quomodo fecissetis vos?»: così Ferrer interpella i cavalieri presenti al sermone, «Delibereretis eam de drachone stagni, sed devorassetis eam in peccato inmundicie» (Ferrer 1995: 383) Notevoli sono anche le variazioni che si notano nel sermone per san Giorgio presente nel famoso ciclo trasmesso dai codici della cattedrale di València (Ferrer, 1971-1988: VI 77-82, sermone CC), databile ai primi anni del secolo XV (Viera-Piqué 1996: 275). Il padre vuole che la principessa sia ornata riccamente di perle e di oro «molt gentilment», come se andasse a nozze («com si hagués ésser nòvia»): particolare che riprende il testo della Legenda aurea , e che viene abilmente utilizzato nel seguito del racconto. San Giorgio infatti, che cavalca «tot sols», vede la «donzella bella molt ben ornada» e si rivolge a lei con uno stile accentuatamente cortese, feudale. ‘Senyora’ è il titolo invariabilmente usato nel dialogo dopo l’iniziale ‘donzella’; non filia come si legge nella fonte latina. In questa versione di València san Giorgio smonta da cavallo e affronta il drago uccidendolo con una «gran lançada», non con la spada come nella citata predica del ciclo di Ayora. Inoltre è il re che vorrebbe dare la figlia come premio al cavaliere, il quale suggerisce di darla in sposa a Cristo, come di fatto avviene con la conversione e il battesimo della donzella e di tutta la città (ivi: 79). Più duro e diretto è il rimprovero rivolto ai cavalieri moderni, macchiati di lussuria:»Ara, vosaltres cavallers, què haguerìa feyt, que trobasseu axi tal donzella ornada? Que? Haguereu-la deshonrada axi com feu a d’altres, que no us studiau en aldre»; e conclude con un insulto: «Oo, traydors!». Se si legge il sermone modello raccolto nella collezione standard di Tolosa, base delle successive stampe, vi si trova una drastica riduzione dei dettagli e soprattutto dei dialoghi, quasi con un ritorno alle linee essenziali dell’originario schema fissato nel Sermonario di Perugia. Il testo è ridotto spesso a semplice didascalia per il predicatore: «Dicatur quomodo draco exivit de lacu et beatus Georgius signavit se signo sancte crucis et exivit contra eum quem percussit» (Ferrer, 1503: [g7vb]). Sono invece dilatate le osservazioni morali, ad esempio la tirata contro i vizi dei «moderni milites».
Vicent Ferrer è per tanti aspetti una «exception mès que una norma» (Catalán Casanova, 2013: 397), un evento unico che tuttavia condiziona lo svolgimento del sermone in Europa, soprattuttto nella penisola iberica, dove la storia della predicazione può essere distinta tra l’epoca che precede e quella che segue l’intervento carismatico del santo (Sanchez Sanchez, 2000: 804). L’originalità della sua parola, sia per quanto riguarda i temi, sia per i mezzi espressivi e per gli strumenti di lavoro è largamente debitrice alla esperienza secolare degli Ordini Mendicanti e soprattutto della scuola domenicana e all’esercizio vario, instancabile, della comunicazione adattata a un pubblico esigente e inquieto alla fine del Medioevo e negli anni di una crisi grave della cultura e della sensibilità religiosa.
BIBLIOGRAFIA CITATA
Aldobrandino da Toscanella, De Tempore (Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, Plut. XXXII sin 5).
Bataillon, Louis-Jacques (1992). «Les images dans les sermons du XIII esiècle» (1990), in Id, La prédication au XIII esiècle en France et en Italie. Études et documents , Aldershot, Variorum, XI, pp. 327-395.
Ben-Aryeh Debby, Nirit (2001), Renaissance Florence in the Rhetoric of Two Popular Preachers: Giovanni Dominici (1356-1419) and Bernardino da Siena (1380-1444) , Turnhout, Brepols.
Bériou, Nicole (1978), «La prédication au béguinage de Paris pendant l’année liturgique 1272-1273», Recherches augustiniennes , XIII, pp. 105-229.
Bériou, Nicole (1998), L’avènement des maîtres de la Parole. La prédication à Paris au XIII esiècle , Paris, Institut d’études augustiniennes, 1998.
Bériou Nicole-Hodel Bernard (2019), Saint Dominique de l’ordre des frères prêcheurs.Témoignages écrits fin XII e-XIV esiècle , Paris, Les Éditions du Cerf.
Bernardino da Siena (1979), La battaglia e il saccheggio del Paradiso cioè della Gerusalemme celeste . Introduzione e traduzione a cura di Franco Cardini, Siena,Cantagalli.
Bernardino da Siena (1950), Quadragesimale de christiana religione , in Opera omnia , studio et cura PP. Collegii S. Bonaventurae, Firenze, Ad Claras Aquas, 1950-1965, in 9 tomi, t. I- III.
Catalán Casanova, Oriol (2013), La predicació cristiana a la Catalunya baixmedieval . Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Historia, Departament d’Historia medieval, paleografia i diplomàtica. Tesi di dottorato (dir. Prof. Ignasi J. Baiges i Jardí).
Catedra, Pedro M. (1994), Sermón, sociedad y literatura en la Edad Media. San Vicente Ferrer en Castilla (1411-1412) , Valladolid, Junta de Castilla y Leon.
Cavalca, Domenico (2009), Vite dei Santi Padri , a cura di Carlo Delcorno, Firenze, Ed. del Galluzzo per la Fondazione Franceschini, 2 voll.
Charland, Thomas-Marie (1936), Artes Praedicandi. Contribution à l’histoire de la rhétorique au Moyen Âge, Paris, Vrin-Ottawa, Inst. d’études médiévales.
Colosio, Innocenzo (1970), «Il B. Giovanni Dominici come uomo, come scrittore e come maestro di vita spirituale specialmente religiosa», in Giovanni Dominici (+1419). Saggi e inediti ( Memorie Domenicane n.s. 1), pp. 9-48,
Daileader, Philip (2016), Saint Vincent Ferrer, His World and Life: Religion and Society in Late Medieval Europe , New York, Palgrave MacMillan.
De Fraja, Valeria (1999), «Usi politici della profezia gioachimita», Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento , 25, pp. 397-398.
De Garganta, Josep Maria (1980), «San Vicente Ferrer, predicador de penitencia y de reforma», in Agiografia nell’Occidente cristiano. Secoli XIII-XV (Roma, 1-2 marzo 1979), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, pp. 129-165.
Delcorno, Carlo (1975), Giordano da Pisa e l’antica predicazione volgare , Firenze, Olschki.
Delcorno, Carlo (1979), «Cavalca, Domenico», in Dizionario biografico degli italiani , XXII, Roma, Isitituto dell’Enciclopedia Italiana, pp. 577-586.
Читать дальше