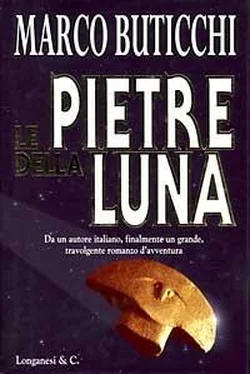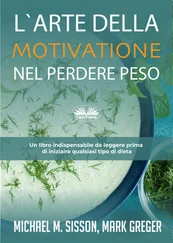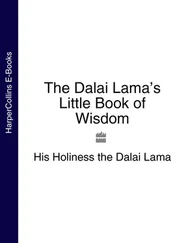Ancora una volta: ti amo per la vita.
Laura piegò i fogli, asciugandosi le lacrime. Quindi abbassò lo sguardo sul tavolino davanti al divano dov’era seduta, nella residenza abituale di Kevin. Il pacco di antichi fogli, ridotto a un unico grosso grumo di impasti apparentemente inestricabili, era lì. Ce lo aveva posato lei ormai da diversi giorni.
D’impulso, sollevò la cornetta del telefono e digitò il numero di Oswald Breil. Era l’unica persona a cui, in quel momento, si sentiva di chiedere conforto e aiuto.
Kevin aiutò l’anziano scienziato a indossare la tuta spaziale e a mettersi in spalla il voluminoso zaino contenente la riserva d’aria e i razzi direzionali. Per fortuna si trovavano in assenza di gravità: sulla Terra, quel fardello sarebbe pesato più di ottanta chili.
Il portello della cabina pressurizzata si aprì. I due astronauti furono investiti dalla pressione, e dopo qualche istante si trovarono sospesi nello spazio infinito. Greg stava cercando di prendere dimestichezza con i due booster necessari per muoversi nello spazio. Si esibì in una mezza capriola, quindi sbandò una prima volta sulla sinistra e poi a destra, finché, con qualche sforzo, non riuscì a riprendere il controllo.
«Alla fine di quest’avventura», commentò rompendo il silenzio radio, «se sulla Terra sarà rimasto qualcuno in grado di stampare il Guinness dei primati, prenoto fin da adesso una pagina intera.»
Per tutta risposta Kevin scosse la testa protetta dal casco spaziale, portandosi faticosamente l’indice alla tempia e ruotandolo un paio di volte.
Le diciotto testate russe erano allineate in un angolo della stiva, assicurate al pavimento con cinghie e reti d’acciaio. Erano di una lega metallica lucida, su cui risaltava il simbolo giallo e nero, d’identificazione del materiale radioattivo.
Kevin si stupì che oggetti così piccoli potessero racchiudere una simile potenzialità distruttiva. Greg, che li conosceva perfettamente, si mise al lavoro senza indugi. Un solo minuto perso avrebbe potuto significare la catastrofe.
Aperta la testa del razzo vettore, Dimarzio rimase interdetto di fronte al groviglio di fili elettrici che vide dipanarsi tra le ogive già collocate al loro posto. Con estrema cautela e pazienza, le mani dello scienziato, protette dai guanti, stavano già seguendo lentamente a uno a uno i contatti, dal punto in cui il filo usciva da una testata fino a quello in cui rientrava nel sistema elettronico d’innesco di un’altra.
Improvvisamente alzò la testa. Se il vetro del casco non fosse stato a specchio per resistere ai raggi cosmici, Kevin avrebbe potuto vedere la soddisfazione che gli brillava negli occhi.
«Hanno fatto davvero un ottimo lavoro, quei poveretti», lo informò via radio Greg Bender. «Ci resta soltanto il compito di portarlo a termine.»
Quattro ore più tardi videro la Terra, che da quella quota sembrava una grossa palla variopinta da spiaggia. Le perturbazioni coprivano interi continenti con un manto ovattato. Gli oceani sembravano laghi di un colore blu intenso.
«Credo non sia ancora giunta la tua ultima ora, vecchia mia!» esclamò Bender, risigillando la testata del razzo vettore.
«Capcom a Houston. Capcom a Houston», chiamò il comandante, chino ancora una volta sul microfono, appena furono rientrati a bordo.
«Qui Houston. Avanti, colonnello.»
«Abbiamo seri problemi e una capacità detonante molto ridotta, ma pensiamo di farcela. Il sistema idraulico di chiusura dei portelloni della stiva è danneggiato. Non abbiamo tempo per un tentativo di riparazione. Dirigiamo verso l’incontro.»
E, data l’informazione, Kevin accese i razzi principali onde avere una spinta maggiore per allontanarsi ulteriormente dall’orbita terrestre. Manovrare la navetta in quelle condizioni creava qualche difficoltà, ma l’assenza di atmosfera facilitava i problemi aerodinamici della navicella spaziale.
Vista da quella distanza, la luna perdeva gran parte del suo fascino argenteo. Era una distesa brulla e grigiastra, disseminata di crateri che rompevano qua e là la monotonia delle pianure sconfinate.
«Dieci minuti alla finestra», annunciò Greg, scandendo il tempo.
«Otto minuti alla finestra», continuò dopo un po’. «Processo di innesco elettronico attivato.»
L’asteroide Speitz-42 spuntò finalmente da dietro il satellite. Illuminato dai raggi del sole, il suo colore rosso acceso risultava ancora più vivo. In pochissimo tempo attraversò completamente l’orizzonte lunare.
«Fuori il razzo vettore!» disse Kevin, ripetendo a voce alta i comandi che stava eseguendo, mentre Greg continuava a scandire il tempo.
«Sei minuti alla finestra.»
«Cristo, Greg, il braccio meccanico non si muove. Non riesco a sbalzare il vettore fuori della stiva.»
«Prova ancora, Kevin! Prova! Quattro minuti alla finestra…»
«Non vuole saperne, Greg, è bloccato!»
«Tre minuti alla finestra», continuò imperturbabile Bender.
La lenta rotazione dell’asteroide stava per mostrare loro il grande cratere in cui avrebbero dovuto far arrivare il razzo. Kevin tentò un’ultima volta di azionare il meccanismo indispensabile per il lancio.
«Non c’è niente da fare, Greg. I meteoriti l’hanno danneggiato. Non c’è niente da fare», ripeté in tono sconsolato.
«Due minuti alla finestra.»
Ormai il cratere era davanti a loro.
Kevin cominciò a ripetere le procedure d’emergenza ad alta voce, mentre le sue mani si muovevano esperte tra i comandi.
«Procedura di eiezione capsula iniziata. Contatti inseriti, sicure rimosse…»
Bender seguì con espressione impassibile i movimenti rapidi e precisi delle dita di Kevin sui comandi. Capì che le procedure di espulsione della capsula erano terminate quando vide il colonnello togliere le tre antiche statuette d’oro dal cruscotto e infilarle nella piccola borsa che si era già agganciato alla vita.
Pochi attimi più tardi il cono di roccia sembrò inghiottire la navicella imbottita di cinquecentotrenta chilogrammi di esplosivo nucleare. Tutto avvenne nella frazione di pochi secondi. Un immenso bagliore illuminò i silenzi dello spazio.
Alla base di Houston un liberatorio urlo di gioia salutò la deviazione dell’asteroide. Presi da un’emozione irrefrenabile, i tecnici si abbandonarono a scomposte manifestazioni di entusiasmo, del tutto estranee alle loro abitudini di compassata imperturbabilità. Chi si abbracciava, chi rideva istericamente, chi batteva le mani, chi gettava in aria il berretto di ordinanza.
Per qualche istante tutti trascurarono il fatto che dallo spazio non arrivava più nessun segnale umano.
Dopo i pochi attimi di follia collettiva, recuperata la calma in un silenzio di tomba, i presenti presero atto con espressioni di cupo imbarazzo che la salvezza della Terra era costata il sacrificio di altri due eroi.
Gli strumenti, intanto, continuavano implacabili a ticchettare e lampeggiare le loro informazioni.
Lima. Perù. Primavera 1623.
Se fosse avvenuto soltanto alcuni mesi prima, il matrimonio di Maria Antonia Llobet sarebbe sicuramente stato celebrato con ben diverso sfarzo e sfoggio di ricchezza. I notabili della città non riuscivano a capacitarsi dell’improvviso stato di scarse disponibilità in cui sembrava essere precipitato uno degli uomini più ricchi delle Americhe.
Ma, purtroppo, per ripianare l’esposizione verso la Banca Centrale di Spagna, Llobet era stato costretto a vendere gran parte dei suoi possedimenti. Ormai era un benestante come tanti altri, lontanissimo da ciò che era stato un tempo. Ma una nuova ricchezza aveva illuminato la sua vita: quella di una serena felicità.
Vasted uscì raggiante dalla chiesa, in alta uniforme di ufficiale dell’Armada. Felice, si concesse alle congratulazioni dei presenti abbracciando la bellissima sposa. La tremenda avventura che avevano vissuto non aveva lasciato segni nelle loro giovani menti. Aveva, caso mai, arricchito e cementato i loro sentimenti. Adesso li aspettava la vita.
Читать дальше