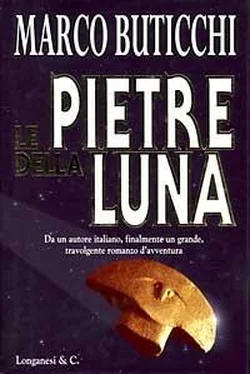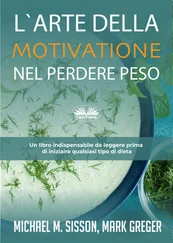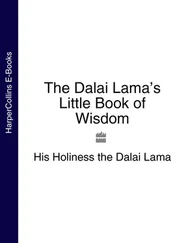Marco Buticchi
Le pietre della Luna
A Mel Fisher, al suo coraggio, alla sua perseveranza. A chi ancora crede che, dove finisce un arcobaleno, si possa scoprire una pentola piena d’oro.
Roma. Maggio 1996.
La primavera piena stendeva sulla città il meglio della sua tavolozza cromatica. Gialli dorati, cremisi stemperati, verdi brillanti. Nelle strade il clima era caldissimo. Tra la folla non particolarmente frettolosa si vedeva più di una persona tergersi il sudore dalla fronte e rivolgere uno sguardo al cielo, più perplessa che implorante. Quando finirà questo tormento? sembravano chiedere. Figurarsi, sembravano aggiungere, l’estate è ancora di là da venire. Ma lo spirito filosofico del carattere romano prevaleva immancabilmente. Il caldo sarebbe passato e finito, sarebbe arrivato l’inverno, e le lamentele sarebbero state di altro tenore. Anche quel caldo, in fondo, era mandato da Dio, il Dio temporaneamente in carica, uno dei tanti che avevano presieduto il cielo e le sorti di Roma nei suoi ben più che duemila anni di storia.
Comunque, maledizione, faceva un gran caldo.
Non, però, dietro le grandi finestre azzurrate di un terzo piano, nel quartiere dell’EUR. Un ufficio come tanti altri, apparentemente: il distaccamento di un ministero, un ente governativo, il centro studi di una banca, la sede di una multinazionale. Chi sollevava lo sguardo al cielo non aveva certamente né tempo né soprattutto motivo di soffermarsi su quelle finestre. Un po’ diverse dall’usuale, certo, ma se i romani dovessero meravigliarsi delle cose inusuali che ha loro riservato la storia, dovrebbero cominciare a farlo nei primi istanti della vita e continuare fino agli ultimissimi.
Lassù, dietro quelle finestre azzurrate, avevano semplicemente sede gli uffici di un centro studi. Un centro molto particolare, finanziato con fondi internazionali e creato al fine di cercar di decifrare i reperti archeologici dell’antica Roma, in qualsiasi forma essi fossero.
Dietro due di queste finestre, in particolare, una giovane studiosa era al lavoro davanti al grande monitor di un computer, diviso in tre settori (due vaste fasce verticali e una orizzontale, larga e bassa) e collegato a un’apparecchiatura che a un occhio profano sarebbe potuta sembrare una fotocopiatrice. Un po’ strana, certo, con un’arcana serie di luci, lucette e lucine che baluginavano o scorrevano su piccoli schermi oblunghi. Tasti, pulsanti, levette. Cavi, cavetti, fili.
In realtà non era affatto una fotocopiatrice, ma un sofisticatissimo esemplare di scanner scientifico — di cui erano equipaggiati non più di venti centri di ricerca in tutto il mondo -, realizzato attraverso una complessa combinazione di luce ultravioletta, radiazione infrarossa, beta-radiografia e raggi laser, in grado di leggere e trasferire in chiaro sullo schermo del computer il contenuto invisibile di certi antichi rotoli o fogli che un’altrettanto sofisticata apparecchiatura separava, scollava e restaurava prima che venissero fatti scorrere sul ripiano di cristallo dello scanner. Su di esso erano stati letti e interpretati decine di testi e documenti antichi, in forma di papiro, di pergamena, di tessuto, di cera o altro. Redatti in latino, in greco antico, in egizio, in aramaico, in siriaco. In tante altre lingue e alfabeti.
Questa volta, però, la sofisticata macchina non era alle prese con niente di tutto ciò. Stava leggendo comune carta. Ma una carta grossa, povera, friabile e sul punto di andare in polvere. Quando si era trovata davanti il suo impasto legnoso, la giovane studiosa aveva rischiato di scoraggiarsi.
Le pagine, in uno stato pietoso, erano così amalgamate tra loro da far temere che non sarebbe mai stato possibile separarle. Le muffe avevano avuto il sopravvento sui labili inchiostri vegetali.
Ma Sara Terracini non si era persa d’animo, non era nel suo carattere. Aveva immediatamente chiamato con il telefono interno il più prezioso dei suoi collaboratori, Toni Marradesi. Tra il fango dell’alluvione di Firenze, da giovanissimo volontario, aveva saputo risolvere situazioni persino peggiori. E da allora la tecnologia aveva fatto passi da gigante. Lo stanziamento di fondi da parte del programma comunitario Laser Analysis and Restoration of Art aveva consentito al laboratorio in cui operava insieme a Sara di essere all’avanguardia nel mondo.
Sara gli aveva spiegato la situazione in poche parole. Dopo alcuni minuti il non più giovanissimo — anche se ancora quasi volontario, in termini di retribuzione — Toni era già al lavoro, operando con la freddezza di un chirurgo. Aveva rimosso i resti di legatura, recidendo i fili, e proceduto a una prima separazione dei blocchi di pagine ovunque era possibile. Quindi, prelevato un campione microscopico di carta, lo aveva inserito nell’analizzatore automatico di aminoacidi. Il responso della macchina lo avrebbe messo in condizione di stabilire il grado di corrosione per il bagno di separazione.
Sara lo aveva lasciato al suo lavoro, sicura di avere messo nelle mani migliori il preoccupante regalo mandatole dal suo vecchio amico Oswald Breil. Era tornata al suo posto di lavoro, in attesa di un messaggio di Toni.
Rimasto solo nel suo antro di stregone del restauro, Marradesi aveva eseguito una spettroscopia di fluorescenza sui blocchi di pagine incollate. La stessa tecnica usata per «vedere», sotto un dipinto, eventuali disegni preparatori o ripensamenti dell’artista. Lo schermo si era illuminato, rivelando segreti che nessuna radiografia di tipo tradizionale avrebbe potuto scoprire. Con aria soddisfatta si era alzato dal trespolo dove aveva l’abitudine di appollaiarsi come Eta Beta e si era messo ad armeggiare con alcune provette e con acqua distillata. Aveva incrociato le dita e immerso il primo dei gruppi di pagine nella soluzione.
Aveva scandito il tempo secondo per secondo, osservando il cronometro, e finalmente aveva estratto il blocco di fogli. Aveva controllato la temperatura del forno a conversione e regolato l’umidità. Poteva soltanto sperare, alla stessa stregua di un medico dopo un intervento rischioso.
Ma finalmente aveva potuto posare sul suo tavolo le prime pagine ingiallite, staccate le une dalle altre, seppure ancora illeggibili. Ci avrebbe pensato Sara. Adesso toccava a lei. Era salito di persona a portarle i primi risultati del suo lavoro.
Sottoposta a vicende sicuramente tormentose, per quanto ormai non più note a nessuno, quella carta sembrava non voler concedere al comune occhio umano niente di ciò che su di essa era stato puntigliosamente scritto al fine di tramandarlo ai posteri. Aveva sofferto sole e tempesta, acqua e aria, sale e sabbia.
Soltanto la rara macchina da svariate decine di migliaia di dollari, gestita con precisione chirurgica da Sara Terracini, avrebbe forse potuto penetrare nel suo segreto. Forse. Dopo tre giorni di lavoro, infatti, il dubbio restava. Fino a quel momento, nonostante l’ostinato impegno della giovane studiosa, l’antica carta non aveva voluto concedere assolutamente niente nemmeno a quella macchina avveniristica.
Ma Sara non desisteva. Aveva affrontato ben altre imprese. E di ben altra difficoltà sarebbe stato l’incarico affidatole se, invece di dover interpretare quei fogli scritti a mano, le fosse stato chiesto di decifrare i ben più antichi rotoli, purtroppo perduti, di cui, secondo Breil, essi erano probabilmente una prima trascrizione.
Sommessi ronzii e bip elettronici turbavano appena il silenzio. La giovane studiosa era una donna di incisiva bellezza — capelli corvini su un sano colorito bruno, naso aquilino, brucianti occhi neri -: per strada non capitava di rado che un uomo si voltasse a seguirla con sguardo ammirato. Un’attrice degli studi televisivi di Saxa Rubra, una modella delle annuali sfilate di moda, pensavano. Certo, non conoscendola, era difficile pensare che si trattasse di una scienziata di grande rigore e professionalità. Se in quel momento Sara aveva caldo, non era certamente per il clima esterno. Dal suo laboratorio, caldo e umidità erano rigorosamente banditi.
Читать дальше