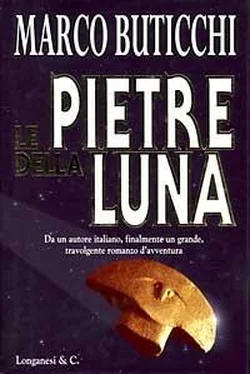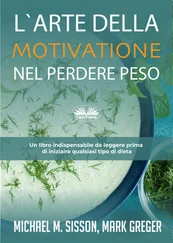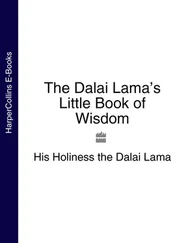Erano ormai nello spazio da otto giorni, e si erano concessi veramente poche pause. La stanchezza cominciava a farsi sentire per tutti. Tranne, apparentemente, per l’anziano scienziato, che riusciva a non perdere mai il buon umore ed era sempre pronto alla battuta scherzosa, se non addirittura goliardica, e alla parola di conforto, accompagnandole alla profondità di un’esperienza che si stava rivelando sempre più preziosa.
Finalmente, il computer di bordo guidò la navicella accanto alla prima rampa sovietica. Sebbene il concetto ispiratore della struttura fosse il medesimo, l’aspetto della batteria spaziale era molto diverso da quello dei «Post-Boost» americani.
Gregory Bender rivolse un paterno sorriso di incoraggiamento al giovane russo: «Adesso siamo nelle tue mani, Yuri», disse. «Senza di te, non sapremmo assolutamente che cosa fare. Buon lavoro!»
Aveva appena finito di parlare che già il tecnico si esibiva in una perfetta capriola in assenza di gravità, dopo di che volò letteralmente fino al locale di vestizione, calandosi dentro l’unico indumento in grado di farlo sopravvivere all’esterno della navicella.
Era trascorsa una mezz’ora circa, quando la voce di Yuri gracchiò nel microfono con il suo inconfondibile accento russo: «C’è un problema, comandante Dimarzio».
«Che cosa succede, Yuri?» chiese Kevin, inquieto.
«Forse dipende dalla scarsa manutenzione del reattore nucleare che assicura la propulsione della stazione orbitale con a bordo le testate atomiche.»
«Scusa, Kevin», si inserì in linea la voce di Bender. «Hai misurato la radioattività, Yuri? Controllala di nuovo con la massima attenzione.»
Gli attimi di silenzio che seguirono riempirono Bender e Kevin di profonda ansia. Spinto dall’entusiasmo, il giovane russo aveva forse trascurato di tenere sotto controllo il contatore Geiger inserito nella tuta. Il timore fu purtroppo confermato dalla voce di Yuri, che tornò finalmente a farsi sentire dicendo:
«Cristo! Qui dentro sembra di essere nel centro di Nagasaki il giorno dopo lo scoppio!»
«Via, Yuri, via subito! Lascia stare tutto e allontanati da lì», ordinò immediatamente Bender. «E, rientrando, passa per il locale di decontaminazione, mi raccomando.»
L’operazione complessiva avrebbe richiesto alcune ore, prima che il giovane russo potesse tornare nella zona comune pressurizzata. Kevin e Bender le trascorsero in preda a una profonda ansia.
«Le tute in dotazione riescono a schermare una modesta contaminazione radioattiva. Il ragazzo potrebbe cavarsela», disse il comandante della missione, aggrappandosi a un filo di speranza.
«Yuri ha lavorato troppo tempo in presenza di una radioattività molto elevata», replicò lo scienziato scuotendo la testa. «Temo che ci siano poche speranze. Prepariamoci al peggio.»
La previsione, purtroppo, si rivelò tragicamente giusta. Yuri rientrò nella stanza comune con la polo blu che faceva parte della loro divisa nei momenti di pausa. Sembrava un turista dalla carnagione lattea che si fosse steso per un’intera giornata al sole dei tropici. Cominciò presto ad accusare un forte malessere, mentre le chiazze rosse si gonfiavano come vesciche.
Bender gli somministrò un po’ di iodio e una fiala di morfina, le uniche sostanze presenti nell’infermeria di bordo che potessero essere di qualche utilità in quella situazione imprevedibile, quindi si ritirò al tavolo del carteggio, dove s’immerse in calcoli, dovendo per giunta contrastare la difficoltà di tenere ferme penne e matite, che continuavano a librarsi nell’aria.
Circa un’ora più tardi raggiunse Kevin. «Ho riformulato tutti i calcoli», disse, «azzerando ogni tolleranza in eccesso. Penso che potremmo farcela anche senza quelle testate, ma ci occorrono assolutamente le ogive dell’altra stazione sovietica.»
«Abbiamo osservato Yuri da lontano, mentre operava per smontare i missili», interloquì il tecnico di testate americano. «Forse ho capito qualcosa, anche se non garantisco la riuscita.»
«Posso uscire anch’io a dare una mano. Tu, Kevin, sei perfettamente in grado di tenere in rotta questo aggeggio anche senza il mio aiuto», intervenne immediatamente il copilota.
Mezz’ora più tardi affiancavano l’ultima delle stazioni orbitali.
A terra, Laura leggeva e rileggeva la lettera di Kevin con la stessa emozione della prima volta.
Vedi, Laura, ci sono cose troppo gravi, di fronte alle quali anche il coraggio e l’amore per la verità possono vacillare. Spesso è il danaro a convincere gli uomini a compiere azioni aberranti, altre volte è il potere a farli cadere in trappole fatali. Questa mia scorza fredda e scostante, credimi, dipende dal fatto che soffro da anni e anni per mantenere il segreto su un crimine della storia o, meglio, sul contributo che mio padre ha dato per salvare il più grande assassino di massa del nostro secolo.
Io appartengo per discendenza a un’associazione segreta a numero chiuso, costituita tra tutti coloro che hanno partecipato a una sciagurata missione.
Il giorno prima che i russi prendessero Berlino, in una località nei pressi della costa tedesca Adolf Hitler salì su un aereo pilotato da mio padre. La mattina seguente il Führer sbarcava sano e salvo negli Stati Uniti d’America. Tutto questo non per un’adesione ideologica o politica, ma semplicemente per danaro, una quantità enorme, con cui la mente organizzatrice dell’operazione ha saputo tappare la bocca ai suoi complici.
Tutti noi, primogeniti dei responsabili dell’operazione, divenuti a nostra volta automaticamente membri dell’associazione, siamo vincolati al silenzio da un patto mortale. Ma non è per questo che ho taciuto in tutti questi anni. Se l’ho fatto, è stato soltanto per non vedere il mio nome macchiato, nonostante la rettitudine a cui ho sempre voluto improntare la mia vita.
Ma ormai, credimi, non ce la faccio davvero più. Non ho mai avuto ambizioni di ricchezza: quanto guadagno onestamente con il mio lavoro è sempre stato sufficiente per i miei bisogni. Prova ne sia che non ho mai attinto un solo centesimo dal conto a me intestato presso una banca svizzera. Ma sono stanco, amore mio, e non sai quanto sollievo io trovi semplicemente nello svelarti questo segreto.
Greg Bender era salito nella cabina di pilotaggio e aveva preso posto nel sedile sulla destra di Kevin. Le tre statuette emanavano raggi rosso dorati dal cruscotto, sul cui piano erano assicurate con alcuni elastici che impedivano loro di librarsi nell’aria. Lo scienziato non ci fece caso; le aveva già viste, ma riteneva si trattasse di amuleti che il colonnello amava portare con sé a fini scaramantici.
Dimarzio manovrava manualmente i razzi laterali per tenere in assetto il velivolo. Il braccio meccanico si mosse dall’interno della stiva e riuscì ad agganciare la rampa sovietica al primo tentativo. Erano capovolti rispetto alla Terra e viaggiavano a una velocità superiore ai ventottomila chilometri orari. Dopo il tempo necessario per rimuovere gli schermi protettivi, l’artificiere annunciò nel microfono: «Qui le cose vanno bene. Nessun segnale del contatore né durante l’avvicinamento né nelle immediate prossimità. Tutto è in ottime condizioni e non si riscontrano tracce di radioattività neanche all’interno della struttura».
Era toccato a Bender il compito di collegare i centri vitali di Yuri al sistema di monitoraggio in contatto con la base a Terra. Lo sfortunato giovane russo era in coma da diverse ore.
«Houston a Capcom, Houston a Capcom. Allarme. Allarme. Problemi per il ferito. Le apparecchiature segnalano una crisi cardiocircolatoria», si sentì annunciare concitatamente dal sistema di comunicazione interno.
Kevin lasciò i comandi e si tuffò di slancio nel passaggio che portava al piano inferiore. Trovò Yuri in preda a nausea e vomito, con il corpo ridotto a un’unica ustione. Poi lo vide inspirare più a lungo del solito, e infine reclinare la testa, paralizzato. Era morto, mentre il suo comandante, impacciato per l’assenza di gravità, cercava inutilmente di praticargli un massaggio cardiaco. Il fisico di Yuri, già debilitato, cedette molto prima di quanto normalmente avvenga in analoghe circostanze.
Читать дальше