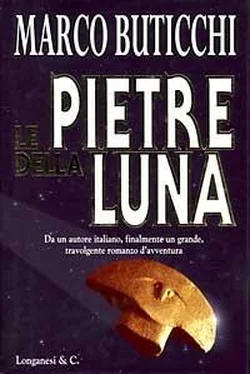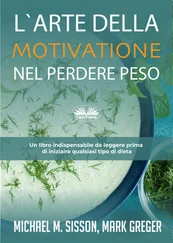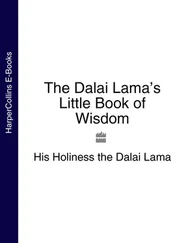«Non soltanto: anche la figura di Publio Marzio, integerrimo comandante delle legioni e senatore, è stata più volte infangata da accuse infamanti. E soltanto la rettitudine dell’uomo di cui vi parlavo ha tentato di opporsi alle trame dei suoi nemici.
«Quest’uomo è presente tra voi e lo conoscete tutti. In anni non ancora lontani, lo avete gratificato della più appassionata ammirazione. Vi chiedo di rinnovarla. Il suo nome, sebbene io dubiti sia necessario ricordarvelo, è Giunio di Luna.
«Ebbene, al cospetto del popolo di Roma chiedo che vengano rispettate le volontà testamentarie di mio cugino Publio Marzio. Vieni avanti, Giunio. Ti nomino erede unico di quello che è stato il tuo grande protettore e al tempo stesso il tuo protetto. In nome di Roma ti attribuisco il suo nome e ti reintegro nel grado di alto ufficiale. Il tuo coraggio ha saputo innescare il meccanismo, troppo a lungo represso, della giusta rivolta contro i tiranni. La tua valentia e il tuo coraggio ci hanno liberato dal più indegno dei potenti.»
Ancora una volta l’urlo della folla si levò alto a scandire il suo nome. Giunio si avvicinò al nuovo imperatore nello stesso momento in cui l’Augusto si voltava verso uno schiavo che reggeva sulle braccia tese un drappo di porpora.
«So», riprese Nerva, «che queste statue appartengono a te e alla tua famiglia, tribuno Giunio. È giusto che ti vengano rese.»
Giunio afferrò letteralmente le Pietre della Luna dalle sue mani, sentendosi invadere da un irrefrenabile tremito di emozione. L’oro rosso rifletteva i raggi del sole. Alzò le stele al cielo in segno di ringraziamento agli dei per avere posto termine al suo incubo.
«C’è bisogno di te, Giunio Marzio», concluse l’imperatore. «La tua presenza non potrà che essere d’esempio al senato di Roma.»
Cape Canaveral. Florida. Kennedy Space Center.
2 maggio 1996.
Kevin Dimarzio era ai comandi nella cabina di pilotaggio. La voce gli giungeva forte e chiara nella cuffia del casco: «Meno tre. Due. Uno. Lancio!» Si sentì comprimere dalla pressione contro il sedile, mentre lo Shuttle si alzava da terra in una nuvola di fumo. Dopo qualche istante disse nel microfono: «Capcom a Controllo Missione di Houston, qui tutto bene, chiedo conferma dei seguenti dati: peso al decollo 4,5 milioni di libbre; potenza di spinta al momento del decollo 6,5 milioni di libbre; consumo dei combustibili al minuto sessantaquattromila galloni».
«Qui Houston», arrivò immediata la risposta. «Dati corretti. Siete pronti per lo sgancio degli SRB?» Dopo qualche altro istante i due razzi a combustibile solido, ormai inutili, si sganciarono dai fianchi della navicella.
«Capcom a Houston. Controllo della velocità. Stiamo viaggiando a seimilacinquecento piedi al secondo?» chiese ancora Kevin dopo poco più di tre minuti. «Chiedo conferma.»
«Affermativo, Capcom. Vi siete liberati del peso dei razzi ausiliari e sentite sempre meno la gravità. Siete a 51 miglia nautiche di altitudine, a una velocità quasi sei volte superiore a quella del suono.»
Laura Joanson, nel soggiorno della villetta, aveva acceso il televisore con molto anticipo sull’inizio della diretta. Come un’infinità di altre persone in tutto il mondo, aveva assistito al decollo dello Shutde davanti al video. Ma tra lei e l’anonima folla dei telespettatori c’era una differenza fondamentale. Conosceva il vero scopo di quella missione, che al resto del mondo era invece stato tenuto nascosto, nel timore che potessero esplodere ingovernabili manifestazioni di panico.
Il campanello della porta d’ingresso squillò nello stesso istante in cui le telecamere non riuscirono più a seguire la navicella spaziale.
Aprendo, Laura si vide davanti sull’attenti un capitano della Air Force, che, senza mai abbandonare la rigida posizione marziale, le porse una lettera, dicendo: «Il colonnello Dimarzio mi ha ordinato di consegnarle questo, dottoressa Joanson, immediatamente dopo il decollo».
Non disse altro. Battuti rumorosamente i tacchi e fatto il saluto militare, scomparve.
La voce di Kevin continuava a raggiungere regolarmente la base di controllo: «Capcom a Houston. Orbita raggiunta. Motore principale spento. Vi stiamo girando attorno a quasi diciassettemila miglia all’ora.
«Da qui sembrate fermi», continuò il comandante in tono scherzoso.
«Tra diciotto minuti cominciamo i Bus Stop.»
«Bene, Capcom, ricevuto», fu la risposta che arrivò da terra.
La scherzosa espressione «Bus Stop» era stata coniata dal professor Bender in uno dei suoi frequenti momenti di humour adolescente, per indicare le diverse soste che lo Shuttle avrebbe dovuto compiere per il prelevamento delle testate nucleari dalle stazioni missilistiche in orbita.
La manovra di avvicinamento alla prima non fu complessa. Non appena la navicella si fu messa su un’orbita parallela a quella della stazione missilistica, Kevin azionò i comandi per aprire la stiva. Intanto gli uomini stavano indossando le tute pressurizzate. La fusoliera della navicella si aprì esattamente al centro. Il tecnico di bordo fu il primo a uscire nello spazio, mettendosi ai comandi esterni del braccio retrattile di oltre quindici metri.
Agganciata la stazione orbitante con la lunga proboscide, fu poi il turno dei tecnici di testate nucleari. Nella cabina di pilotaggio e dagli oblò laterali, Kevin, Bender e il copilota seguivano con spasmodica attenzione le operazioni. La rampa delle testate nucleari sembrava un tronco cilindrico del diametro di diciotto metri. Al suo interno erano disposti i missili, protetti da una schermatura in grado di resistere a pressioni altissime e calori insopportabili.
Con profondo sollievo, mentre dal suo posto seguiva l’andirivieni degli uomini nello spazio, Kevin dovette riconoscere che, nonostante la specifica preparazione dei tecnici, i consigli di Greg Bender erano davvero preziosi. Dopo undici ore di lavoro ininterrotto, le ogive erano stivate nella fusoliera dello Shuttle. Soltanto in un secondo momento i tecnici avrebbero provveduto a disporre le testate all’interno del razzo vettore cinese, anch’esso disposto longitudinalmente nella stiva.
Lontana miglia e miglia di vuoto, Laura Joanson stava leggendo e rileggendo la lettera di Kevin. L’aveva aperta immediatamente. A mano a mano che scorreva i fogli scritti di suo pugno da Kevin Dimarzio, aveva sentito il bisogno di sedersi e concentrarsi nella lettura.
Cape Canaveral, 1° maggio 1996
Mia carissima,
non so, visto il lavoro che hai svolto a contatto con i servizi di informazione, quanto tu abbia avuto occasione di venir a sapere sulla mia persona e sul mio passato. Quando leggerai queste righe, sarò in viaggio nella notte dello spazio. Esattamente quello che desidero per le cose personalissime che devo dirti. Consentimi però, anzitutto, la premessa che, all’età di quarantacinque anni, mi sono innamorato per la prima volta in vita mia. Ho sempre voluto imputare la mia vita di scapolo a una sorta di ribellione nei confronti di qualsiasi legame, ma sapevo benissimo che in realtà era dovuta al mio carattere aspro e chiuso.
Ogni volta che mi sentivo troppo legato a una donna, facevo i bagagli e scappavo. Un brutto carattere, certo, ma determinato da che cosa?
Sta di fatto che, se appaio così chiuso e scostante, è perché non ho mai avuto il coraggio di confessare una sorta di peccato originale, che mi pesa addosso con la forza di una fatalità.
Quanto sto per dirti non l’ho mai confessato a nessuno e ti prego di non rivelarlo, a tua volta, ad anima viva. Mi fido di te. Come non potrei, amore mio?
Intanto, nello spazio, i risultati del lavoro miglioravano a mano a mano che Kevin e i suoi uomini procedevano nell’affiancamento delle stazioni americane, al punto che dall’ultima stazione orbitante riuscirono a estrarre tutte le trenta testate nucleari in meno di sei ore e quaranta minuti, compresi gli indispensabili intervalli. Una volta richiusa la stiva e ripressurizzata la cabina, il compito dei tecnici continuava con l’inserimento delle ogive nell’ampio scomparto ricavato nella testata del missile. Per affrontare la parte veramente operativa della missione, mancavano ormai soltanto le due «fermate di autobus» presso le stazioni ex sovietiche.
Читать дальше