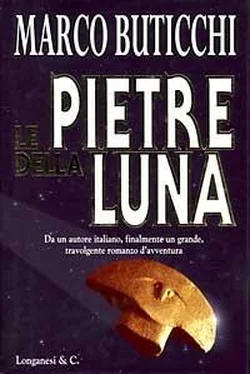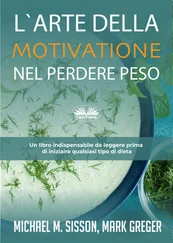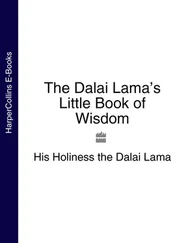Clelia gli appoggiò il capo sulla spalla. Gli passò la mano morbida tra i capelli e accostò le labbra alle sue: «Dio ti protegga, marito. Sarò qui con i nostri figli ad aspettare il tuo ritorno».
Lui la strinse appassionatamente a sé, fino a quando non furono le piccole mani di Marzio a separarli. «Dove vai, padre?» chiese nella sua innocenza.
Giunio rispose la prima cosa che gli venne in mente: «Devo uscire a pesca, sarò di ritorno tra pochi giorni».
«Portami con te, ti prego», implorò il bambino.
«Non posso, piccolo», rispose lui. «È una pesca pericolosa, adatta soltanto agli uomini grandi.»
«Ma io sono grande», replicò prontamente Marzio, indicando la spada di legno che portava al fianco. Ma per fortuna si lasciò convincere di buon grado a rinunciare.
La piccola nave si allontanò dal lato dell’isola opposto a quello dov’era ormeggiata l’oneraria. Arrivati abbastanza lontani da essere sicuri di non essere visti, virarono verso Ostia.
Cape Canaveral. Florida. Kennedy Space Center.
Gennaio 1996.
Greg Bender amava recitare — e recitava bene — il personaggio dell’insegnante affabile. E Laura e Kevin non si stancavano mai delle sue battute e della semplicità degli esempi con cui sapeva illustrare qualsiasi concetto, anche il più complesso.
«Sapete che cosa ho risposto a un giornalista che mi chiedeva come pensavo si potesse scongiurare una catastrofe cosmica sul tipo di quella che ci preoccupa?» chiese l’anziano scienziato, calamitando ancora una volta la loro attenzione.
«Bastano cento milioni di dollari», gli ho detto. «Il necessario per realizzare un ordigno nucleare ottocento volte più potente di quello di Hiroshima, in grado di disintegrare i corpi celesti più piccoli o di deviare la rotta di quelli più grossi.»
«Domanda!» interloquì Laura, alzando scherzosamente una mano come una scolaretta. «Come facciamo a realizzare un ordigno di quella potenza in così poco tempo, dovendo per di più tenere a bada lo scetticismo del mondo scientifico e avendo a disposizione fondi pressoché inesistenti?»
«Chi ha detto che dobbiamo realizzarlo?» replicò Bender con un sorriso malizioso. «Basta accontentarsi di quello che c’è già… nello spazio.»
Laura e Kevin gli piantarono in viso sguardi ancora più perplessi.
«Come tutti sanno, la massima aspirazione del presidente Ronald Reagan era probabilmente quella di passare alla storia come il realizzatore di un piano di difesa stellare degli Stati Uniti d’America. A quei tempi io fui chiamato a dirigere il coordinamento del progetto Scudo Spaziale, un disegno veramente efficace per difendere il territorio da un attacco nucleare.
«Semplificando, il sistema di difesa avrebbe dovuto funzionare così: diverse batterie di missili a testata nucleare avrebbero dovuto ruotare attorno alla terra come normali satelliti. Alcuni dei vettori dovevano essere intercettori, capaci di far esplodere in volo le testate dirette contro le nostre città, altri invece dovevano avere il compito di cancellare ogni forma di vita nel territorio nemico.
«Prima che il congresso ci tagliasse i fondi e che il comunismo, autoestinguendosi, cancellasse persino il concetto di pura emulazione militare della guerra fredda, il mio staff e io siamo riusciti a mettere in orbita quasi sessanta missili, con un potere detonante pari a quattrocento chilogrammi di esplosivo nucleare: circa seicento volte l’ordigno di Hiroshima.»
L’anziano scienziato lasciò cadere una breve pausa per osservare l’effetto delle sue parole sugli interlocutori, quindi riprese: «È inutile che mi guardi con quell’espressione severa, dottoressa Joanson. I suoi begli occhi non ci guadagnano. Ero e sono convinto che una bomba atomica sia molto meno pericolosa in volo attorno all’orbita terrestre che sepolta in questa o quella base segreta sotto il salotto buono di casa nostra».
«Crede che i suoi missili possano bastare per scongiurare il pericolo dell’asteroide Speitz?» tagliò corto Kevin.
«Calma, colonnello. Non so ancora se possano bastare al nostro scopo, sempre ammesso che se ne verifichi la necessità, però conosco molto bene le difficoltà connesse con l’operazione. Prima di tutto, bisogna infatti trovare un veicolo idoneo e mettersi a girare per lo spazio in cerca delle batterie di missili. Mi sembra comunque che l’ Atlantis possa fare al caso nostro.
«Una volta raggiunte le stazioni di puntamento, occorre poi che una persona di ottima dimestichezza con quegli ordigni faccia una passeggiata nello spazio per disinnescare le testate e smontarle dall’affusto dei missili. Dopo di che, le ogive nucleari possono essere ricoverate nella stiva del mezzo spaziale con l’ausilio del braccio meccanico dello Shuttle.
«A questo punto, però, viene veramente il difficile. Con quale vettore verranno portate sull’obiettivo le testate nucleari?»
E Bender fece una nuova breve pausa, con aria meditabonda, riprendendo: «Forse si potrebbe legarle a grappolo attorno a un razzo e lanciarle direttamente dalla stiva contro la presunta minaccia spaziale. Sempre che, ripeto, questa minaccia si verifichi davvero. Chissà».
«Non sarebbe più semplice lanciare da terra una navicella già equipaggiata con le armi nucleari?» chiese Laura.
«Giusta osservazione», annuì Bender. «Ma c’è un grosso ‘ma’. Lei era presente quando i massimi responsabili dello spazio ci hanno manifestato il loro scetticismo circa il presunto pericolo. E ci scontreremmo di sicuro con lo stesso atteggiamento delle grandi potenze se chiedessimo adesso di poter attingere agli arsenali nucleari. Se la minaccia dovesse diventare una certezza, non avremmo sicuramente problemi. In quel momento tutti farebbero a gara per aiutarci. Basterebbe un ordine del presidente degli Stati Uniti. Ma potrebbe essere tardi. Anzi, sarà sicuramente tardi.
«Inoltre», proseguì pensosamente Bender, «esiste una seconda remora di enorme importanza per l’opinione pubblica, e di conseguenza per i politici. Si immagina uno Shuttle imbottito di megatoni che parte dalla Terra? Un qualsiasi incidente al momento del decollo, o poco dopo, potrebbe avere conseguenze terribili, persino più catastrofiche della presunta minaccia dell’asteroide. No, allo stato attuale nessuno autorizzerebbe una simile procedura. Dobbiamo prepararci da soli.»
Porto di Ostia. Anno 849 dalla Fondazione di Roma.
[96 d.C. (N.D.T.)]
Giunio scese a terra con il favore del buio notturno, coprendosi con una tunica e un turbante scuri, alla maniera di molti marinai africani, per evitare il rischio di essere riconosciuto da qualche concittadino.
La nave oneraria carica di granito arrivò in porto la sera dopo. Dal suo nascondiglio sotto una barca da pesca tirata in secco, Giunio seguì con attenzione la manovra di ormeggio. Vide distintamente Dario sulla prora. Notò che i suoi modi tradivano una grande agitazione.
Scese a terra prima ancora che le gomene venissero fissate alle bitte. Poco mancava che corresse: la taglia che pendeva sulla testa del fuggiasco accusato di omicidio continuava evidentemente a fare presa sul suo spirito avido.
Giunio gli si parò davanti all’improvviso, uscendo dal nascondiglio con la spada brandita. Nonostante l’oscurità, vide con chiarezza il suo viso torcersi in una smorfia di terrore. Ma, passato il primo attimo di panico, Dario riuscì a ricomporsi e ad abbozzare un sorriso: «Giunio», esclamò, «mio salvatore! Il mio cuore si gonfia di gioia nel vederti!»
«Basta con le commedie, Dario», ribatté lui, stringendo la mano sull’elsa. «Sono tornato per farti pagare le tue colpe.»
«Aspetta, fratello, che cosa fai? Io non ho mai creduto alla menzogna con cui hanno infangato il tuo nome», replicò l’altro, spostandosi leggermente di lato.
Читать дальше