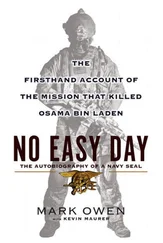Nell’appartamento regnava un ordine quasi inquietante, come se qualcuno si fosse dato da fare per fermare il tempo e congelare i ricordi.
L’appartamento era pieno di antichi cimeli, di fotografie e lettere, di disegni raffiguranti l’Anello dei Re.
Alberto aprì l’armadio e spostò alcuni vestiti. La bottiglia era nascosta dietro a dei pantaloni piegati.
Sciarra tolse il tappo e annusò l’odore forte del liquore: quella bottiglia non avrebbe dovuto essere lì.
Improvvisamente tutto gli fu chiaro: l’ultima lettera che il suo amico gli aveva scritto proveniva dal distretto di polizia di Manhattan. Da lì avrebbero cominciato le loro ricerche.
«No, signore. Minhea Petru è uscito da quella porta da un paio di mesi e non è più tornato a farci visita. Una persona veramente priva di riconoscenza.»
Il sarcasmo trapelava dal tono dell’agente mentre scorreva un registro vergato a mano.
Alberto era uscito e si era fermato smarrito sul marciapiede davanti alla stazione di polizia.
Sentiva che Minhea era vivo, e che probabilmente aveva bisogno di lui, ma non sapeva come continuare a cercarlo.
«Signore», disse una voce in italiano alle sue spalle, «mi chiamo Cesare e lavoro all’hotel Plaza. Promettetemi che non direte nulla alla direzione dell’albergo: se i miei superiori dovessero venire a conoscenza anche di un solo particolare di questa vicenda, mi licenzierebbero su due piedi. So che siete qui per cercare il signor principe Petru.»
«È così, Cesare. Tu sai qualche cosa? Ti prego, dimmi tutto.»
«Il signor principe aveva il vizio di bere.»
«Lo sospettavo da tempo e ne ho avuto conferma curiosando nell’armadio del suo appartamento.»
«Date le mie conoscenze si rivolgeva a… ehm… membri della mia famiglia per rifornirsi di liquori che, come voi saprete, sono da anni severamente proibiti qui negli Stati Uniti.»
«Vai avanti, Cesare.»
«Quando venne rilasciato dalla prigione, credo si sia recato direttamente in un bar clandestino a poca distanza dall’albergo. Da lì è stato visto uscire alle prime ore del mattino… non era in buone condizioni… insomma, il signor principe era completamente ubriaco.»
«Tu hai idea di dove avrebbe potuto recarsi, una volta abbandonato il locale?»
«Lo hanno visto percorrere la Nona in direzione nord, verso Central Park. Era sprovvisto dei documenti di identità, dato che sul bancone del bar aveva lasciato questo. Ne sono venuto in possesso da pochi giorni: il barista era convinto che il principe si sarebbe fatto vivo, prima o poi.» Così dicendo Cesare gli porse il portafogli che Petru aveva dimenticato nel locale clandestino.
Stati Uniti d’America, 1931
Béla Lugosi sedeva su un palco, accanto a lui c’erano il regista Browning e qualche pezzo grosso della casa di produzione. Coccarde col tricolore dell’Ungheria verde bianco e rosso erano ovunque, nella sala da pranzo dell’hotel Plaza lussuosamente imbandita.
Quando Béla Lugosi pronunciò il suo discorso in lingua magiara, il più scatenato a prodursi in fragorosi applausi fu un ometto insignificante, accompagnato da una donna dai capelli color biondo platino che ostentava improbabili atteggiamenti da gran dama.
Se Béla Blasko avesse prestato attenzione a quel suo sfegatato ammiratore, si sarebbe reso conto che lo conosceva già: si trattava del passeggero che anni prima, durante la traversata atlantica, lo aveva denunciato al comandante.
Dagli appunti raccolti da Asher Breil
a Cortina d’Ampezzo, 1967
«Non appena saremo in albergo», aveva detto Alberto alla moglie, «tu recupererai più informazioni possibili presso ospedali e uffici di polizia: sarà anche sconfinata questa metropoli, ma adesso siamo in possesso di una data precisa e di una zona sufficientemente circoscritta. Vedrai che lo troveremo.»
Giunti nuovamente al Plaza, Sciarra rimase a osservare i colori delle coccarde: erano gli stessi della bandiera italiana.
«C’è forse una festa di miei connazionali?» chiese alla reception.
«No, signore. Si tratta di ungheresi che festeggiano…»
In quel momento Béla Lugosi sbucò da uno dei corridoi della hall, seguito da un codazzo di ammiratori. Non era possibile non notarlo: indossava un frac nero con una camicia e una cravatta candide. Il volto era spolverato di cipria bianca e gli occhi sottolineati dal nerofumo.
Sciarra gli si fece vicino ed esclamò ad alta voce: «Blasko! Béla Blasko!» Il dito di Alberto era puntato verso l’attore.
Lugosi non si scompose, mentre Sciarra continuava: «Il vostro nome è Blasko, tenente nell’esercito ungherese durante la prima guerra mondiale. Non è vero?»
Lugosi lo osservò con uno sguardo gelido e incredulo al tempo stesso. «Voi vi sbagliate, mio caro amico. Io sono Béla Lugosi, il grande attore.»
Quello strano incontro non era certo sfuggito all’occhio attento di Teofil Bàlaj e di sua moglie, che stavano camminando al seguito dell’artista.
«Quando lo abbiamo conosciuto noi, invece, si chiamava Olt, se non vado errata. Vero, Teofil?» disse la signora Bàlaj rivolta al marito. «Credo che il signor Béla ‘Dracula’ Lugosi sia una persona piuttosto originale e che andrebbe tenuta d’occhio, non trovi, Teofil?» L’espressione da oca petulante era scomparsa dal volto della donna, per lasciare il posto a uno sguardo tanto indagatore quanto scaltro.
Il mattino seguente Kimberly era già al lavoro di buon’ora. Entro poche ore la ricerca produsse i suoi frutti.
«Un uomo senza documenti è stato ricoverato a seguito di un grave incidente in un ospedale vicino all’Undicesima.»
«Pensi si possa trattare di Minhea?» le aveva chiesto Alberto, ancora scosso dall’incontro del giorno precedente con Béla Blasko.
«La descrizione corrisponde.»
«Ed è ancora vivo?» chiese poi Sciarra con la voce rotta dall’emozione.
«Sì, anche se non credo che questo sia un bene: dimesso dopo un delicato intervento chirurgico, si trova ora in un ospedale psichiatrico. Le conseguenze del trauma hanno prodotto un grave danno cerebrale e la totale perdita della memoria.»
«Si tratta di danni irreversibili?»
«Al telefono non si sono molto sbilanciati. Ma se si trattasse veramente di Minhea, temo che il nostro amico vegeti come se fosse stato lobotomizzato.»
Era sufficiente una visita nel reparto chiamato Madhouse , il manicomio all’interno del N.Y. General Hospital, per provocare uno shock anche nella persona più forte ed equilibrata. I malati si aggiravano come fantasmi, ciondolando lungo i corridoi avvolti negli ampi camicioni bianchi. Alcuni gesticolavano, altri parlavano da soli, altri ancora stavano in disparte, accostati al muro o nascosti dietro un angolo, annientati dalla loro stessa follia.
Il medico con cui i coniugi Sciarra avevano ottenuto un appuntamento li aveva guidati verso il proprio ufficio: «Possono aggirarsi liberamente per l’istituto soltanto pochi dei ricoverati: quelli che non sono considerati pericolosi per sé e per gli altri sono autorizzati a muoversi all’interno di alcune sezioni della struttura.» Quindi, osservando con attenzione la cartella clinica, aveva continuato: «Voi dite che uno di questi pazienti potrebbe essere il vostro amico, signor Sciarra?»
«È molto probabile, dottore. Devo soltanto vederlo per riconoscerlo.»
«Tra qualche istante sarà qui, gli infermieri sono andati a prendere la persona che risponde alla vostra descrizione.»
«Credete che i danni da lui subiti siano irreversibili, dottore?»
«La mente umana è la più incomprensibile delle macchine, signor Sciarra. Nonostante il buon livello di conoscenze a cui è arrivata la medicina moderna, il cervello e il suo modo di reagire a stimoli, traumi o malattie è ancora oggetto di teorie controverse. A giudicare da quanto leggo, il paziente potrebbe restare per sempre nella condizione in cui si trova o, anche se non lo escludo, pur ritenendolo molto difficile, potrebbe svegliarsi all’improvviso da quello che sembra uno stato ipnotico.»
Читать дальше