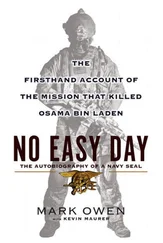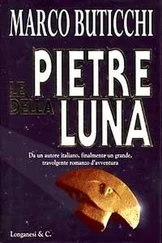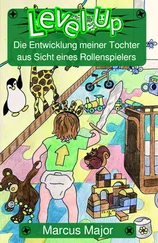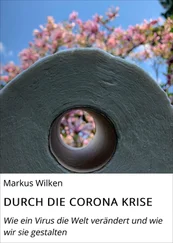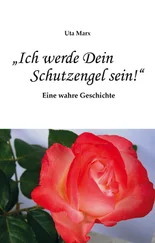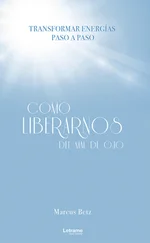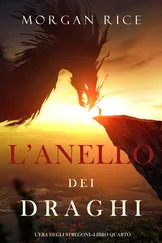«In totale dieci chilogrammi di esplosivo e quasi un quintale tra viti, chiodi e bulloni d’acciaio. Le assicuro che non è stata una passeggiata portare tutta quella roba sui tralicci. Peccato. Lei mi ha negato un ottimo spettacolo. Però questa nostra sfida ha il potere di eccitarmi enormemente. Alla prossima, Breil.»
Sono molti gli aneddoti che tendono a offuscare la fama della Central Intelligence Agency. Uno di questi vuole che l’agenzia statunitense sia l’ultima a venire a conoscenza dei fatti di interesse nazionale.
Non era stato così per quello che era accaduto nello stadio cipriota.
Glakas aveva preavvertito i suoi uomini sull’isola non appena ricevuta la telefonata del Giusto. Naturalmente aveva tenuto nascosto il suo contatto e quanto lui fosse invischiato nella faccenda. Lo scopo di quella telefonata sarebbe stato, ad attentato avvenuto, di dimostrare ai superiori che lui era sulle tracce del terrorista, ma che, purtroppo, era arrivato tardi.
Non appena gli erano stati segnalati i movimenti di Cassandra Ziegler e Oswald Breil, aveva inviato un paio di uomini di rinforzo allo scarso organico presente sull’isola.
Il dirigente della CIA aveva seguito in diretta il disinnesco degli ordigni all’interno del 20 Temmuz Stadyum di Kyrenia, collegato via cellulare con uno dei suoi che non aveva mai perso di vista la Ziegler.
Il telefono privato di Glakas prese a suonare nello stesso istante in cui Oswald Breil, a migliaia di chilometri di distanza, interrompeva la chiamata con il terrorista.
«Sono convinto che non ti sei perso la scena, Glakas», disse la solita voce metallica.
«I miei uomini mi hanno tenuto al corrente. Questa volta hai fallito, Giusto.»
«No, ho solamente perso la battaglia che avevo messo in conto di perdere per vincere la guerra. E tu sai di che guerra sto parlando, vero?»
La voce assunse un tono quasi isterico, e ciò non aveva nulla a che vedere con il marchingegno elettronico che l’alterava: il Giusto sembrava aver perso la sua proverbiale calma.
«No, non so di che guerra parli.»
«Vedrai, Glakas, vedrai. Anche loro avranno paura a camminare per la strada, avranno paura a mandare a scuola i loro figli, avranno paura a vivere. Anche loro come noi, Glakas.»
Glakas assunse un’aria pensosa non appena il Giusto interruppe la conversazione. Vincere quella guerra interessava anche a lui. Ma l’avrebbe fatto senza il Giusto, che diventava una presenza sempre più scomoda e pericolosa.
Era arrivato il momento di rendere inoffensivo il serial bomber.
Dagli appunti raccolti da Asher Breil
a Cortina d’Ampezzo, 1967
«Ricordo ancora il contenuto della lettera con cui Minhea mi comunicò la sua decisione di trattenersi in America per qualche tempo, dopo che già aveva fatto la spola diverse volte tra l’Europa e il nuovo continente alla vana ricerca dell’Anello dei Re. Qualche cosa mi diceva che difficilmente sarebbe ritornato in patria. Pensi, Asher, abbiamo combattuto assieme su quelle vette», aveva detto l’anziano generale Sciarra, indicando le montagne che circondavano Cortina. Quindi si era messo a declamare quasi a memoria il testo della lettera.
«Nessuna cosa, Alberto caro, mi lega più al mio paese, se non il dovere che ho nei confronti di un impegno che ho giurato di rispettare, così come hanno fatto, prima di me, i miei avi: avere cura dell’Anello dei Re e conservarlo anche a costo di mettere a repentaglio la propria vita. Io purtroppo ho disatteso al giuramento. E il mio compito, ora, è quello di recuperare l’antico talismano dei principi di Valacchia. Sono convinto che il tenente Blasko — o come diavolo si farà chiamare lui adesso — non ha ancora lasciato gli Stati Uniti. Devo riuscire a scovare il suo nascondiglio. Fraternamente ti abbraccio. New York, 1925.»
Stati Uniti d’America, 1921-1925
Béla Blasko non si nascondeva affatto, anzi aveva solamente voglia di «apparire». Aveva cambiato ancora una volta nome, ma per un semplice gioco delle circostanze…
«Blasto?» gli aveva chiesto l’agente dell’Immigration Office.
«Blasko!» aveva ripetuto per l’ennesima volta l’ungherese.
«E come si scrive Béla Blasko?» Non che fosse duro di comprendonio, ma l’America non voleva che la forza lavoro rappresentata dagli immigrati rimanesse ancorata alle sue antiche origini: il nome era parte delle radici che l’immigrato avrebbe dovuto recidere per poter diventare un vero americano.
Chi si apprestava a calcare il suolo degli Stati Uniti doveva essere sano di costituzione, non presentare gibbosità o mutilazioni e non mostrare altre deformazioni scheletriche. E l’ungherese soddisfaceva questi requisiti. Poco, se non nulla, importava al paese come aveva dichiarato di chiamarsi l’ennesimo clandestino senza passaporto che veniva accolto sul suolo americano.
«Come si scrive Blasko?» chiese ancora l’agente.
«Scriva Lugosi, Béla Lugosi», disse l’ungherese tracciando le lettere sul piano del polveroso tavolo nell’ufficio immigrazione. Quel nome sarebbe stato il suo tributo alla città di Lugos, in Romania, che lo aveva visto nascere nell’ottobre del 1882.
Erano trascorsi alcuni anni da quel giorno. Béla ricordava ancora quando, seduto in un tram affollato, aveva oltrepassato la periferia di Los Angeles ed era entrato in quello che aveva sempre immaginato come lo scenario di una fiaba.
La città, e in particolar modo il quartiere di Hollywood, aveva fatto molta strada da quando i nativi cahuenga e cherokee abitavano le valli e le praterie della regione. La popolazione era cresciuta in maniera esponenziale e lì aveva sede una tra le più ricche industrie del territorio americano, l’industria dove i sogni di un mediocre attore europeo avrebbero potuto realizzarsi.
Béla Blasko-Lugosi percorreva ogni mattina la Wilcox Avenue, intitolata ai primi abitanti di razza bianca della zona, per raggiungere l’Hollywood Hotel.
Nelle sue continue passeggiate in cerca di una scrittura, transitava dinanzi alle ville delle celebrità del grande schermo. Aveva ormai imparato i nomi delle star e dei magnati del cinema che vi abitavano protetti dagli invalicabili muri di cinta: Mary Pickford, Cecil DeMille, Louis Mayer, Jackie Coogan, Rodolfo Valentino, Dolores del Rio, Wallace Reid.
«Prima o poi potrò permettermi anche io una villa così», si ripeteva Béla Lugosi, entrando negli uffici del Central Casting Office.
Il Casting Office era una sorta di grande emporio dove un produttore, un costumista o un regista potevano approvvigionarsi di comparse e caratteristi, animali ammaestrati e musicisti, attori sull’onda del declino e giovani talenti. Insomma, ogni persona, animale o oggetto in grado di calcare la scena era schedata nello sconfinato archivio del Central Casting Office.
Anche Lugosi si era messo in lista appena arrivato a Hollywood, nel 1923. Poco dopo era arrivata la prima piccola parte in un film realizzato con l’aiuto finanziario delle forze armate statunitensi. Erano seguite una serie di scritture; per lo più si trattava di ruoli da comparsa che però gli davano da vivere in maniera dignitosa.
Tra alti e bassi Béla Lugosi era andato avanti per quattro anni, sino a che non si era presentata l’occasione che gli avrebbe cambiato radicalmente la vita.
Dagli appunti raccolti da Asher Breil
a Cortina d’Ampezzo, 1967
«Buonasera, signor principe», aveva detto il concierge dell’hotel Plaza di New York chinando il capo in segno di rispetto. Minhea Petru aveva preso la chiave con la mano percorsa da un leggero tremito, che aveva cercato di nascondere.
La stanza da lui occupata era sempre la stessa ormai da qualche anno. Gli unici periodi nei quali il nobile rumeno non era annoverato tra gli ospiti fissi del lussuoso hotel corrispondevano ai suoi sempre più rari ritorni in Europa. Ormai Minhea faceva parte delle leggende del Plaza, di quel sommesso mormorio che nasce dall’accumularsi di piccole indiscrezioni da parte dell’abbottonato personale. C’era chi diceva che Petru fosse alla ricerca di un tesoro di famiglia che gli era stato sottratto; chi sosteneva che avesse abbandonato il vecchio continente per dimenticare un amore non corrisposto. L’unica cosa su cui tutti si trovavano d’accordo era che il principe da alcuni anni aveva cominciato a bere.
Читать дальше