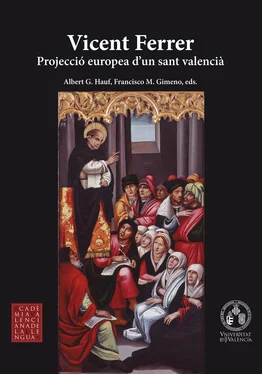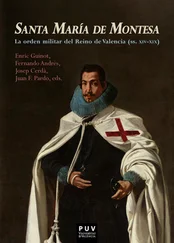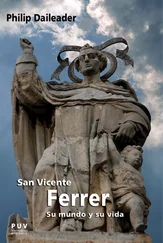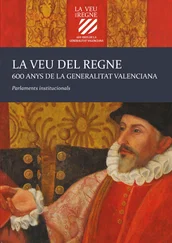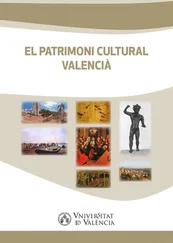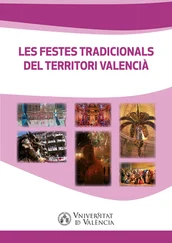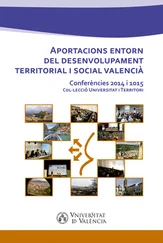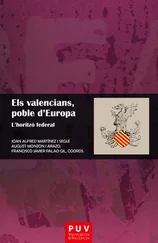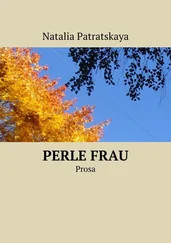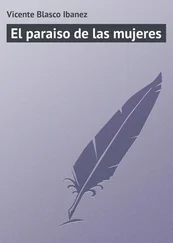AAVV - Vicent Ferrer. Projecció europea d'un sant valencià
Здесь есть возможность читать онлайн «AAVV - Vicent Ferrer. Projecció europea d'un sant valencià» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, ca. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Vicent Ferrer. Projecció europea d'un sant valencià
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Vicent Ferrer. Projecció europea d'un sant valencià: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Vicent Ferrer. Projecció europea d'un sant valencià»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Vicent Ferrer. Projecció europea d'un sant valencià — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Vicent Ferrer. Projecció europea d'un sant valencià», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Se gli studia generalia come anche gli studia artium erano funzionali alla formazione degli insegnanti delle scuole conventuali domenicane, le scholae , erano in realtà proprio queste ultime l’oggetto privilegiato della legislazione domenicana sullo studio. Nella scuola conventuale il magister studentium , che ne era il responsabile, doveva provvedere all’organizzazione delle dispute o di altri esercizi simili al momento del vespro o in altro momento consono. In questo nuovo contesto mutava anche il ruolo della cella che in ambito domenicano si trasformava da solitario riparo di ascendenza eremitica in un vero e proprio studio, dove il religioso approfondiva le proprie conoscenze e ne acquisiva di altre. Ogni domenicano non doveva dimenticare che, come attestano le antiche Costituzioni, era un vir evangelicus ad imitazione di san Domenico, intento sempre a parlare con Dio o di Dio. A questo scopo doveva intraprendere un esigente percorso di studio, regolato dalla ratio studiorum che conferma il ruolo portante della schola nella formazione intellettuale domenicana: dei circa ventiquattro provvedimenti varati dalla commissione nominata da Umberto di Romans, una ventina riguardavano le scuole conventuali. Si prevedevano pene per i frati che disattendevano alle lezioni; in occasione delle visite canoniche annuali, si stabiliva la verifica della preparazione di ciascun lettore conventuale; si vietava di portare in aula libri che non rientravano nei programmi di studio; ai lettori conventuali non in servizio fu ordinato di frequentare le lezioni e di partecipare alle dispute per essere al corrente delle questioni di attualità. In ogni convento si sarebbe dovuto preparare un frate repetitor incaricato di impartire quotidianamente le repetitiones di tutte le lezioni date nella scuola conventuale e ogni settimana quelle di tutte le questioni trattate nelle dispute. Infine, fu stabilito che fosse tenuta due volte a settimana la collatio scientifica, in cui i frati si esercitavano come confessori o come predicatori, dimostrando di saper maneggiare testi come la Summa de casibus .
I Predicatori fin dalle origini prestarono particolare attenzione alla qualità della schola conventuale non solo per garantire una buona formazione ai frati, ma anche per assicurare ai laici e ai chierici secolari interessati un insegnamento di alta qualità. Del resto, sia il papato sia i vescovi locali raccomandarono l’inserimento dei frati della nova religio sia per la loro attività di insegnamento sia per il loro servizio pastorale. I Predicatori insegnavano pubblicamente, non solo dal pulpito, ma anche nelle scuole. Ben presto divennero in Europa i professori di teologia per antonomasia, proprio grazie al ruolo svolto dalle loro scuole.
L’iter formativo prevedeva, dopo un triennio dedicato alla formazione spirituale e religiosa del novizio, l’inizio dello studentato con lo studio delle arti liberali, durante i quali i giovani frati apprendevano la logica e la retorica. Successivamente, venivano iniziati agli studia naturarum , cioè alla filosofia della natura. Fin dal 1220 le Costituzioni domenicane proibivano lo studio della filosofia: «In libris gentilium et philosophorum non studeant» (Vicaire 1937: 290; Thomas (1965): 361-362; Bériou-Hodel, 2019: 254), raccomandando esclusivamente quello della teologia. Questo divieto non fu mai abrogato almeno fino alla seconda metà del XIV secolo per cui, per l’erezione degli studia artium e degli studia naturarum , così come per la partecipazione dei frati ai corsi ivi impartiti, era sempre richiesta una speciale dispensa del Maestro dell’Ordine. Sempre per questa ragione i programmi degli studia artium e degli studia naturarum vennero inseriti gradualmente nel percorso formativo domenicano (la logica ebbe un suo spazio solo nel 1259, la filosofia qualche anno dopo e gli studia naturarum in tutte le province dell’Ordine solamente nel 1305).
In questo contesto è comunque attestata una certa osmosi tra gli studia conventuali e le facoltà delle arti, a cominciare dal corpo docente che frequentemente veniva a coincidere in entrambe le istituzioni.
Terminato lo studio delle arti liberali e della filosofia della natura, si accedeva al quadriennio di studi teologici, diviso in due bienni, di cui l’ultimo da frequentare presso uno studio generale.
Per tutto il XIII secolo i testi di riferimento furono la Bibbia e le Sentenze di Pietro Lombardo, che sarebbero state progressivamente sostituite dalle opere di Tommaso d’Aquino, soprattutto la Summa theologica . Ciò avvenne in via definitiva nel XVI secolo con il Concilio di Trento. La Sacra Scrittura fu affiancata per un certo periodo dalla Historia scolastica e dalle summae di Guglielmo Peyraud. Solitamente al baccelliere ( sublector ) e al cursor era affidata la didattica di questi testi, mentre il lettore aveva l’incarico degli approfondimenti. Il commento al testo del Lombardo si attuava attraverso il ricorso ai grandi commentatori scolastici, tra cui Alessandro di Hales, Bonaventura, Tommaso d’Aquino, Giovanni Duns Scoto e Guglielmo di Ockham e ai più autorevoli esponenti della grande tradizione patristica latina (Ambrogio, Girolamo, Agostino, Gregorio Magno) e greca, sebbene in traduzione latina. Alla fine del XIII secolo si possono distinguere tre tipologie di baccellieri: i biblici , incaricati di leggere la Bibbia; i sententiarii , in grado di commentare le Sentenze di Pietro Lombardo; i formati , chiamati a cimentarsi nelle disputationes . Normalmente con il conseguimento del titolo di baccelliere, il frate cominciava ad espletare il ministero di confessore o di predicatore, mentre i più meritevoli erano inviati presso uno studium solemne nella provincia di appartenenza o presso uno studio generale, dove affluivano i frati da tutte le province dell’Ordine.
Per chi continuava gli studi teologici dopo il conseguimento del baccellierato presso gli studi generali, il cursus terminava con l’esame ( rigorosum ) con cui si conseguiva la licentia ubique docendi , titolo abilitante per l’insegnamento della teologia in tutto l’orbe cattolico. L’esame verteva su due distinzioni tratte da due dei quattro libri del manuale del Lombardo (o il I e il III, o il II e il IV). Presso i Predicatori, solo una volta conseguito il titolo di «maestro in teologia», il frate poteva sostenere la disputa de quolibet , mentre alla disputa ordinaria erano ammessi indistintamente tutti i lettori. Superato l’esame, il candidato alla licentia doveva cimentarsi in un disputa pubblica, detta «vesperia», durante la quale doveva dimostrare di essere in grado di rispondere a domande di argomento biblico e teologico. Finalmente, il cursus di studi teologici si concludeva con il dies aulae o aulatio , il giorno della consegna delle insegne magistrali o dottorali e con il convito offerto dal neo-dottore.
Tra la fine del XIV e gli inizi del XVI secolo si assiste ad un incremento massiccio degli studia generalia domenicani in Europa, che passano da tredici nel 1300 alla cifra ragguardevole di sessantatré nel 1500, mantenendo comunque pressoché inalterata la tradizionale struttura istituzionale. Nei centri universitari italiani più rinomati, quali Bologna e Firenze, la teologia rimase appannaggio degli studia dei vari ordini religiosi o dei collegi affiliati, sebbene all’interno della facoltà delle arti l’università potesse attivare una «lectura theologica» a proprie spese.
Vincenzo Ferrer (Kaeppeli-Panella, 1993: 458-474; Hodel, 2008; Daileader, 2019), entrò nell’Ordine domenicano nel 1368 (Forcada, 1956: pp. 1-18). Due anni prima, nel 1366 (Robles Sierra, 1996: 129-130, 133) il Maestro dell’Ordine Simone di Langres (1352-1366), reiterando le disposizioni del suo predecessore Ugo di Vaucemain (1333-1341) in merito alla formazione dei lettori in filosofia e teologia, aveva varato i programmi per i collegi della Provincia di Aragona, alla quale apparteneva il Nostro. In esse veniva stabilito che gli studenti iscritti a tali collegi, una volta entrati nell’Ordine, avrebbero dovuto conoscere la grammatica latina, in modo da poter accedere, subito dopo la professione religiosa, agli studi di logica e successivamente a quelli di «filosofia naturale». Una volta acquisite queste conoscenze, i frati della Catalogna sarebbero poi passati a Lérida per attendere agli studi teologici. I migliori però erano inviati allo Studio di Barcellona, dove a poter insegnare con il titolo di «magistri sententiarum» (cioè abilitati a commentare le Sentenze di Pietro Lombardo) erano solo coloro che si erano formati presso lo Studio generale di Parigi. I frati di Aragona e di Navarra invece continuavano gli studi teologici a Saragozza. La sempre maggiore difficoltà di reclutare frati con una sufficiente pregressa conoscenza della lingua latina, atta all’accesso degli studi di logica, è evidente dal crescente numero di religiosi assegnati nei vari conventi per studiare grammatica, a partire dal 1350. Infatti nel triennio 1351-1353 gli assegnati a studiare grammatica superavano quelli assegnati per lo studio della logica. Nel 1371 il capitolo della Provincia d’Aragona destinò uno studente su tre allo studio della grammatica. È opportuno a questo punto spendere qualche parola sulle scuole di grammatica istituite nei conventi domenicani della Penisola iberica. Un tratto distintivo della Provincia domenicana di Spagna, eretta nel 1221, fu proprio la costante preoccupazione dei capitoli provinciali di organizzare scuole di grammatica, ben documentate fin dal 1299. Al capitolo generale di Colonia (1301) vennero staccati da questa provincia i conventi della Catalogna, di Aragona, di Valenza, di Navarra e delle Isole Baleari (Reichert, 1898: ) La difficoltà di reperire professori di grammatica portò alla concessione per i frati assegnati a questo fine degli stessi privilegi riservati ai «doctores actu legens». A quanto pare, però, nemmeno questi vantaggi ebbero l’effetto di aumentare il personale docente. Il priore conventuale poteva ricorrere anche a personale esterno al convento o addirittura a secolari. Nel 1348 il capitolo generale di Lione (Reichert, 1899: 323) concedeva il ricorso a docenti secolari 4. Il capitolo generale di Pamplona del 1355 reiterò questa disposizione 5(Reichert, 1899: 367). Nel 1405, tuttavia, la politica dell’Ordine su questo argomento mutò se il capitolo generale di Norimberga (Reichert, 1900: 119) stabiliva che ogni provincia provvedesse all’erezione di almeno uno studio di grammatica e il conferimento dell’insegnamento ad un maestro di grammatica, regolare o secolare che fosse 6. Nel 1321 nella Provincia domenicana d’Aragonavenne proibito di accogliere nell’Ordine giovani sprovvisti di formazione grammaticale di base, senza permesso del priore provinciale (Robles Sierra, 1991: 145). Nei conventi catalani, sempre alla fine degli anni ‘20 del XIV secolo, si avvertì sempre più il bisogno dell’istruzione grammaticale per i giovani frati, ai quali venne imposto di rimanere nei conventi dove avevano ricevuto l’abito per attendere agli studi grammaticali. Riguardo all’insegnamento della grammatica, sappiamo che lo scopo da raggiungere era la padronanza della lingua latina, sia parlata, sia scritta attraverso il metodo della ripetizione pomeridiana, come illustra la disposizione di un capitolo provinciale del 1352 (Robles Sierra, 1994: 234) 7. Del resto il capitolo generale celebrato a Besançon nel 1353 aveva ordinato che: «ad sacros ordines de cetero nemo promoveatur…nisi…ad minus in grammaticalibus sufficiens sit inventus» (Reichert, 1899: 350), ribadendo quando stabilito dai capitoli di Bordeaux del 1324 (Reichert, 1899: 153) e di Tolosa del 1328 (Reichert, 1899: 179).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Vicent Ferrer. Projecció europea d'un sant valencià»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Vicent Ferrer. Projecció europea d'un sant valencià» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Vicent Ferrer. Projecció europea d'un sant valencià» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.