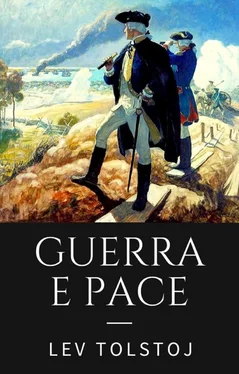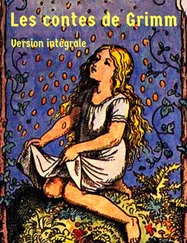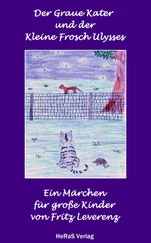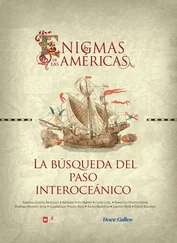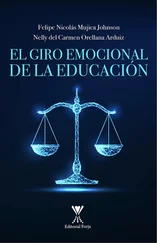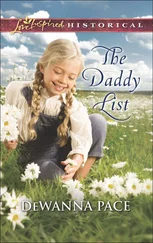Stavano già calando le ombre sul genio creatore di figure immortali, quando l’uomo, il veggente, divenuto in un istante eroe, volle raccogliere nell’ora vespertina di sua vita tutta la nobiltà luminosa dell’anima, che aveva alimentata la sua lunga giornata. La conversione del Tolstoi, i cui presupposti sono già, secondo notammo, latenti in questo libro che ora appare in veste italiana, per la prima volta tradotto integralmente e direttamente dall’originale russo, come nell ’Anna Karenine , esigeva come suo logico complemento l’estremo sacrificio di rinunzia, il cui programma anticipato era nell’articolo Demands of Love pubblicato da lui parecchi anni prima dell’ultimo atto di sua vita2 . Ora quella conversione potè ripetere bensì, come altri ha notato3 , sostanzialmente i motivi ideali di tutte quelle autobiografie religiose di tutti i tempi, a cominciare dalle Confessioni di S. Agostino, che hanno fornito utile materia al noto libro del James sulle varietà dell’esperienza religiosa. Ma una cosa distingue la conversione tolstoiana dagli altri movimenti congeneri: che il segno verso cui mira questa grande anima di profeta e di solitario non è una vita oltreterrena, bensì il regno della felicità umana, che ella annunzia regno di Dio sulla terra, anzi nascente dalla stessa terra, cioè dal lavoro umano applicato a questa gran madre che col suo «largo petto» alimenta la vita, e pacifica e affratella gli uomini. Non è quindi la nuova parola una negazione ascetica delle ragioni del vivere; sì una ricerca della via che a lui par la sola atta a condurre alla vera e stabile felicità terrena. È quasi l’apologia del lavoro manuale, come veicolo di vera umanità, e ritorno al vero stato di semplicità naturale e di pace. Ogni istituto sociale, lo stato, la società civile, la giustizia punitiva, l’amore sessuale, la scienza, l’arte medesima, di cui era stato, e doveva essere fino agl’inizi del secolo, così gran sacerdote e ministro, sono impedimenti a questa vita verace, insidiosi ed iniqui espedienti con cui si tenta giustificare il peccato e l’oppressione dei simili, forme consuetudinarie d’intossicamento morale come quelle che muovono, più o meno palesemente, da impulsi egoistici, e ci allontanano dalla intimità colla natura, nella quale ci sentiamo parte viva di Dio.
Amaro e cinereo pessimismo non è, dunque, questo, come altri ha creduto; se non, come in ogni conversione di spiriti religiosi, nel suo impulso iniziale, che è il sentimento di disagio nella vita circostante, e in quanto anela alla liberazione dall’egoismo e dalle lotte della esistenza comune acuite dalla ragione, creatrice di tutte le così dette ipocrisie sociali. Ma non è rinunzia alla volontà della vita; bensì, anzi, ricerca di quella che ei crede la vera vita; dacchè se la salute non può sperarsi da qualche cosa di esterno, deve invece cercarsi entro di noi. La linea di pensiero e di sentimento in cui si muove il Tolstoi è sì una diramazione divergente da quella del Nietzsche, dal comune tronco pessimistico dello Schopenhauer che spinge le sue lontane radici nell’oriente buddistico, non solo nella critica di quelle che i più credono le fonti del piacere e della vita, ma anche in quello che svolge la dottrina antiegoistica della simpatia e della negazione di sè stesso, e tende alla liberazione dall’incessante contrasto fra l’istinto e la volontà, fra il sentimento e la ragione, fra il presente reale e l’ideale. Divenuto consapevole di essere anch’egli, come tanti che stanno in alto, un parassita della società che vive del frutto dell’altrui lavoro, del lavoro delle plebi che pur sono più felici di lui perchè immerse nel lavoro e nei semplici doveri della vita e sostenute dalla lor fede rassegnata anche al male, a lui non riesce conquistare la fede ingenua e nativa degli umili. E dispera di trovarla finchè non incontra un genio religioso che gli rivela il semplice e pur grande segreto della vita, racchiuso nel fondo dell’idea religiosa buddistica e specialmente cristiana. Allora gli balena alla mente e all’animo inquieto la luce di una verità nuova ed antica, nella efficacia salutare e redentrice del lavoro, della povertà, della non resistenza al male, nel sentimento dell’universale simpatia e dell’amore umano. Onde ei ritrova espressa nell’evangelio, liberamente interpretato, la soluzione del problema della vita, la quale altrimenti rimane un peso di dolore e un enigma tormentoso. Poichè la miseria e il male nella vita nasce dal riguardarsi come un essere separato, a cui sia lecito volgere all’utile proprio le forze del lavoro altrui. Ma quando l’uomo si avvede che il suo vero fine è nel cooperare al bene universale, nel collaborare ad un’opera comune, allora solo ei merita e sente di entrare nel vero regno dello spirito, di conformarsi ad un ordine divino del mondo. Così è che nell’anima grande dello scrittore russo poterono penetrare frammenti di altri grandi spiriti congeneri e congeniali, il Rousseau e il Ruskin, Victor Hugo e il Mazzini, Schopenhauer e il Carlyle, l’Ibsen e il Wagner, e risalendo nei secoli fino a S. Agostino e S. Paolo. Ma questi frammenti ei potè fondere in una concezione propria e originale, se anche non propriamente filosofica, della vita. Per la quale non intese di mortificare la vita se non per trovare o ritrovare la smarrita via di essa: nè si fece censore e giustiziere universale delle deformazioni sociali, se non per esser poi caritatevole e misericorde per gli uomini più vicini alla natura. E perciò non il fine suo può disconoscersi o rinunziarvisi, bensì soltanto i mezzi onde credè di poterlo conseguire.
Questo ideale di vita ei trovò nell’evangelio, non già criticamente storicamente interpretato (poichè a lui non premeva di discernere gli elementi storici ed originali dei documenti cristiani, o come si sien formati gli evangeli), bensì in quello che nella parola del Cristo a lui parve elemento e promessa di vita, il messaggio di pace agli uomini di buona volontà. L’idea della vita è, difatti, l’idea maestra in quella che si può dire la sua filosofia religiosa, la cui formula sta nella parola di Paolo: «la legge dello spirito di vita in Cristo, che libera dalla legge del peccato e della morte». Quello che vi è di veramente vitale nell’idea cristiana, non è la forma, il sistema dogmatico a cui oggi la Chiesa s’attiene, ed è lettera morta; bensì solo la dottrina della partecipazione alla vita dello spirito per mezzo del Cristo. Se non che il Tolstoi non può sottrarsi all’abito mentale dell’ortodossia, contro cui pur muove così aspra guerra, che consiste nel determinare lo spirito cristiano in una dottrina e in una serie di regole di vita, che è come il pentalogo da lui estratto dal Nuovo Testamento. Ora il Cristianesimo è una fonte sempre viva. Nessuno può contrarre il suo spirito in un vaso che tutto in sè lo contenga e racchiuda. Il rinnovamento del mondo, la creazione «di una nuova terra», che è l’ideale cristiano, non può essere se non opera di un lungo, continuo, graduale mutamento, che s’inizi dall’intimo dell’animo dell’uomo e non per esterni comandamenti. Il vero segreto dell’evangelio, come nota giustamente a proposito del Tolstoi Matteo Arnold,4 è racchiuso nella parola: «chi amerà la sua vita, la perderà: e chi perderà la sua vita, la salverà». Non è un precetto da seguirsi alla lettera, ma una idea che opera sull’intelletto e sull’animo, e di un inesauribile valore.
Nè, quanto alla sostanza, la ribellione alle forme e agli ordini sociali, o il principio dell’evangelio tolstoiano della non resistenza al male, risponde esattamente all’ideale cristiano. Per certi rispetti la sua aspra critica degli ordini sociali esistenti s’incontra collo spirito del sindacalismo come l’intende Giorgio Sorel5 . Gesù pagò il tributo a Cesare, e stette a convito coi pubblicani, sebbene nè l’impero romano nè la Giudea del suo tempo fossero compatibili col suo ideale e colla «nuova terra» che doveva fiorire sotto la sua nuova luce. Forse la soluzione moderata e provvisoria di Levine nell’ Anna Karenine , in una società come la nostra sarebbe più vicina alla «regola divina della verità», che non quella così radicale accettata e praticata più tardi dal Tolstoi. La non resistenza al male non è un motivo che si trovi così schietto e senza temperamenti nella predicazione di chi aveva pur proclamato: «io son venuto a portare la guerra non la pace». E la guerra al male è una necessità dolorosa ma imprescindibile, per il trionfo finale del bene e della giustizia. Onde il Tolstoi medesimo, che seppe accendere vasti incendi sulle nevi e i ghiacci della sua terra, nella denuncia spietata e inesorabile di tutte le ipocrisie umane, di tutte le deformazioni e le esteriorità vacue e corruttrici delle religioni ortodosse, di tutte le oppressioni ufficiali, di tutto un vasto sistema di sfruttamento sociale, fu pure il grande atleta di questa battaglia eterna contro il male, o contro quello che tale egli ha creduto. Atleta fino da questo libro di Guerra e Pace e più nella seconda parte di sua vita come scrittore; e negli ultimi giorni della sua travagliata esistenza anche come uomo, dacchè alla denuncia del male e all’insegnamento del dovere, fece seguire più immediata e più ardimentosa l’azione.
Читать дальше