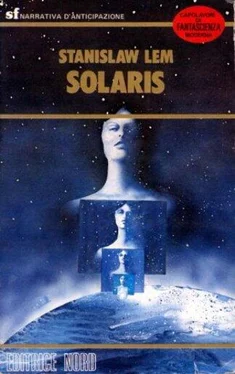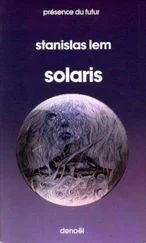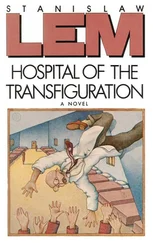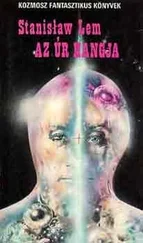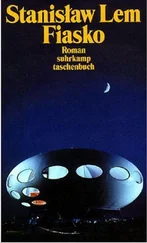L’appoggiai sulla pelle, là dove avevo una cicatrice rotonda e rossa, e lo conficcai nella carne. Il dolore era fastidioso.
Guardai il sangue che stillava a grandi gocce sulla superficie esterna della coscia e cadeva lentamente sul pavimento.
Era inutile. Ogni volta i pensieri atroci che mi passavano per la mente diventavano più espliciti. Da tempo non mi dicevo più: «E’ un sogno», non lo credevo più. Pensavo solo:
«Devo difendermi». Guardai la sua schiena che traspariva dal vestito bianco, la forma dei suoi fianchi, i suoi piedi scalzi penzolanti sopra il pavimento. Mi chinai, toccai leggermente la caviglia rosea, passai la mano sotto la pianta del piede.
Era delicata come quella di un neonato.
Seppi allora con certezza che non era Harey, e che quasi sicuramente lei stessa non lo sapeva. Il piede scalzo si mosse sotto le mani, le labbra scure di Harey ridevano senza far rumore.
— Piantala… — disse piano.
Liberai dolcemente la mano e mi alzai. Ero ancora nudo.
Mentre mi vestivo in fretta, vidi che si era seduta sul letto.
Mi guardava.
— Dov’è la tua roba? — domandai, e mi pentii subito.
— La mia roba?
— Ma hai solo questo vestito?
Ormai era un gioco. Mi comportavo apposta con noncuranza, con naturalezza, come se ci fossimo lasciati il giorno prima, no, come se non ci fossimo mai lasciati. Si alzò e con una leggera mossa diede un colpo alla gonna per lisciarla. Le mie parole l’avevano interessata, ma non disse nulla. Per la prima volta diede uno sguardo concreto all’ambiente, come cercando qualcosa, poi riportò gli occhi su di me, visibilmente stupita.
— Non so… — mi disse vaga. — Forse nell’armadio…? — aggiunse, e socchiuse la porta.
— No, lì ci sono solo le tute — risposi. Trovai di fianco al lavandino il rasoio elettrico e cominciai a farmi la barba. Preferivo non voltare le spalle a quella ragazza, chiunque fosse.
Camminava su e giù per la cabina, guardando in tutti gli angoli, e fuori dalla finestra; alla fine mi si avvicinò e disse:
— Chris, ho l’impressione che sia successo qualcosa…
S’interruppe. Aspettai, col rasoio in mano.
— E’ come se avessi scordato… è come se avessi scordato quasi tutto. Solo… ricordo te… E… e niente di più.
L’ascoltavo cercando di dominare la mia espressione.
— Sono… stata ammalata?
— No… ma si potrebbe dire così. Sì, per un certo tempo sei stata un po’ ammalata.
— Ah. Dev’essere per questo.
Cominciò a rasserenarsi.
Non so descrivere ciò che passai. Quando stava zitta, e camminava, e si sedeva, e sorrideva, ero convinto di avere davanti a me Harey. A farmi girare la testa era qualcosa di più forte della paura. Una Harey semplificata, limitata alle sue caratteristiche nei gesti e nelle risposte. Mi si avvicinò, mise i pugni sotto il mento e mi domandò: — Come andiamo?
Bene o male?
— Nel migliore dei modi. Sorrise impercettibilmente.
— Se lo dici così, direi che va male.
— Ma no, Harey carissima. Adesso devo uscire — dissi rapidamente. — Mi aspetterai, vero? Forse… hai fame — aggiunsi, poiché a un tratto sentivo anch’io crescere la fame.
— Fame? No.
Scosse la testa, e i capelli ondeggiarono.
— Devo aspettarti? Per molto?
— Un’oretta… — cominciai, ma m’interruppe.
— Vengo con te.
Era un’altra Harey: quella che conoscevo non era mai stata così invadente.
— Piccola, non è possibile.
Mi guardava dal basso e mi prese la mano. La toccai dal braccio alla spalla, il suo braccio era pieno e caldo, una carezza non intenzionale. Il mio corpo si riconosceva nel suo, lo desideravo, mi attraeva fino alla follia, al di là delle incertezze e della paura.
Cercando a tutti i costi di tranquillizzarla, ripetei: — Harey, è impossibile: devi rimanere.
— No.
Come risuonò nella cabina quella parola!
— Perché?
— N… non lo so.
Si guardò attorno e di nuovo alzò gli occhi.
— Non posso… — disse quasi sottovoce.
— Ma, perché?
— Non lo so. Non posso. Mi sembra che… mi sembra che…
Chiaramente, cercava una risposta. Quando la trovò, fu per lei quasi una scoperta.
— Mi sembra… che io non debba smettere di vederti.
L’intonazione concreta tolse alle parole ogni sentimento di fedeltà. Sotto questa impressione, il mio abbraccio cambiò…
anche se apparentemente non lo mostrai. Era rigida tra le mie mani; fissandola negli occhi, cominciai a piegarle le braccia all’indietro. Questo movimento, sebbene non premeditato, aveva uno scopo. Cercavo con gli occhi qualcosa con cui legarla. I suoi gomiti si toccarono e, contemporaneamente, si tesero con tale forza che annullarono la mia presa. Lottai per un secondo. Nemmeno un’atleta, piegata all’indietro come era Harey, toccando appena con i piedi il pavimento, sarebbe riuscita a liberarsi; lei, però, con un’espressione del tutto indifferente, senza modificare il suo lieve sorriso un po’ insicuro, spezzò il mio abbraccio, si raddrizzò e abbassò le mani.
I suoi occhi mi osservavano con la stessa tranquilla curiosità di prima, quando mi ero svegliato, come se non si fosse resa conto del mio disperato sforzo per immobilizzarla dettato da un accesso di paura. Era in piedi, inerte, sembrava che aspettasse qualcosa, indifferente e allo stesso tempo raccolta e leggermente stupita di tutto.
Mi caddero le braccia. La lasciai in mezzo alla stanza e mi diressi verso il piano del lavandino. Sentivo di essere in trappola e ne cercavo l’uscita, pensando convulsamente cosa fare. Se qualcuno mi avesse chiesto che cosa mi succedeva, che cosa significasse tutto quello, non sarei riuscito a dire neppure una parola, però mi rendevo conto che era qualcosa che succedeva a tutti nella stazione, ed era insieme tremendo e incomprensibile; eppure mi ostinavo a cercare una via d’uscita. Anche se ero di spalle, sentivo lo sguardo di Harey.
Sopra il ripiano, in una nicchia del muro, si trovava una cassetta di pronto soccorso. Vi guardai dentro rapidamente. Trovai un tubetto con dei sonniferi e buttai quattro pastiglie — la dose massima — nel bicchiere. Non cercavo di nascondere ad Harey quel che facevo. Mi era difficile dirne il perché. Non ci pensavo troppo. Versai nel bicchiere acqua calda, aspettai che si sciogliessero le pastiglie e mi avvicinai ad Harey che restava in mezzo alla stanza.
— Sei arrabbiato? — domandò in un bisbiglio.
— Bevi questo.
Non saprei spiegarne il motivo, ma ero certo che mi avrebbe obbedito. Ed effettivamente prese il bicchiere dalle mie mani e ne bevve il contenuto.
Appoggiai il bicchiere vuoto su un mobile e mi sedetti in un angolo tra l’armadio e la biblioteca. Harey mi si avvicinò lentamente, si accucciò per terra a fianco della poltrona, com’era solita fare, con le gambe sotto di sé, e, con un movimento a me ben noto, buttò i capelli all’indietro. Pur convinto che non fosse lei, ogni volta, riconoscendo questi particolari, qualcosa mi stringeva la gola. Era davvero una cosa incomprensibile e tremenda, e soprattutto terribile, per me, quel cercare di darle a intendere, contro la mia volontà, che la consideravo Harey, quando lei stessa, senza malizia, era convinta di esserlo. Non so come potevo essere arrivato a capirlo, ma ne ero sicuro, se di qualcosa si poteva essere sicuri…
Ero seduto, la ragazza appoggiava la schiena contro le mie ginocchia, i suoi capelli solleticavano la mia mano immobile, stavamo in quella posizione senza muoverci. Di tanto in tanto guardavo l’orologio. Era passata mezz’ora. Il sonnifero ormai avrebbe dovuto fare effetto. Harey sussurrò adagio qualcosa.
— Che cosa dici? — domandai, ma non mi rispose.
Presi questo per un segno di sonnolenza incipiente, sebbene, quant’è vero Dio, nel fondo della mia anima dubitassi che il barbiturico facesse effetto. Perché? A questa domanda non trovavo risposta, sicuramente perché il mio ragionamento era fin troppo semplice.
Читать дальше