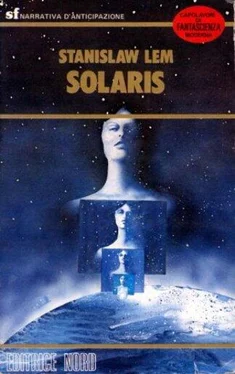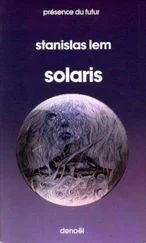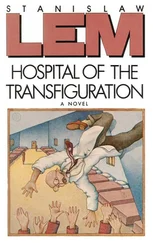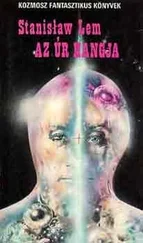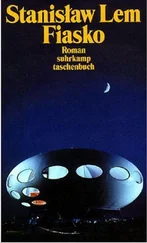La rimisi al suo posto. Sapevo che non mi sarebbe bastata nemmeno una pistola a raggi gamma; che cosa avrei potuto fare? Distruggere la porta? Invadere il laboratorio? Mi alzai.
Sprofondando nell’oceano, simile a un’esplosione all’idrogeno, il disco mi rinviò un fascio di raggi paralleli quasi tangibile; quando raggiunsero la mia guancia (scendevo giù per la scaletta) fu come la bruciatura di un ferro rovente. A metà scala ci ripensai e tornai su. Controllai tutt’intorno al laboratorio. Come ho detto, il corridoio lo circondava: dopo cento passi, mi trovai davanti a un’altra porta di vetro simile a quella di prima. Non provai ad aprirla, sapevo che era chiusa.
Cercavo qualche finestrino nella parete in plastica, qualche fessura; il pensiero di spiare Sartorius non mi sembrava affatto ignobile. Volevo smetterla con le supposizioni e conoscere la verità, ma non riuscivo a figurarmi come fare. Mi venne in mente che il laboratorio era illuminato dai portellini posti sul soffitto, ciò significava che si aprivano nella corazza superiore; se fossi riuscito a raggiungere l’esterno, avrei potuto guardare dentro. Per fare questo dovevo scendere al piano inferiore per prendere la tuta e l’autorespiratore a ossigeno. Mi ero fermato davanti alla scala, rimuginando se ne valesse la pena. Era molto probabile che i portellini fossero chiusi con vetri opachi, ma che altro mi rimaneva da tentare?
Scesi al piano di mezzo. Dovetti passare davanti alla cabina radio. La porta era spalancata. Snaut stava ancora come l’avevo lasciato, nella poltrona. Dormiva. Udendo i miei passi si mosse e aprì gli occhi.
— Salve, Kelvin! — disse con voce arrochita.
Rimasi zitto.
— Sei riuscito a sapere qualcosa? — domandò.
— Sì — risposi tranquillamente. — Non è solo.
Fece una smorfia. — Ma guarda! E’ già qualcosa. Ha ospiti, dici?
— Non capisco perché non volete parlarmi. Poiché sono destinato a rimanere qua, prima o poi verrò a saperlo — dissi quasi involontariamente. — E allora, perché tutti questi misteri?
— Lo capirai quando avrai degli ospiti — mi disse. Sembrava che non gradisse la mia presenza e non avesse voglia di chiacchierare.
— Dove vai? — chiese, quando mi mossi. Non risposi. La rimessa dell’aeroporto era nelle identiche condizioni in cui l’avevo lasciata. La mia capsula bruciacchiata era ancora ritta lì, soprelevata e vuota. Mi avvicinai al ripostiglio delle tute spaziali e di colpo mi passò la voglia di quella scappatella sulla superficie della corazza. Girai sui tacchi e, per una scaletta a chiocciola, scesi nei depositi.
L’angusto corridoio era pieno di bombole e di casse impilate. Le pareti nude, metalliche, mandavano un riflesso azzurro livido. Ancora qualche decina di passi e vidi sotto la volta le tubature dell’impianto di congelamento coperte di brina bianca. Le seguii. Andavano a finire in un manicotto con un grosso collare di protezione, e attraverso di esso passavano in un locale a chiusura ermetica. Quando aprii la porta, che aveva guarnizioni di gomma larghe due palmi, m’investì un gelo che mi penetrò fin nelle ossa. Rabbrividii. Dal groviglio delle serpentine coperte di brina pendevano i ghiaccioli. E anche qui c’erano casse e contenitori, velati da uno strato gelato; gli scaffali lungo le paratie erano pieni di scatolame e di grasso in cubi gialli avvolti in plastica trasparente. Di fronte, sul fondo, la volta a botte si abbassava. Lì era appesa una tenda di stoffa pesante, che luccicava per gli aghi di ghiaccio che vi si erano formati. Ne scostai un lembo.
Su un lettino a rete d’alluminio giaceva, coperta da un tessuto grigio, una forma oblunga.
Alzai un orlo del telo e vidi il volto cereo di Gibarian. I capelli, neri con una ciocca bianca, aderivano lisci al cranio. La laringe sporgeva e sembrava sul punto di bucare la gola. Gli occhi spenti guardavano fissi la volta, all’angolo di una palpebra si era formato un ghiacciolo opaco. Il freddo che mi avvolgeva mi faceva tremare a tal punto che dovevo fare un enorme sforzo per non battere i denti. Senza lasciare la coperta, con l’altra mano toccai la sua guancia. Era come toccare un legno secco. La pelle era ruvida, irta di peli corti. Una piega che esprimeva un’infinita e sprezzante pazienza era congelata sulle sue labbra. Nel lasciar ricadere l’orlo del tessuto, vidi che da sotto le pieghe sporgevano delle perle o fave nere e allungate, in ordine di grandezza decrescente. Mi irrigidii di colpo.
Erano dita di piedi scalzi, che vedevo dalla parte della pianta; i polpastrelli ovali erano lievemente divaricati. Sotto il lembo rigonfio del sudario c’era la donna nera, appiattita contro il corpo del morto. Sembrava riposare bocconi, come immersa nel sonno. Centimetro per centimetro scostai il grosso tessuto. La testa ricoperta di capelli crespi, intrecciati a ciuffetti, era appoggiata sul braccio nero. La pelle lucida della schiena era tirata sulle vertebre della spina dorsale.
Nessun movimento animava quel corpo immenso.
Ancora una volta guardai la pianta dei suoi piedi e mi colpì una stranezza: non si erano appiattiti sotto il gran peso che dovevano sopportare, non si erano incalliti con il camminare scalzi, la pelle che li copriva era fine come quella della schiena e delle mani.
Dominai un fremito e mi piegai per toccarli; ma ciò mi risultò più difficile che toccare il cadavere. Quando vi appoggiai la punta delle dita accadde un fatto incredibile; il corpo, a una temperatura ambiente di 20 gradi sotto zero, era vivo, e si mosse. Ritirò la gamba come potrebbe fare un cane che dorme, quando lo si prende per una zampa.
«Qui gelerà» pensai; ma il corpo era calmo e non freddo; avevo ancora sulla punta delle dita la sensazione di morbidezza della sua pelle. Arretrai fin oltre la tenda, la lasciai ricadere e tornai nel corridoio.
Il caldo che mi accolse mi sembrò infernale. Le scale mi ricondussero nella rimessa dell’aeroporto. Sedetti sopra un mucchio di paracadute arrotolati, chiusi nei loro anelli, e mi presi la testa tra le mani. Mi sentivo abbattuto. Non capivo quello che mi succedeva. Ero distrutto, i miei pensieri scivolavano verso un abisso, col pericolo di precipitarvi; ma la perdita della ragione o l’annientamento mi sembravano una grazia irraggiungibile e ineffabile.
Non avevo bisogno di andare da Snaut o Sartorius, mi pareva che nessuno sarebbe riuscito a figurarsi ciò che avevo provato, visto, toccato con le mie stesse mani. L’unica via di scampo, l’unica spiegazione sembrava essere la diagnosi di follia. Dovevo essere impazzito subito dopo l’atterraggio.
L’oceano si era impadronito del mio cervello, soffrivo di un’allucinazione dietro l’altra; se così era, non dovevo sprecare energie in vani tentativi di risolvere enigmi che non esistevano in realtà, ma chiedere soccorso medico, mandare per radio un S.O.S. al Prometheus o a un’altra nave.
Accadde a questo punto l’impensato: l’idea che fossi pazzo mi calmò.
Ora capivo perfettamente le parole di Snaut, sempre ammesso che Snaut esistesse realmente e che gli avessi parlato, poiché le allucinazioni potevano essere cominciate prima.
Forse ero ancora a bordo del Prometheus , colpito all’improvviso da malattia mentale, e quel che avevo veduto era una creazione della mia mente turbata. In tal caso, cioè se ero malato, potevo curarmi, e ciò mi consentiva almeno una speranza di salvezza: una salvezza che non ero riuscito a trovare nei tentativi condotti nelle ore precedenti.
Dovevo dunque eseguire una prova generale, un esperimento logico — experimentum crucis — che mi dimostrasse se veramente ero impazzito o vittima della mia fantasia, oppure se, per quanto assurde e improbabili, le mie esperienze erano reali.
Mentre sedevo a rimuginare in preda a questi pensieri, osservavo il basamento della struttura portante della rimessa spaziale. Era un pilone d’acciaio che saliva dal pavimento, fasciato di lastre curve di un colore verde pallido. In alcuni punti la vernice era venuta via, sicuramente a causa dello sfregamento dei carrelli portarazzi che passavano da lì. Toccai l’acciaio, lo scaldai per un momento con la palma della mano. Picchiai l’orlo piatto del rinforzo. Era possibile che un’illusione raggiungesse un simile grado di realtà? Forse sì, mi risposi. In fin dei conti era il mio campo, lo conoscevo bene.
Читать дальше