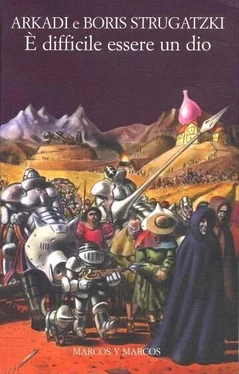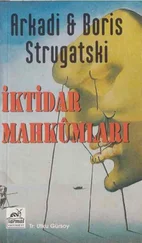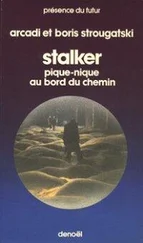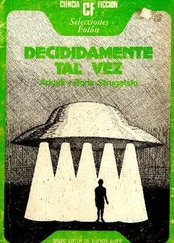Ispirati dalla benedizione del Sacro Ordine, per il quale devo ammettere di aver sempre nutrito grande ammirazione e simpatia, ci stiamo avviando verso un’era di gloria inaudita. Nessun contadino si permetterà più di alzare lo sguardo su un nobile senza essersi procurato prima un permesso speciale che dovrà essere firmato dall’ispettore distrettuale del Sacro Ordine. Sto appunto andando a consegnare una petizione scritta a questo proposito».
«Che puzza» disse Rumata.
«Sì, disgustosa» disse Don Tameo, rimettendo il tappo alla bottiglia. «Comunque, d’altro canto, come respiriamo liberamente nella nostra nuova Arkanar! E il prezzo del vino da ieri è calato della metà…»
Quando arrivarono in fondo al vicolo Don Tameo aveva vuotato la fiaschetta, che gettò via. Cominciò a essere stranamente agitato, cadde due volte con la faccia a terra, rifiutò di ripulirsi i vestiti insozzati dichiarando che essere impuro era la sua condizione naturale, che desiderava presentarsi così al suo nuovo padrone. Recitò più volte la sua petizione a gola spiegata: «Come parlo meravigliosamente!» urlava. «Per esempio, considerate questo passaggio, signori! ‘Affinché i luridi contadini…’ Eh?
Non è un’intuizione stupenda?»
Entrando nel cortile dietro la cancelleria Don Tameo si scontrò con un monaco, scoppiò in lacrime e chiese perdono per i suoi peccati. Il monaco, mezzo soffocato, cercò di difendersi dalla sua presa ferrea e di chiedere aiuto con un fischio, ma Don Tameo gli si aggrappò alla veste e caddero tutti e due in un mucchio di spazzatura.
Rumata li lasciò dov’erano e si allontanò. Anche da lontano continuava a sentire i fischi e le urla: «Affinché i luridi contadini! La vostra be-be-benedizione!… Con tutto il cuore!… Io avevo compassione, compassione, capito, villano schifoso?»
Sulla piazza di fronte all’ingresso della cancelleria stazionava un distaccamento di monaci di fanteria armati di rozzi manganelli. Avevano rimosso i cadaveri dalle strade. Il vento mattutino spingeva colonne di polvere giallastra attraverso la piazza.
L’ombra rettangolare della Torre della Gioia si proiettava sui soldati. Sotto il largo tetto conico della Torre i corvi gracchiavano e litigavano come al solito. In alto sporgeva una trave a cui si impiccavano i condannati a testa in giù. La Torre era stata costruita due secoli prima dagli antenati del Re, al solo scopo di tenere lontani i nemici in caso di guerra. Elevata su fondamenta solidissime, era una struttura a tre piani che poteva servire da magazzino viveri in caso di assedio prolungato. Più tardi la Torre era stata utilizzata come prigione. Poi, in seguito a un terremoto, tutti i pavimenti e i soffitti all’interno erano crollati, e la prigione dovette essere trasferita a livello delle fondamenta. Una volta una regina di Arkanar si era lamentata che le grida dei prigionieri torturati la disturbavano, e così il consorte aveva decretato che una banda militare dovesse suonare dal mattino presto fino a tarda notte. Era stato allora che aveva assunto il nome che ancora aveva. Ormai era solo un guscio vuoto di pietra: le sale di tortura erano state trasferite da tempo nelle buche più profonde delle cantine e l’orchestra aveva smesso di suonare i suoi concerti quotidiani, ma i cittadini continuavano a chiamarla con lo stesso nome, Torre della Gioia.
Di solito la zona intorno alla Torre era deserta. Ma quel giorno brulicava di gente. I monaci soldati conducevano, spingevano, trascinavano orde di Sturmovik con le uniformi strappate, vagabondi, straccioni, cittadini mezzi nudi paralizzati dalla paura, ragazze che urlavano istericamente. I soldati male in arnese dell’armata di Koleso, che lanciavano sguardi sprezzanti, venivano spinti come mandrie di bestiame. I monaci tiravano fuori i cadaveri dalle botole con dei ganci, li gettavano sui carri e li trasportavano fuori dalla città. Nella lunga coda di cortigiani e di privilegiati che attendevano davanti alle porte della cancelleria, l’ultimo della fila osservava inorridito l’orribile traffico.
Tutti venivano ammessi all’interno della cancelleria; qualcuno veniva aggregato a un gruppo. Rumata si fece largo a gomitate. Dentro l’aria era appiccicosa e pesante come nella discarica. A un’enorme scrivania coperta di fasci di carte sedeva un ufficiale dal colorito grigio giallastro. Dietro l’orecchio sinistro teneva una grande penna d’oca. Il richiedente di turno, il nobile Don Keu, giocherellava sprezzante con il baffo annunciando il suo nome.
«Si tolga il cappello» disse l’ufficiale con voce monotona, senza alzare gli occhi dalle sue carte.
«Il clan dei Keu ha il privilegio di portare sempre il cappello, anche in presenza del Re» disse orgogliosamente Don Keu.
«Davanti al Sacro Ordine nessuno ha più privilegi» rispose l’ufficiale con la stessa voce monotona. Don Keu cominciò a sibilare e diventò rosso, ma si tolse il cappello.
L’ufficiale faceva scorrere il dito sottile e giallastro lungo il foglio.
«Don Keu… Don Keu» mormorò. «Don Keu… Via Reale, numero 12?»
«Sì» rispose lui con voce irritata.
«Numero 485, Frate Tibak».
Frate Tibak, con il viso rubizzo e il fiato corto, era seduto alla scrivania accanto.
Frugò in certi documenti, si asciugò il sudore dalla fronte, si alzò in piedi e lesse con voce piatta: «Numero 485, Don Keu, Via Reale numero 12, colpevole di bestemmia contro il nome di Sua Magnificenza il Vescovo di Arkanar, Don Reba, due anni fa a un ballo reale, è condannato a trentasei colpi di frusta sulla schiena nuda e a baciare la scarpa di Sua Magnificenza».
Frate Tibak riprese il suo posto. «Vada in quel corridoio» disse l’ufficiale con la sua voce incolore. «Le frustate a destra, la scarpa a sinistra. Il prossimo». Con grande sorpresa di Rumata, Don Keu non cercò neppure di protestare. Evidentemente doveva aver visto molte cose mentre aspettava in fila. Squittì una volta, si toccò i baffi con grande dignità ed entrò nel corridoio.
Il successivo era l’enorme Don Pifa, una massa di grasso tremolante. Si era già tolto il cappello facendo un passo avanti. «Don Pifa… Don Pifa» borbottò l’ufficiale, facendo scorrere il dito sul foglio davanti a lui. «Via Lattai, numero 2?»
Don Pifa fece un suono gorgogliante.
«Numero 504, Frate Tibak».
Frate Tibak si toccò la pelata e si alzò in piedi.
«Numero 504, Don Pifa, Via Lattai numero 2. Non sono state rilevate sue offese contro Sua Magnificenza, e di conseguenza è puro».
«Don Pifa» disse l’ufficiale. «Ricevete l’attestato di condotta irreprensibile». Si chinò su una cassetta accanto alla sedia e prese un braccialetto di ferro che diede al gentiluomo. «Da portarsi al polso sinistro, da presentarsi immediatamente quando richiesto dai guerrieri del Sacro Ordine. Il prossimo».
Don Pifa fece di nuovo un gorgoglio, con gli occhi incollati al braccialetto, e uscì dalla stanza. L’ufficiale dalla voce incolore stava già chiamando il nome successivo.
Rumata guardò la gente che si era messa in coda ad aspettare. Tra la folla c’erano molti visi familiari. Alcuni erano vestiti bene come al solito, altri erano visibilmente caduti in disgrazia, ma ricchi e poveri erano tutti inzaccherati di fango. In mezzo alla fila, Don Sera disse per la terza volta in cinque minuti, ad alta voce: «Non vedo proprio perché un gentiluomo non possa prendersi anche qualche bella sferzata, in nome di Sua Magnificenza!»
Rumata aspettò che inviassero nel corridoio anche il successivo. Era un pescivendolo ben conosciuto, condannato a cinque colpi di bastone, senza bacio della scarpa, a causa di pensieri illeciti. Quindi Rumata si fece largo fino alla scrivania e senza tanti complimenti posò la mano sul fascio di carte dell’ufficiale.
«Scusate. Mi serve un ordine ufficiale di scarcerazione per il dottor Budach. Sono Don Rumata».
Читать дальше