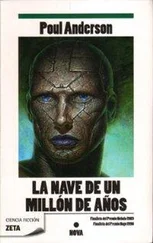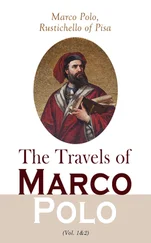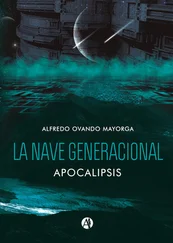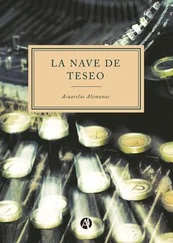Gli architetti Severo e Celere avevano interpretato alla lettera la volontà dell’imperatore. Ma un’opera di tale opulenza, nel centro della città, poteva soltanto dare origine ad aspre critiche. Si diceva che, nel corso della cerimonia di consegna, Nerone avesse esclamato: «Finalmente una casa degna di un uomo».
Ma ancora si considerava tale l’imperatore? A questa domanda Lisicrate aveva tentato più volte di dare risposta, però il suo parere cambiava insieme col mutevole atteggiamento di Nerone. Sì, avrebbe risposto il greco, Nerone era un uomo quando si calava, con le sue abili orazioni, nelle vesti di uno dei più valenti politici che l’Urbe avesse mai avuto. Era un uomo quando la sua mente ripercorreva le tappe dell’impero, riconoscendo errori e ripromettendosi di porvi rimedio. Ed era un uomo quando si trovava solo con Lisicrate.
Era una divinità, o meglio credeva di esserlo, quando spogliava le offerte votive dei templi per ricoprire d’oro una sua dimora. Credeva di essere immortale come gli dei quando i suoi occhi emettevano fiamme e la sentenza di morte usciva dalla sua bocca con la stessa disinvoltura di un saluto. Credeva di essere superiore a qualsiasi umano giudizio quando si lasciava andare a baccanali licenziosi, accoppiandosi dinanzi a tutti, e con tutti, come un animale. Credeva che nessuno tra gli uomini potesse mai giudicarlo quando si appropriava della ricchezza di Roma solo per aumentare lo sfarzo dei suoi palazzi.
Lisicrate rimase a osservare la colossale statua d’oro che raffigurava Nerone, nudo, mentre sorreggeva un globo. La sua testa era adornata da una corona a sei raggi, ciascuno dei quali lungo oltre venti piedi. Quando Nerone l’aveva commissionata allo scultore greco Zenodoro, gli aveva espressamente richiesto di venire raffigurato come il dio Sole.
Un servo lo raggiunse, offrendosi di accompagnarlo al cospetto dell’imperatore, impegnato in alcune prove teatrali.
Lisicrate seguì il servo lungo uno dei porticati che misurava oltre un miglio. Ai lati del portico si estendevano campi coltivati e boschi dove, tra piante esotiche e secolari, si aggiravano animali di ogni specie. Nello stagno erano ormeggiate sette navi identiche alle galee da guerra. Si trattava di copie delle originali, ma di proporzioni ridotte, come le imbarcazioni utilizzate nel corso delle battaglie navali al circo.
L’ auditorium era ricavato in un piccolo padiglione alla periferia orientale di quella sfarzosa città dell’imperatore. Lisicrate si stupì che non ci fosse nessuno a occupare i cinque ordini di gradinate in marmo disposti a semicerchio. Nerone amava contornarsi di pubblico anche quando provava le sue opere.
E invece l’imperatore stava eretto al centro dell’emiciclo, completamente solo. Con voce sicura declamava i versi della sua ultima creazione.
Quando la prova ebbe fine, l’applauso che Lisicrate gli tributò fu sincero.
«Non era quella la prova, mio buon Lisicrate», disse una voce ben conosciuta alle sue spalle. «Ma questa.»
Nerone stava in piedi, esattamente dalla parte opposta rispetto all’altro Nerone che aveva appena finito di recitare al centro del piccolo auditorium.
«Settimio è riuscito a ingannare anche te, la persona che mi conosce da più tempo.»
Lisicrate, passato il primo momento di stupore, dovette convenire che l’attore era perfettamente identico a Nerone: anche i movimenti, la loquela e gli atteggiamenti dovevano essere stati studiati a lungo.
«No, mio imperatore. Nessuno riuscirebbe mai a dire che Settimio non sia il divino Cesare», esclamò Lisicrate dopo aver esaminato il sosia ancora una volta.
Mar Mediterraneo, 1336
Gli uomini di Hito Humarawa, seguendo gli insegnamenti di Wu, si erano immersi giorno e notte nel corso delle due settimane in cui la galea era rimasta all’ancora nella rada di punta Marsala.
Utilizzavano delle vesciche di capra piene d’aria e appesantivano la discesa verso il fondale con grosse pietre. Lì giunti, assicuravano delle cime al carico del dromone semidistrutto dal fuoco o, in altri casi, raccoglievano con grosse reti quello che si trovava sparpagliato sul fondale.
Wu si incaricava invece di azionare, spesso con la sua sola forza, il grosso argano di prora, recuperando veri e propri tesori o rimuovendo, per mezzo delle cime, quelle strutture della nave affondata che impedivano il completo accesso alle stive.
I recuperi di materiale prezioso erano cessati due giorni prima, fatta eccezione per un’antica anfora, recante un numero romano e un sigillo sull’anforisco che Humarawa non sapeva decifrare. «Poco male», pensò il giapponese, «ci penserà Crespi a tradurre per me quanto c’è scritto.» Quasi certamente quell’anfora non faceva parte del carico del dromone, ma apparteneva con ogni probabilità a un naufragio precedente. Il bottino era stato riportato in superficie dalla ciurma del giapponese. Dato il basso fondale e la velocità dell’intervento, erano riusciti a recuperare l’intero tesoro dell’emiro di Tabarqa.
«Uomini, alle manovre», ordinò Humarawa, «si torna a Venezia.»
Poi si rivolse a Diletta, chiusa da giorni in un assoluto mutismo: «Credo che vostro padre, damigella, avrà di che rallegrarsi per l’esito di questa missione… Cosa che, curiosamente, mi sembra non stiate facendo voi… Forse la morte del pirata ha lasciato un segno nel vostro cuore?» Una risata sinistra seguì quelle parole, mentre la galea, salpata l’ancora, dirigeva verso la laguna veneziana.
Salìm aveva osservato il dromone allontanarsi, lanciato all’inseguimento del traditore ’Abd al-Hisàm. Era la prima volta che il suo comandante lo lasciava a terra, ma lo aveva fatto per un valido motivo: Tabarqa doveva avere qualcuno che amministrasse la città in nome del Muqatil, adesso che l’usurpatore era stato scacciato. E Salìm si era dato da fare per restituire la città alla sua gente e al suo condottiero.
Erano trascorse quasi tre settimane da quando il dromone era salpato, e il presagio di un disastro si era fatto strada nella mente del giovane luogotenente del Muqatil già da alcuni giorni.
Salìm osservava il porto dall’alto delle mura, quando una nave solitaria si presentò all’imboccatura del molo.
Pochi istanti più tardi, Salìm riconobbe il Muqatil che guadagnava la riva a bordo di una scialuppa.
«Che cosa è successo?» chiese Salìm quando raggiunse il suo signore.
«Siamo stati attaccati dall’orientale. Gli uomini, tutti gli uomini, sono stati trucidati.»
«E Diletta, mio signore, che ne è della tua compagna?»
«Avevamo recuperato il tesoro della mia famiglia, e siamo stati attaccati all’improvviso. Diletta e buona parte dell’oro che gli infedeli saranno riusciti a trovare sono in rotta verso Venezia.»
La galea era stata accolta in maniera trionfale, non appena entrata nella laguna; emissari del doge si erano recati sotto bordo per tributare i meritati onori al samurai che era stato l’unico capace di sconfiggere il Muqatil.
Poco prima di raggiungere la città, Humarawa aveva radunato la sua ciurma di avanzi di galera sul ponte.
«La metà del bottino che abbiamo recuperato mi spetta di diritto, uomini. Voi avete invece riacquistato la vostra libertà», spiegò Humarawa rivolto ai suoi. «Nessuno potrà mai sostenere che io non sia un generoso. A ognuno di voi spetteranno dieci monete d’oro in segno di riconoscenza per il vostro valore. Chiederò inoltre ai potenti di questa città di lasciarmi al comando di questa nave e con essa continuerò a combattere i pirati che infestano le rotte. Quindi, se qualcuno di voi vuole seguirmi…» Un’autentica ovazione si levò da quell’equipaggio di tagliagole.
«Presto, mio signore», disse uno dei servi di Angelo Campagnola, «la galea sta ormeggiando. Dicono che ci sia una donna a bordo.»
Читать дальше