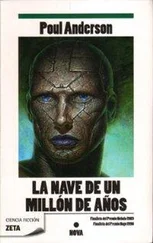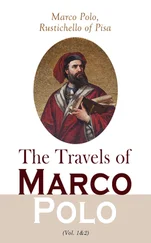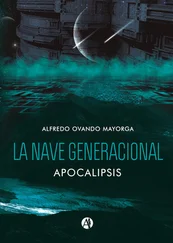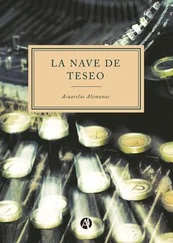Era da troppo tempo che l’erario romano non riceveva gli indispensabili introiti derivanti dai bottini di guerra: regioni come le Alpi Cozie o il Ponto Polemoniaco erano rientrate sotto l’egida imperiale in forza di pacifici trattati. L’unico fronte che rimaneva aperto sembrava essere quello armeno, dove il generale Corbulone viveva le alterne vicende della sua guerra contro il valoroso re dei Parti, Vologese. Alla fine, il re fu costretto ad abdicare in favore del fratello, Tiridate, e questi accettò di assoggettarsi pacificamente al governo di Roma.
La cerimonia di sottomissione di Tiridate, giunto nell’Urbe in pompa magna, fu molto sfarzosa e oggetto di critiche da parte di chi, preoccupato, vedeva le casse statali prosciugarsi in imprese tanto grandiose quanto inutili.
Nerone, dal canto suo, era sempre più chiuso in cupi pensieri, irascibile e vendicativo. La sua figura, un tempo agile e snella, si era notevolmente appesantita e la grande testa poggiava su un collo taurino che si congiungeva a un corpo flaccido e grosso.
«Credo sia giunta l’ora di organizzare il tuo viaggio in Grecia, mio imperatore. Sono molte le voci malevole che circolano in città sulla tua persona e temo per la tua incolumità», aveva detto un giorno Lisicrate, rimasto ormai tra i pochi consiglieri che godessero la fiducia di Nerone.
E così iniziarono í preparativi per muovere alla volta della culla della civiltà. Quando tutto sembrava pronto, la data della partenza venne improvvisamente anticipata: il genero del generale Corbulone, Annio Viniciano, aveva organizzato una nuova congiura tesa a uccidere Nerone e a insediare sul trono un nuovo imperatore. Roma sembrava non amare più il suo Cesare.
Mille carri, cinquemila augustani, migliaia di pretoriani, innumerevoli lettighe d’oro e d’argento trasportate da schiavi si misero in marcia lungo la via Appia alla volta di Brindisi. Ofonio Tigellino si occupava della salvaguardia della persona dell’imperatore e del suo nutrito seguito.
Una volta giunti a Brindisi, la flotta si diresse alla volta di Corinto, sospinta da venti favorevoli.
«Non trovi assomigli all’amata Poppea?» chiese Nerone a Lisicrate, indicando un giovane dai lineamenti femminei.
«È vero, mio imperatore», rispose il greco. «Sporo sembra la reincarnazione di Poppea.» Affermando questo, Lisicrate non aveva mentito e Nerone si era invaghito dello schiavo al primo incontro. Si raccontò poi che, nel corso di una festa sfrenata, Nerone avesse addirittura sposato Sporo, dopo averlo fatto evirare.
«Mi spiace ricondurti alla realtà, mio imperatore», disse Lisicrate, mentre Nerone era intento ad accarezzare i lunghi capelli di Sporo. «Ma vorrei ricordarti lo scopo del nostro viaggio: molti tuoi predecessori sono caduti vittime di ignobili congiure solo perché non erano stati abbastanza previdenti…»
«Io saprò conquistarmi l’affetto e la devozione di questa meravigliosa gente», rispose Nerone, mentre il profilo delle alture nei pressi di Corinto appariva all’orizzonte. Lisicrate sapeva bene che nessuno come Nerone era capace di accattivarsi le simpatie del popolo.
Il periodo che l’imperatore e il suo seguito trascorsero in Grecia fu spensierato. Lontano dagli impegni di governo e dal terrore di restare vittima di una congiura, anche Nerone sembrava aver riacquistato i molti lati positivi del suo carattere.
I greci, per accontentare l’illustre visitatore, avevano raggruppato le date dei vari giochi. E così Nerone si spostava continuamente, ricevendo la palma di vincitore, nelle competizioni Istmiche, Nemee, Olimpiche e Pitiche.
Armato di una vanga d’oro, aveva dato il via a una nuova impresa titanica, anelata sin dai tempi di Giulio Cesare: il taglio dell’istmo di Corinto, che avrebbe consentito di evitare la lunga e pericolosa circumnavigazione del Peloponneso per raggiungere il mar Ionio.
In seguito, sulla piazza del mercato di Corinto gremita di autorità e popolani, Nerone proclamò solennemente l’esenzione della provincia romana dell’Acaia, corrispondente all’intero Peloponneso, da qualsiasi tributo dovuto a Roma.
Tanta liberalità nei confronti della provincia ellenica fu male interpretata dalla Curia, e i maligni fecero circolare la voce che quello fosse il prezzo pagato dall’imperatore per le vittorie ottenute nei giochi. Nessuno, se non Lisicrate, sapeva che quello era uno dei passi decisivi per garantirsi l’amicizia di un popolo nell’eventualità di una destituzione. Ipotesi che si faceva sempre più vicina, con il crescere del malcontento e dell’invidia non solo a Roma, ma in tutte le province dell’impero.
Mar Mediterraneo, 1336
Il dromone, semidistrutto dalle fiamme, si era inabissato tra il ribollire del mare. Hito Humarawa era rimasto a osservare la nave che spariva nei fondali di punta Marsala, prima di dare inizio al macabro rituale.
Gli uomini del Muqatil ancora vivi, tenuti sotto la minaccia delle armi dai tagliagola agli ordini del samurai, erano poco più di una sessantina. Stavano radunati nei pressi dell’albero di maestra della galea e tutti conoscevano il destino a cui, entro pochi istanti, sarebbero andati incontro. Il giapponese impartì l’ordine ai suoi, proprio mentre il Muqatil riprendeva i sensi. Gli uomini dell’orientale balzarono addosso ai prigionieri disarmati e le spade calarono inesorabili sui corpi indifesi.
Un giovane marinaio del Muqatil, terrorizzato dallo spettro della morte, incominciò a implorare clemenza: «Non uccidetemi, vi prego. La nostra nave trasportava il tesoro di Tabarqa. Avete modo di diventare enormemente ricchi. Risparmiatemi».
Un corpulento ergastolano sorrise crudelmente, mentre affondava la spada nel cuore del giovane saraceno.
«Adesso è il tuo turno, Muqatil», esclamò infine Humarawa con aria sinistra. «Ma voglio che la tua giovane compagna sia testimone della tua morte. Diceva il vero quel giovane pirata quando parlava di un tesoro?»
Il Muqatil si guardò attorno disperato: degli oltre trecento uomini che componevano l’equipaggio della sua nave, era rimasto in vita soltanto lui. Il ponte della galea era arrossato di sangue e la ciurma veneziana stava gettando i cadaveri orrendamente mutilati fuori bordo, mentre altri si occupavano di ripulire il legno. I cadaveri dei saraceni venivano avvolti a quattro o cinque alla volta in grossi brandelli di vecchie vele del dromone e quindi sollevati oltre il bordo e gettati in mare.
«Vigliacco! Tu sei soltanto un vigliacco, capace di assassinare a sangue freddo degli uomini disarmati. Dammi in mano una spada e combatti con me da uomo», urlò il Muqatil, cercando di forzare i legacci che gli assicuravano le mani dietro la schiena.
«Se non mi sbaglio», rispose Humarawa sorridendo, «tu e i tuoi avete già avuto modo di mostrare quanto valete con le armi in pugno. E questo è il risultato. La guerra non conosce pietà e il solo onore è quello del vincitore. Adesso basta. Portate qui Diletta Campagnola: voglio che veda la testa del suo amato pirata rotolare sul ponte.»
L’enorme Wu percosse con un legno le ginocchia del Muqatil, costringendolo a piegarle. Humarawa sguainò la lucente katana , tenendola alta, proprio in corrispondenza del collo della sua vittima. Diletta emise un grido disperato, mentre il samurai raccoglieva la forza per colpire l’uomo che lei avrebbe amato per sempre.
Al-Buraq, il fedele falco ammaestrato, calò improvviso dal cielo, proprio mentre Humarawa stava per vibrare il fendente. Tra uno sbattere d’ali, gli artigli dell’animale si conficcarono profondamente nel viso del giapponese. Il dolore e la sorpresa fecero in modo che Humarawa si concentrasse verso la nuova minaccia. Pochi istanti più tardi, il nobile rapace giaceva privo di vita sul ponte. Ma il suo sacrificio non era stato vano: il Muqatil, approfittando della confusione, si era gettato in acqua dal parapetto della nave.
Читать дальше