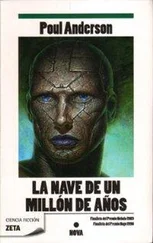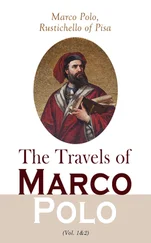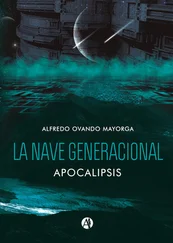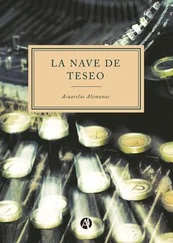«Roma brucia, Cesare», furono le sole parole che il messo, appena giunto dalla capitale, pronunciò con la voce scossa dall’affanno.
L’incendio era divampato di notte, nella zona in cui il Circo Massimo confinava con il Celio e con il Palatino. Si trattava del rione più densamente popolato della città — che contava ormai oltre un milione di abitanti — ove, tra vie strette e case di legno, si alternavano botteghe e magazzini, spesso stipati di stoffe e materiali infiammabili.
Nerone, rientrato subito da Anzio, prese a dirigere di persona i soccorsi: ma la lotta contro le fiamme era impari. I sifonarii e gli aquarii , benché aiutati da migliaia di volontari, non riuscivano con le loro pompe e i loro mastelli a domare la furia del fuoco.
«Circo Massimo, Palatino e Celio sono un unico rogo. È inutile tentare di domare l’incendio, mio imperatore», aveva detto uno dei questori che comandavano le operazioni di soccorso.
Nerone osservava la densa coltre di fumo che si levava dalla sua città, una colonna enorme che oscurava la luce del sole. L’aria era quasi irrespirabile e ovunque una pioggia di ceneri cadeva sulle strade.
«Distogliamo ogni soccorritore dai quartieri ormai devastati. Preoccupiamoci di salvare quanto è stato risparmiato dal fuoco», ordinò l’imperatore.
Nell’arco di poche ore, gli uomini si schierarono a protezione dell’Esquilino, uno dei quartieri più popolati e più poveri.
Per contrastare l’avanzare delle fiamme, Nerone comandò di abbattere tutto ciò che potesse alimentarle. Migliaia di persone lavorarono febbrilmente, radendo al suolo case, botteghe e alberi. Quando l’incendio raggiunse la fascia tagliafuoco voluta dall’imperatore, si arrestò: almeno l’Esquilino era stato salvato dal rogo.
Lisicrate era rimasto al fianco di Nerone per tutto il tempo e, con lui, si era affannato per coordinare le operazioni di soccorso. Durante i primi sei giorni nessuno riuscì a dormire più di poche ore. Poi, finalmente, la sesta notte, l’aria cominciò a diventare più respirabile e l’oscurità non fu più illuminata dai bagliori delle fiamme. L’incendio pareva volersi arrendere a tutti coloro che avevano speso ogni energia per salvare la città.
Ma quando la situazione sembrava quasi sotto controllo, improvvisamente altri focolai si accesero in diversi luoghi, spesso lontani dalle zone già investite dal fuoco. Roma arse per altri tre giorni e tre notti.
Dopo nove, interminabili giorni, l’incubo si placò. All’alba, Nerone spinse lo sguardo verso il Circo Massimo: in luogo del grande stadio, del quartiere del Palatino e di quello di Isis e Serapis, c’era un immenso cratere fumante.
Dei quattordici quartieri in cui era divisa la città, tre erano stati completamente distrutti, sette avevano subito gravi danni e solo quattro: Esquilino, Porta Capena, Trastevere e Ata Semita erano rimasti indenni. Oltre quattromila insulae e centotrentadue domus erano state ridotte in cenere.
«Roma, la mia Roma», sospirò Nerone, mentre un velo di commozione gli appannava lo sguardo. Quasi immediatamente si riscosse. «Non c’è tempo da perdere, Lisicrate, dobbiamo occuparci dei sopravvissuti, e dare sepoltura ai morti. Poi avremo tempo per pensare al da farsi.»
Il Campo Marzio venne aperto a feriti e profughi, così come i giardini di Agrippa, dove i militari edificarono dei rifugi di fortuna. A tutti i vicini municipi fu richiesto l’invio di mezzi di prima necessità. Per editto imperiale, il prezzo del grano scese a tre nummi per moggio, un sedicesimo del prezzo di mercato.
I morti vennero seppelliti a spese dell’erario. Le zone di Roma risparmiate dalle fiamme si erano trasformate in un immenso ricovero per chi nell’incendio aveva perso ogni cosa.
Il Pantheon, le terme, il portico di Vipsania, grandi sale pubbliche furono destinati ad accogliere migliaia di derelitti. Alcuni contingenti militari vennero impiegati per impedire lo sciacallaggio.
«Ricordi, Lisicrate, la mia prima orazione in Senato? Quella che provai per un’intera notte dinanzi a te?»
Il greco si meravigliò di come Nerone riuscisse, nel giro di un solo istante, a mutare espressione e umore. Adesso i suoi occhi azzurri gli ricordavano quelli del bambino che lui stesso aveva iniziato alla conoscenza. In altri momenti lo sguardo dell’imperatore sembrava attraversato dalle furie dell’Averno.
«Certo che la ricordo, Nerone. Riguardava aiuti alla città di Bononia devastata da un incendio. Ricordo anche con quanta tempestività, anni dopo, tu hai fatto sì che fossero inviati consistenti aiuti alla città di Lugdunum, rasa al suolo dalle fiamme in un sol giorno.»
«Non meritavo questo, Lisicrate. La mia città non meritava questo. Ma Roma risorgerà… Giuro che risorgerà…»
Mar Mediterraneo, 1336
«Trecento infedeli e un traditore tengono in scacco i nostri fratelli», disse il Muqatil, indicando le mura di Tabarqa.
«Già, ma se è vero che trecento uomini armati sono sufficienti per ridurre al silenzio la popolazione», convenne Salìm, «è altrettanto vero che, in uno scontro diretto con i nostri, gli infedeli avrebbero sicuramente la peggio.»
«Hai ragione, Salìm. Però, prima di arrivare allo scontro, dobbiamo superare le mura di Tabarqa: l’impresa è quasi impossibile.»
Erano venti giorni, infatti, che lungo la cinta muraria si susseguivano attacchi da parte degli assedianti. Erano poco più che azioni di disturbo, tese a tenere viva la brama di battaglia degli uomini. Il Muqatil non era ancora riuscito a elaborare un piano infallibile per conquistare la città.
Improvvisamente, alle prime luci dell’alba, come uno scrigno magico che si schiude per incanto, la pesante porta principale ruotò sui cardini: uno sparuto gruppo di una quarantina di militari infedeli uscì con le mani alzate e disarmato. Dietro di loro, uomini e donne lanciavano pietre, urla e insulti, mentre scortavano i prigionieri nella direzione in cui erano attestate le truppe del Muqatil.
La popolazione di Tabarqa si era ribellata agli invasori: quel piccolo plotone di infedeli impauriti e feriti erano i soli superstiti della lotta interna alle mura che si era protratta per tutta la notte precedente.
L’uomo che aveva assunto il comando degli insorti si inchinò dinanzi al Muqatil.
«Purtroppo ’Abd al-Hisàm è riuscito a fuggire attraverso un passaggio segreto: con alcuni dei suoi ha raggiunto la costa orientale, dove c’erano almeno due navi ad attenderlo», riferì l’uomo. «E ha portato con sé buona parte del tesoro dell’emirato. Io riconsegno a te la tua città, Muqatil, emiro di Tabarqa.»
«Ti sono grato, fratello, sono grato a tutti voi. Ma adesso non dobbiamo perdere nemmeno un istante. È tempo che l’usurpatore che ha ridotto in schiavitù la mia gente paghi per ogni sua colpa. Voglio che l’equipaggio della mia nave sia pronto a salpare prima che scenda la sera.»
Le donne presenti cominciarono a mulinare la lingua nella bocca, emettendo nel contempo un suono acuto. L’urlo di gioia si levò al cielo: quello era il saluto della gente di Tabarqa per la ritrovata libertà.
Gennaio 2002
Sara Terracini si passò la mano sulla fronte, come se volesse detergerla dal sudore: le fiamme che avevano divorato Roma nel racconto di Lisicrate sembrava fossero riuscite a incendiare anche l’atmosfera asettica del laboratorio di ricerca.
«Non dovrebbe mancare molto, e i miei uomini si trovano già in alto mare. Forza, Sara, avanti!» disse a se stessa la bella ricercatrice, sedendosi ancora una volta dinanzi allo schermo del computer.
Il Moulin Rouge era situato all’incrocio tra Hisiya e Yurakucho Street, nei pressi del Teatro Imperiale di Tokyo, e aveva poco a che spartire con l’omonimo ma più celebre locale francese.
Читать дальше