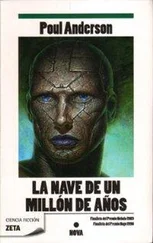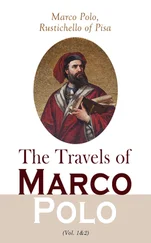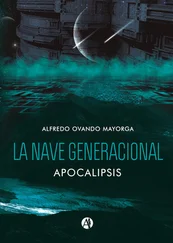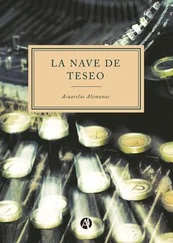«Ma tu sai a che cosa stai andando incontro? Il Muqatil è un uomo abituato a lottare, a solcare i mari combattendo i tuoi stessi fratelli.»
«Non ho più fratelli, né famiglia, emiro. Ho soltanto lui. Sono stata trattata alla stregua di una schiava, e come tale venduta al mercante più ricco. Non voglio tornare indietro. Voglio vivere la sua vita, la vita dell’uomo che amo.»
«Dio grande e misericordioso abbia cura di te, giovane donna», disse Muhammad aprendo le mani in segno di preghiera.
Angelo Campagnola era sconvolto: i contenuti della lettera che aveva appena ricevuto da sua figlia erano blasfemi e irriverenti.
La galea danneggiata dal rostro del dromone era rientrata a Venezia da poco più di un mese. Sicuramente il Muqatil aveva subito un duro colpo dopo che il villaggio era stato messo a ferro e fuoco. Comunque sua figlia, fuggita quando ormai era al sicuro, era ancora in quelle mani profane. Non era tanto la salvezza di Diletta che preoccupava il Campagnola, quanto il fatto che, con il matrimonio mancato, lui stesso doveva dire addio alle ambizioni di una vita.
Quella lettera affrettò le operazioni di riparazione della galea.
«Voglio la testa di quell’infedele», aveva detto il Campagnola rivolto a Humarawa e a Crespi. «Hanno plagiato mia figlia, annullandone la volontà con chissà quali droghe e sevizie. Riportatemi anche lei. Il nobiluomo alla quale era promessa la sta ancora aspettando. Dobbiamo fare in fretta, se non vogliamo che ci ripensi. Portatemi la testa del Muqatil su di un piatto d’argento.»
Gennaio 2002
Quando Bruno Milano giunse alla porta del suo ufficio, trovò il responsabile della sicurezza dell’ambasciata ad attenderlo. L’uomo era un sottufficiale, veterano dell’esercito della stella di Davide. Nonostante fosse abituato a vedere la morte da vicino, la sua espressione tradiva il raccapriccio.
«Come per ogni pacco che arriva all’ambasciata, abbiamo proceduto a un accurato controllo ai raggi X della scatola», riferì il sottufficiale indicando una cappelliera. «Era indirizzata a lei, maggiore Milano. Credo che dentro ci sia una terribile sorpresa.»
Il volto di Kuniko Sagashi aveva un colorito grigio-verdastro. I suoi occhi, così come la bocca, erano spalancati nel terrore della morte. Il sangue era raggrumato alla base del collo: la cappelliera conteneva la testa recisa della giovane agente.
Era uno spettacolo troppo forte anche per un ufficiale del Mossad che spesso si era trovato di fronte alla morte di un amico, di un collega o di una persona cara. Bruno Milano si voltò di scatto. Un senso di angoscia insopportabile si impadronì di lui.
«Pagherai anche per questo», disse a denti stretti.
Il camioncino con le attrezzature si fermò proprio dinanzi alla poppa del C’est Dommage. L’autista, un italiano massiccio, scese dal mezzo e chiamò a voce alta, rivolto in direzione del catamarano.
«Ehi, di bordo, c’è nessuno?»
Etienne Jalard emerse da un gavone come un palombaro dalle profondità oceaniche.
«Sono al volante da dieci ore ininterrotte», disse l’autista con un marcato accento romano. «Al laboratorio mi hanno detto che era molto urgente.»
Pochi istanti più tardi sia Jalard sia Vittard armeggiavano con la gru di poppa, prelevando i grossi imballi dalla banchina con l’ausilio del braccio idraulico telescopico.
«Si tenga pronto, Funet.» Il tono che Yasuo Maru usava con lui era, come sempre, imperioso e autoritario. «I miei uomini mi hanno comunicato che oggi hanno imbarcato delle attrezzature. Credo che si stiano preparando a salpare.»
«Ma come posso fare… Sono appena rientrato in ufficio da un periodo di ferie…»
«Si arrangi, Funet, e ricordi che il suo stipendio di funzionario statale è ben lontano da quello che le viene elargito da me.»
Breil assunse un’aria preoccupata, mentre scorreva le informazioni che aveva appena richiesto agli uffici del Mossad: erano trascorsi appena venticinque minuti da quando Sara gli aveva comunicato la notizia della scoperta e già il dossier che riguardava il quadro di Gauguin si trovava sul tavolo del primo ministro.
«L’efficienza del capitano Bernstein…» disse tra sé Breil.
Il logo dello sponsor che aveva consentito la realizzazione della mostra in Giappone spiccava al centro della locandina che reclamizzava l’iniziativa: erano una W e una E, separate da una goccia d’acqua stilizzata. Il marchio della Water Enterprise.
L’ufficio di Nicola Crisafulli si trovava in una traversa di corso Vittorio Emanuele, nel centro di Milano. Da lì controllava le attività della grande impresa edile di cui era a capo: più di duecento cantieri aperti contemporaneamente che operavano nei campi più disparati dell’edilizia. Nicola Crisafulli possedeva notevoli doti organizzative, qualità grazie alle quali aveva saputo mettere ordine all’interno dell’organizzazione mafiosa di cui era a capo.
I colpi inferti alla mafia da Alberto Vite e dai suoi avevano lasciato ferite profonde. Crisafulli aveva alzato un calice quando aveva appreso la notizia della morte del magistrato antimafia. Ma lo aveva fatto non tanto per festeggiare, quanto per onorare la memoria del più leale e arguto tra i suoi avversari.
L’uomo che stava seduto davanti a lui parlava con spiccato accento italo-americano, ma nulla di lui faceva pensare a un gangster: era vicino alla sessantina, elegante ed educato.
«Un’offensiva in piena regola, di questo si tratta, Nicola. I cinesi, sino a oggi, si sono occupati di affari per noi secondari: racket nelle Chinatown o mercato dell’immigrazione. Mai o quasi avevano interferito nello spaccio di stupefacenti in territorio americano.»
«È pur vero che il triangolo d’oro degli oppiacei è in mano alle triadi cinesi», replicò Crisafulli. «Ma è assurdo il fatto di scavalcare noi nella distribuzione della droga sui mercati. Abbiamo ottimi rapporti con i fornitori…»
«Già… Quegli stessi ottimi rapporti che io ho utilizzato per capire il motivo di questa manovra. Pare che dietro tutto questo ci sia un accordo con i giapponesi della Yakuza…» disse il capo di Cosa Nostra americana.
«La Yakuza!» sibilò Crisafulli.
«Proprio così… E pare che ci sia ancora la Yakuza dietro la richiesta di concessioni edilizie per costruire sei casinò a Las Vegas. Qualcuno, che ha già avuto modo di vedere i progetti, sostiene che saranno le più lussuose costruzioni della città. Pensare che è sempre stata una città nostra, anche se oggi è un po’ in crisi. Figuriamoci quando si aggiungeranno altri sei alberghi con casinò.»
«È incominciata la guerra. E il nemico è scaltro e spietato. Con altrettanta scaltrezza dobbiamo comportarci noi.»
Nicola Crisafulli assunse un’aria pensosa.
Roma imperiale, anno di Roma 815 (62 d.C.)
«Mia moglie Ottavia», andava raccontando Nerone a Seneca, «non riuscirà mai a darmi un erede. E la stirpe divina dei Domizi e dei Claudi non può aver fine a causa di una giumenta sterile.»
«Ti conosco a sufficienza per sapere dove andrà a parare il tuo discorso, divino imperatore», aveva risposto il filosofo con aria seria. «Poppea Sabina è ormai un’ospite fissa delle tue stanze, e non sono poche le occasioni pubbliche nelle quali quella donna fa parte del tuo seguito. Ascoltami, Nerone. Roma ti perdona tutto, ma la gente già parla di un tuo possibile divorzio. Ecco l’unica cosa che Roma non ti perdonerebbe mai: ripudiare la figlia di Claudio, una donna caritatevole, modesta e amata dal popolo.»
«Roma parla! Roma parla!» Nerone sembrava essersi acceso all’improvviso, come un fascio di legna secca sul braciere. «Tu vieni a riferirmi le voci dei pettegoli? Credi che io non abbia orecchie, Seneca? Sino a oggi nessuno ha mai osato accusarti pubblicamente, data la tua vicinanza all’imperatore. Ma sono molti quelli che ormai denunciano le tue abitudini, così morigerate a parole, ma così lussuose nella realtà. Non è forse vero che il tuo patrimonio personale ammonta a trecento milioni di sesterzi, e che nelle tue numerose residenze gli ospiti vengono fatti accomodare su triclini dai piedi in oro e avorio intarsiati? Quella Roma che parla sussurra che tu ne abbia ben cinquecento.»
Читать дальше