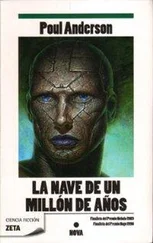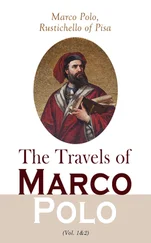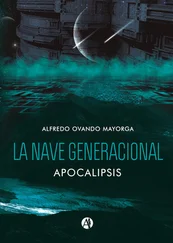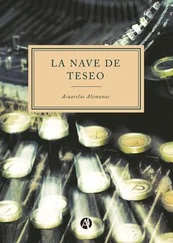Lisicrate spronò i cavalli, per quanto si potesse fare con quei due ronzini dagli stinchi massicci, abituati a trascinare grandi carichi e strumenti agricoli.
Ben prima che scendesse la sera, venti soldati a cavallo, imbeccati da qualche soffiata, avevano raggiunto il carro e imprigionato il greco assieme alla sua compagna.
«Un’ultima cosa, Aniceto», aveva raccomandato Nerone. «Fai sapere al buon Lisicrate, rinchiuso in carcere, di non preoccuparsi. Il suo amico imperatore veglia su di lui.»
Aniceto ricopriva da tempo l’incarico di comandante della flotta imperiale di stanza a capo Miseno. Non era chiaro se rivestisse una così ambita posizione per le sue capacità militari o per le complicità guadagnate nello spalleggiare Nerone in ogni sua nefandezza.
Il comandante uscì dagli appartamenti imperiali. Il compito di tranquillizzare Lisicrate in carcere era l’ultima delle sue preoccupazioni, in quel momento.
Una brezza calda e primaverile soffiava sull’insenatura di Baia. Le ville della nobiltà romana erano illuminate da una moltitudine di torce, disposte ovunque: lungo le maestose scalinate in marmo, nei pressi delle statue, lungo i bordi delle piscine riscaldate.
L’intera città era in festa per la celebrazione dei Quinquatria, il quinto giorno buio dopo le idi.
Nerone aveva invitato Agrippina, che si trovava ad Anzio, loro città d’origine, a raggiungerlo a Baia. Lei era accorsa, recitando la parte della madre che vuole abbracciare il figliol prodigo. E come tale si era comportato Nerone per tutta la sera, coprendo la donna di ogni attenzione.
Poi, a notte fonda, nel disordine del banchetto abbandonato, mentre gli ultimi ritardatari si aggiravano intorpiditi dalle libagioni, Nerone guardò negli occhi la madre e singhiozzò.
Agrippina prese ad accarezzargli con tenerezza la nuca: probabilmente, pensò, pace era fatta dopo quell’ultimo, commosso gesto. Poi, con il suo passo svelto e aggraziato, procedette verso il molo, accompagnata da un servitore e dalla vecchia schiava Acerronia.
La nave che le era stata messa a disposizione era un’imbarcazione elegante, simile a una liburna, ma finemente decorata.
Agrippina prese alloggio nella stanza di poppa. Sedette sul letto, mentre Acerronia le pettinava i capelli e il servo preparava la veste per la notte.
Il soffitto della cabina crollò all’improvviso, tra forti rumori di legna che si schiantava.
La spessa lastra di piombo con la quale il tetto era stato appesantito si abbatté sul servitore. La sua testa sembrò reclinarsi in una posizione innaturale, fino a scomparire del tutto tra le spalle. Durò la frazione di un lampo. Agrippina e Acerronia rimasero impietrite: ora toccava a loro. La spalliera di ferro del letto emise un rumore quasi musicale, mentre la lastra di piombo veniva bloccata dai montanti verticali. Le due donne miracolosamente si resero conto di essere illese.
Ma il terribile piano, architettato da Aniceto e da Nerone, non finiva lì: la nave sarebbe dovuta naufragare per cancellare ogni prova. E, come in ogni naufragio che si rispetti, ci sarebbero stati dei superstiti, uomini fedeli ad Aniceto e a Nerone messi al corrente della congiura, mentre alcuni poveri schiavi, ignari di essere stati sacrificati in nome della messinscena, sarebbero morti in mare.
Così, quando, aperte le falle, la nave incominciò a imbarcare acqua, si creò una situazione paradossale: gli uni che menavano colpi d’ascia al fasciame, e gli altri che si affannavano alle pompe e ai secchi, nel tentativo di salvare il salvabile.
La nave si inclinò e Agrippina e Acerronia furono sbalzate in mare.
La vecchia schiava si trovò presto in difficoltà nei pressi di una scialuppa piena di naufraghi. Per essere tratta a bordo con maggiore celerità, cominciò a gridare aiuto, asserendo di essere l’Augusta Agrippina. Gli uomini ai legni, i fidi di Aniceto che si erano da tempo preparati un piano di fuga, uccisero la vecchia Acerronia a colpi di remo.
Agrippina aveva assistito alla scena in silenzio: era un’ottima nuotatrice, il mare era calmo e la riva non troppo lontana. Era fin troppo chiaro che cosa fosse successo e ora anche il moto di commozione del suo amato figliolo assumeva una nuova luce.
Cercando di fare meno rumore possibile, Agrippina cominciò a nuotare, protetta da una notte serena e senza luna.
Fu ripescata da una barca di pescatori, i quali si sentirono onorati di aver salvato l’Augusta e la riportarono nella sua villa sana e salva, eccezion fatta per una leggera ferita alla spalla.
Nerone, invece, appresa la notizia del fallimento dei fidi di Aniceto, chiamò a sé i due consiglieri di quella stolta avventura.
Seneca e Burro apparivano molto preoccupati. Bisognava agire in fretta: entro breve tempo, la scampata Agrippina avrebbe denunciato al popolo e al Senato la perfida congiura ordita contro di lei.
Entrambi convennero che nessuno dei pretoriani avrebbe mai osato assassinare la figlia di un grande condottiero.
Fu la stessa Agrippina a correre in aiuto ai congiurati: ordinò a un servo di recarsi nella casa dell’imperatore e di informarlo che la sua Augusta madre era scampata al naufragio.
Non appena Nerone vide il servo entrare nelle sue stanze, fu rapido e scaltro come una volpe: gli gettò tra le gambe una corta spada e cominciò a urlare: «All’assassino! All’assassino! Quest’uomo è stato mandato qui da mia madre per uccidermi!»
Le guardie accorsero e il servo, ignaro e innocente, venne arrestato e giustiziato all’istante.
Questo evento spianò la strada ad Aniceto: si introdusse nelle stanze di Agrippina con alcuni uomini. Lei stava adagiata sul letto. Osservò l’ammiraglio con uno sguardo severo: quasi certamente era convinta che l’uomo non sarebbe mai arrivato a ucciderla. Invece Aniceto e i suoi ammazzarono a colpi di bastone e pugnale quella che era stata una tra le donne più potenti dell’impero, se non la più potente. Agrippina aveva quarantaquattro anni. La versione ufficiale diceva che si era uccisa perché non poteva sopportare l’onta di esser stata scoperta come la mandante dell’attentato al figlio.
Mar Mediterraneo, 1335
Le onde sballottavano la scialuppa come se fosse stata un fuscello nel gorgo di un fiume.
Le due donne avevano ormai perso ogni controllo sulla piccola imbarcazione. Niente le avrebbe più potute salvare dal naufragio. Erano riuscite a governare quel guscio, pur tra mille difficoltà, per l’intera notte. Adesso stavano per chinare il capo dinanzi al volere del destino.
Una prima onda colpì la barca di fianco, come un sonoro schiaffo menato da un gigante; una seconda onda, ancor più potente della prima, sollevò la poppa verso l’alto, ponendo lo scafo quasi in verticale. Ricadere nell’incavo dei marosi richiese un tempo che sembrò interminabile.
Diletta riuscì solo a dire: «È finita; perdonami, amica mia, per averti trascinato in quest’avventura» e quindi rimase inerte, ad aspettare la morte, accecata dagli spruzzi salmastri.
Il miracolo avvenne a questo punto. Una figura si issò a bordo, bagnata e ansante. Prese con mano salda il timone, disponendo la prora al mare. Poi, governando con quanto rimaneva della vela, portò la scialuppa sotto la murata del dromone. Qui numerose braccia solide e forti sollevarono le due donne a bordo.
Diletta, con le ultime forze rimastele, riuscì a mormorare: «Il villaggio, attaccheranno il villaggio con tre navi. I veneziani sanno dove si trova l’isola».
Non c’era un istante da perdere. Il Muqatil diede ordine ai suoi di forzare l’andatura. Il dromone sembrava una creatura vivente che arrancasse per superare ogni cresta di onda.
Il pinnacolo di fumo si alzava sinistro. Da quella distanza sembrava che il vulcano, spento ormai da secoli, si fosse svegliato all’improvviso.
Читать дальше