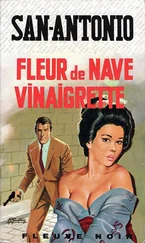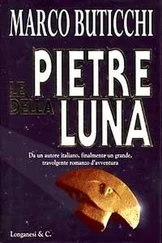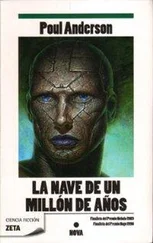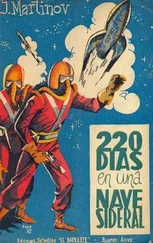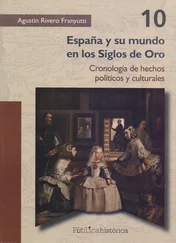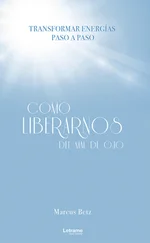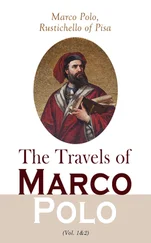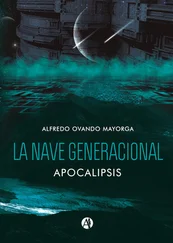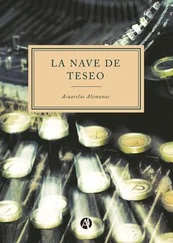«Nonostante le sue interessanti teorie, signor Funet, non siamo ancora riusciti a portare alla luce del sole nulla di interessante», replicò Maru.
Il colorito di Funet riprese i toni verdastri che lo caratterizzavano da quando si trovava a bordo e, scusandosi con il suo ospite, si diresse di corsa verso il parapetto più vicino.
Uno degli ufficiali entrò tenendosi a rispettosa distanza dal Signore delle Acque: «Il secondo turno di sommozzatori è appena rientrato, Maru sama. Ho creduto fosse opportuno disturbarla affinché lei possa prendere visione del reperto che hanno recuperato».
Roma imperiale , anno di Roma 807 (54 d.C.)
Lisicrate non aveva mai provato particolare simpatia per i personaggi del seguito di Agrippina. Li considerava per quello che erano: un nutrito manipolo di opportunisti. Tra loro c’erano maghi e astrologi dalle dubbie divinazioni, ancelle pronte a regalarsi per il sorriso di un uomo altolocato, senatori che mai avevano perorato una causa se non quella del vino abbondantemente mielato servito ai banchetti della potente moglie dell’imperatore.
Lucusta non faceva certo eccezione: era apparsa, fasciata nelle stoffe variopinte del suo Oriente, pochi mesi prima. La sua fama l’aveva preceduta: nessuno pareva dimenticare l’accusa di veneficio che pendeva su di lei. Ufficialmente Agrippina l’aveva voluta al suo seguito per la preparazione di creme e unguenti di bellezza. Ma erano tutt’altre le misture nelle quali era esperta l’anziana donna. Si diceva che conoscesse il segreto di ogni pozione magica e fosse una grande esperta di veleni: da quelli capaci di immobilizzare un uomo per lungo tempo a quelli che riuscivano a uccidere un cavallo in pochi istanti.
Giulia Litia si confidava spesso con Lisicrate: anche lei non nutriva simpatia nei confronti dei cortigiani della sua signora.
«Pare che lo stesso imperatore Claudio sia molto perplesso per il comportamento di Agrippina. E Narcisso sembra non perdere occasione per sottolineare la mancanza di scrupoli della mia signora», riferì Giulia nel corso di una delle sempre più frequenti serate trascorse assieme al pedagogo greco. «Pensa che, nonostante la protezione del liberto più vicino all’imperatore, la zia di Agrippina, Domizia Lepida, è stata comunque condannata a morte. La condanna capitale nei confronti della donna che si era presa cura dell’infante Nerone è stata voluta da Agrippina stessa.»
«Credo che tutto dipenda da Nerone: sua madre desidera più di ogni altra cosa che lui sieda sul trono. Ma non per la legittima aspirazione di ogni genitore di vedere primeggiare i propri figli: Agrippina vuole governare Roma attraverso suo figlio», rispose Lisicrate.
«Hai ragione, e pare che anche Claudio stia rivedendo i suoi piani sulla successione: Britannico cresce bene e sta riguadagnando il posto che gli compete al fianco del suo legittimo genitore. Si mormora che Claudio abbia cambiato testamento e abbia fatto controfirmare il documento da tutti i magistrati. Si dice anche che, con alcuni suoi stretti collaboratori, si sia lasciato andare a una confidenza: il destino è quello, prima di dover soffrire per i disordini provocati dalla moglie e poi di doverla punire.»
«Agrippina è a conoscenza di questo?» chiese Lisicrate.
«Ero presente quando Pallante le riferiva lo sfogo dell’imperatore.»
«Se conosco bene la tua signora, credo che dovremo ancora essere testimoni di fatti sconvolgenti, mia cara Giulia.»
L’eunuco Aloto, assaggiatore imperiale, prese un boccone di funghi e se lo portò alla bocca. Claudio era impaziente: considerava i funghi la migliore delle delizie. Probabilmente l’assaggiatore, mentre verificava la sicurezza della portata, versava sulla pietanza il potente veleno preparato da Lucusta.
L’imperatore cominciò a provare i sintomi del terribile avvelenamento poco dopo. L’ignaro Claudio non poteva certo sapere con quanta cura fosse stata architettata la congiura. Ma la tempra dell’Augusto era forte e, prima che il veleno entrasse irrimediabilmente in circolo, Claudio liberò lo stomaco diverse volte. Fu a questo punto che entrò in scena il medico imperiale, Senofonte, chiamato al capezzale del malato da un’Agrippina all’apparenza sconvolta dal dolore.
Il medico si mise subito al lavoro, mentre le condizioni dell’imperatore parevano quasi ristabilite. Senofonte utilizzò una piuma per favorire il vomito. Claudio sembrò riprendere colore, poi, improvvisamente, si accasciò e di lì a poco morì fra atroci sofferenze. La piuma utilizzata dal medico era intrisa di un veleno ancor più potente di quello versato sui funghi.
Per tre giorni la morte dell’imperatore fu tenuta nascosta. In quel lasso di tempo Agrippina strinse le poche alleanze che ancora le mancavano per coronare il suo disegno. Poi, alla mattina del terzo giorno delle idi di ottobre, l’Augusta consentì che venissero aperte le porte degli appartamenti imperiali e il mondo apprese che Claudio era morto. Alle guardie, ai liberti, ai cortigiani e agli schiavi, apparve il giovane Nerone, accompagnato dal prefetto del pretorio, Afranio Burro. Il vociare sommesso divenne un brusio e, alla fine, un’acclamazione di tutti i presenti.
Nerone fu fatto salire su una lettiga e condotto al castrum dei pretoriani. Lì il giovane si assicurò la benevolenza dell’esercito e la sua fedeltà.
«Elargirò» — così Nerone concluse il suo discorso dinanzi alle truppe — «lo stesso donativo che il mio povero padre, Claudio imperatore di Roma, ha elargito al momento della sua elezione. A ognuno di voi andrà la somma di quindicimila sesterzi.»
I pretoriani accolsero con un’ovazione quelle parole. Prima ancora che l’elezione fosse ratificata dal Senato, il diciassettenne Nerone Claudio Cesare Druso Germànico era diventato il nuovo imperatore di Roma.
Lisicrate aveva un presentimento: invece di darsi alla gioia, come facevano tutti a palazzo, intuiva che l’investitura del suo allievo avrebbe rappresentato una nuova fonte di preoccupazioni.
Gli tornò in mente il feroce attacco dei tonni: uno dei predatori che si librava nell’aria, per poi ricadere nel sangue delle sue stesse vittime.
Il giovane precettore si chiuse nella sua stanza. Estrasse dai suoi bagagli il sistro d’argento e il nodo di Iside, corredo di ogni sacerdote, e cominciò a pregare.
«Affido a te, dea della vita, il giovane Nerone. Affido a te, Iside, la sua scarsa esperienza e la sua forza, affinché riesca a governare la nave nelle acque più insidiose e turbolente. Ma quali acque possono essere più insidiose di queste stanze, dove la morte, la congiura e il veneficio sono sempre in agguato? Affido a te, Horus, la mente di Nerone. Fa sì che rimanga sano e incontaminato. Fa sì che non venga sfiorato dalle trame ordite da chi lo circonda. Abbi cura di lui, Horus, onnipotente dio con la testa di falco.»
Mar Mediterraneo, 1335
Il falco si posò con un rumoroso battito d’ali. Il Muqatil rimase a osservarlo in silenzio, ammirando gli splendidi colori dell’animale. Il giallo delle piume pettorali andava via via sfumando, per diventare un marrone chiaro e lucente sulle possenti ali. Gli occhi dell’uomo e quelli dell’uccello si incontrarono per un solo istante: due predatori non riescono a sostenere a lungo l’uno lo sguardo dell’altro. Rimasero così: il guerriero, stanco dopo una battuta di caccia, a osservare il villaggio da lui voluto, e il falco, a poca distanza, appollaiato con i suoi artigli d’acciaio su uno sperone di roccia. Non c’era diffidenza, né negli occhi color cobalto dell’uomo, né in quelli gialli del rapace. L’emiro gli lanciò un pezzo di una lepre che aveva appena catturato. Il falco dispiegò le ali e raccolse il boccone col becco. Invece di allontanarsi, il maestoso animale rimase fermo. I suoi occhi osservavano l’uomo con curiosità. Il Muqatil lanciò un altro boccone, questa volta più vicino. Allungò una mano e il falco lasciò che lo accarezzasse.
Читать дальше