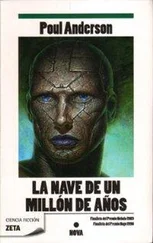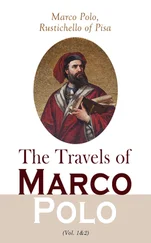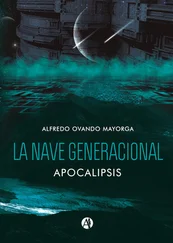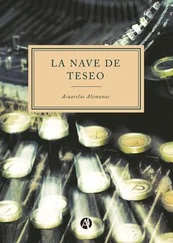Crespi e Humarawa avevano assistito alla cerimonia dello sposalizio dalla piazza. La folla cominciò a disperdersi e stava per scendere la sera. I due si incamminarono verso la casa del mercante veneziano, addentrandosi tra i sentieri in terra che costeggiavano i canali. Al calare della tramontana, una leggera nebbia era scesa tra le calli. L’animazione su un ponte dinanzi a loro li costrinse a rallentare il passo.
Il ponte era privo di balaustre e due uomini si stavano fronteggiando nella lotta, istigati dai presenti che urlavano a squarciagola incitamenti e l’ammontare delle scommesse.
Uno dei due chinò la testa violentemente, battendo con la fronte sul naso dell’altro. Quello che era stato colpito si portò d’istinto le mani alla faccia: immediato il sangue sgorgò tra le sue dita. L’altro non ebbe pietà e, approfittando dell’avversario ferito e disorientato, gli affibbiò un calcio al basso ventre e un pugno dietro l’orecchio. Il malcapitato, privo ormai di sensi, cadde a peso morto nel canale, subito seguito da alcuni amici che cercarono di impedire che annegasse.
Il vincitore alzò le mani in segno di trionfo, poi girò il suo volto inquietante verso i presenti e gridò con voce tonante, rotta dall’affanno: «Chi vuole ancora sfidarmi? Chi vuole assaggiare le acque della laguna?» Nessuno tra gli spettatori, visibilmente intimoriti, raccolse la sfida.
Approfittando del momento di pausa tra quello che pareva essere uno dei divertimenti preferiti tra i popolani, Crespi e Humarawa si avviarono verso il ponte per attraversarlo.
«Vuoi forse essere tu il prossimo tuffatore, strano uomo senza occhi e vestito come una bambola di pezza?» Lo sguardo del vincitore era quello di un pazzo sanguinario, mentre, eccitato dal trionfo, sfidava Hito Humarawa.
Il samurai non prestò attenzione al pugno minaccioso che l’altro stava mulinando davanti al suo volto e tentò di oltrepassare il ponte. Ma quello fece per colpirlo alle spalle, scatenando così la reazione del giapponese. Humarawa si scansò di lato, afferrò il braccio dell’assalitore e fece volare in aria il lottatore come un fuscello. Tutti i presenti presero a ridere per la magra figura che stava facendo l’idolo della lotta, mentre questi si rialzava preparandosi a una nuova carica.
Ancora una volta, Humarawa fu rapido come una folgore nel parare i colpi e reagire e, di nuovo, l’uomo si ritrovò a terra tra scoppi di risate.
L’ira sembrava aver reso folle il lottatore. Sottrasse una sciabola dalla cintura di uno dei presenti e, con gli occhi colmi di odio, si avventò per la terza volta contro Hito Humarawa.
«Adesso morirai, orientale!»
Il sibilo dell’acciaio della katana che veniva sguainata suonò sinistro. Il samurai si servì dell’impeto stesso dell’assalitore per aumentare la forza del suo colpo. Un istante dopo lo scontro, il corpo del lottatore cadeva esanime sul piano di legno del ponte.
I notabili più influenti erano riuniti dinanzi al doge.
«Ho deciso di restaurare il Consiglio dei Dieci: il momento è difficile e grave. Ritengo quindi necessario ridare vita ai Decem Sapientes , in modo che questi assumano la suprema tutela della quiete e della libertà dei sudditi. Parimenti, chiederò a questo tribunale dotato di ampi poteri di sorvegliare sulla regolarità dei traffici e di porre rimedio alle scorrerie corsare. Uomini come il Muqatil non possono continuare a prendersi gioco della più temuta potenza marinara del Mediterraneo.»
Angelo Campagnola sorrise tra sé. Quasi certamente a lui sarebbe toccato uno dei dieci seggi.
Da quando aveva lasciato le coste dell’Al-Andalus, il Muqatil si era dovuto preoccupare di trovare un rifugio ai suoi e un porto sicuro alle sue navi.
I lavori su quell’isola disabitata, posta quasi al centro del mare Egeo, all’estremità meridionale delle Cicladi, si erano protratti a lungo. Dieci squadre di uomini erano state dislocate in pianta stabile nell’isola occupata dal Muqatil per costruire la nuova base.
Nel frattempo le razzie per mare non avevano subito alcun rallentamento: doppiato il Peloponneso, le navi saracene incrociavano le rotte dello Ionio, le stesse che i veneziani percorrevano per i commerci con l’Oriente.
Il Muqatil sapeva che la permanenza nell’isola degli oltre cinquecento uomini ai suoi ordini era temporanea. Quella base poteva essere utilizzata soltanto fino al momento in cui sarebbe rimasta segreta. Non appena gli infedeli avessero saputo dove si nascondeva una delle peggiori minacce della cristianità, avrebbero attaccato con grande spiegamento di forze il suo rifugio. Per questo l’emiro voleva che il villaggio fosse protetto da ogni assalto.
La naturale conformazione del cono vulcanico spento, al centro dell’isola, sembrava favorire l’idea del condottiero saraceno: le pareti della montagna erano, dal lato verso il mare, tanto scoscese e insidiose da sembrare impraticabili. Dall’altro lato, invece, il cono era collassato, aprendo un’insenatura naturale che, oltre a dare protezione alle navi, degradando dolcemente verso l’interno della caldera, sembrava il luogo ideale per insediarvi un villaggio. E così era stato: in breve tempo, i migliori maestri d’ascia avevano addestrato falegnami e carpentieri e, a distanza di quasi un anno, erano sorte case e strade, protette da un’alta palizzata che, disposta a semicerchio, chiudeva quasi ermeticamente l’accesso al centro abitato. Quello era il luogo in cui avrebbero trovato rifugio gli uomini al ritorno dalle scorrerie, il porto nel quale effettuare le riparazioni alle navi e la base di partenza verso i mercati saraceni per buona parte delle merci razziate.
Il Muqatil si voltò verso il villaggio e non riuscì a trattenere un’espressione compiaciuta: anche se gli infedeli avessero scoperto il suo rifugio, i suoi uomini sarebbero riusciti a resistere a lungo. Già, i suoi uomini. Gente fedele sino alla morte, esperta nell’uso delle armi, come nelle tecniche di battaglia. Guardò i volti dei compagni di tante battaglie: conosceva difetti e pregi di ognuno di loro.
«Adesso che abbiamo una casa», disse il Muqatil ai suoi dopo averli riuniti, «dobbiamo darle vita e, perché questo avvenga, sono necessarie delle donne. Però non penso che delle donne possano sbarcare su quest’isola dimenticata da Dio, per cui dobbiamo andarcele a cercare.»
Un urlo di gioia salutò le parole del condottiero.
La nave in partenza da Venezia era la stessa che aveva condotto Angelo Campagnola al ritorno dal suo viaggio a Costantinopoli in compagnia di Crespi e dei due orientali.
Diletta osservò la murata che superava in altezza il calpestio della banchina, con l’identica angoscia con cui si guardano le mura della prigione in cui si sta per essere reclusi.
«Ti benedico, figlia mia», disse Campagnola poggiando le mani sulla fronte della ragazza. «Un destino fulgido e sereno ti attende.»
«Un destino…» pensò Diletta, quando la nave, mollati gli ormeggi, si diresse verso il mare aperto. «Un destino… Avrò mai un destino? Rivedrò mai la città che amo o dovrò accarezzare per sempre la pelle avvizzita del vecchio a cui sto andando in sposa?»
Angelo Campagnola osservò la cocca allontanarsi: per impegni nel Consiglio dei Dieci non avrebbe potuto partecipare al matrimonio della figlia. Si sentiva ugualmente felice: il suo patrimonio personale aveva già subito un notevole incremento in virtù della parentela che si apprestava a stringere attraverso quell’unione. «Vai con Dio e sii felice», mormorò il notabile veneziano, mentre la nave scompariva all’orizzonte.
La flotta del Muqatil si era arricchita di due nuove unità, sottratte ai veneziani nel corso di uno degli innumerevoli scontri. Mentre il dromone rimaneva la sola imbarcazione da battaglia, con la quale venivano compiute le scorrerie, le altre quattro erano destinate al ruolo di navi appoggio e adibite al trasporto dei consistenti bottini razziati agli infedeli.
Читать дальше