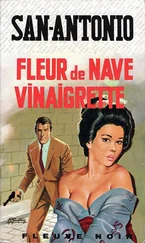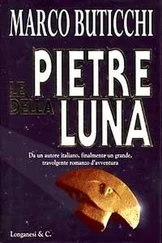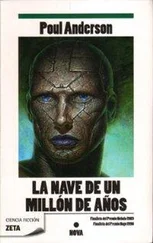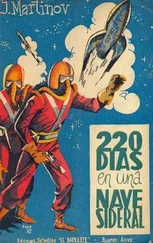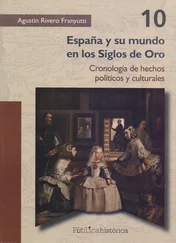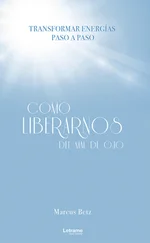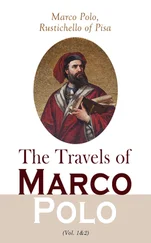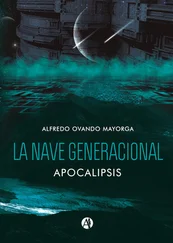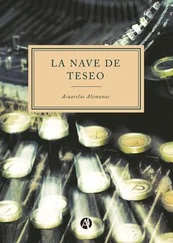«Certo, questo varrebbe qualora ci trovassimo di fronte a una scoperta interessante. Se invece nei papiri dovesse essere annotata la lista della spesa di una matrona romana, ogni necessità di riservatezza sarebbe superata.»
«Già, ma io non credo che una casalinga dell’antichità possa aver reputato così importanti le proprie faccende domestiche da trascriverle su papiro, numerare e proteggere i volumina , sigillarli in un’anfora e imbarcarli su una nave, magari una nave d’oro che sta andando incontro a un naufragio.»
«Una bella storia, Henry. Rimane soltanto una cosa da fare per verificare immediatamente la sua veridicità…». L’espressione di Grandi assunse un’aria quasi infantile, simile a quella del bambino che, ottenuto un buon voto, chiede alla madre la ricompensa.
«Mi ha convinto, ammiraglio», disse Vittard con un sorriso. «Anche perché nemmeno io sono del tutto sicuro di poter dominare la mia curiosità fino all’eventuale verdetto della dottoressa Terracini.»
I due uomini scelsero con cura il rotolo che meno presentava i segni del tempo. Lo disposero sul tavolo da pranzo e, con molta attenzione, iniziarono a rimuovere l’involucro che proteggeva il foglio di papiro.
L’antico supporto scrittorio era estremamente fragile. Il papiro ingiallito dal tempo emetteva preoccupanti scricchiolii a mano a mano che i due uomini lo srotolavano con la delicatezza di solito riservata al corpo di un neonato.
«Penso che sia sufficiente, ammiraglio.» Henry indicò la parte srotolata adagiata sul tavolo. «Se osassimo oltre, correremmo il rischio di mandare in briciole un documento antichissimo. A giudicare da quanto rimane ancora arrotolato, credo si tratti di un papiro abbastanza lungo… una dozzina di metri, direi… per un totale di circa venti fogli scritti in verticale.»
«Se non erro», aggiunse Grandi, «gli antichi usavano squadrare e tracciare linee guida sul papiro utilizzando una rondella di piombo, ma prima l’intero rotolo veniva spalmato con olio di cedro per prevenirlo dalla muffa e salvaguardare nel tempo l’inchiostro.»
«E a giudicare dai risultati sembra siano riusciti perfettamente nell’intento», concluse Henry indicando il foglio.
L’inchiostro rosso dei titoli era perfettamente riconoscibile, anche se i secoli trascorsi avevano ingiallito il supporto e inscurito i contorni. Le uniche parole in lingua latina erano quelle che si riferivano alla catalogazione del volume, alla datazione e a un’intera frase sottostante, forse un epigramma, al centro della pagina. Tutto il resto del testo era invece in lingua greca antica, ed era scritto quasi certamente con l’ atramentum , un liquido nero usato dagli scribi e ottenuto da una mescolanza di fuliggine, pece, resina e nero di seppia.
« Volume quarto. Anno ottocentodue dalla fondazione di Roma. » Grandi lesse le poche righe in latino ad alta voce: « Ducunt volentem fata, nolentem trahunt » .
« Il destino conduce per mano chi lo segue, trascina a forza chi gli si oppone. L’anno, per l’era cristiana, corrisponde al quarantanove dopo Cristo», tradusse seduta stante Vittard, facendo rapidamente i conti. Poi, Henry affrontò il testo greco, non senza difficoltà. « ’Perché, Lisicrate’, mi chiese un giorno il piccolo Lucio Domizio, ‘Pitagora raccomandava di non mangiare i baccelli delle fave?’ Quelle erano le domande che avevano il potere di lasciarmi perplesso: Lucio Domizio aveva la particolarità di saper cogliere gli aspetti insoliti di qualsiasi insegnamento e la sua innata curiosità era capace di trasformare un fanciullo rosso di capelli e corpore maculato [ovvero lentigginoso] nel più coraggioso esploratore dell’inconsueto. ‘Perché Pitagora credeva nella metempsicosi, la trasmigrazione delle anime, e considerava i baccelli alla stregua di feti in procinto di reincarnarsi’, avevo risposto io, convinto di aver saziato la sete di conoscenza del mio giovane allievo. »
«La data corrisponde e il nome, Lucio Domizio, anche. Credo che ci troviamo davanti al diario di uno dei tanti precettori del futuro imperatore romano. Mi auguro che Sara Terracini sia in grado di darci una mano, e spianare la strada di quella che mi sembra davvero una scoperta archeologica senza precedenti.»
Mar del Giappone, 1333
La nave dei wako poteva essere ritenuta una delle tante imbarcazioni commerciali che affollavano il porto di Ching Tao, nel mar Giallo. Crespi si era servito più volte di quella base di partenza per spedire gli oggetti e le stoffe che esportava a Venezia. Sapeva che, periodicamente, dal porto cinese salpavano navi dirette nel golfo Arabico. Da lì sarebbe stato facile raggiungere Costantinopoli e, quindi, la città lagunare.
«Abbiamo ancora davanti un viaggio lungo e faticoso, Hito. E se mantieni questo silenzio per gli oltre duecento giorni che potrebbe durare, rischi di farti rimarginare le labbra come i lembi di una ferita», disse Crespi, cercando di riscuotere il samurai dai suoi pensieri.
Il mercante veneziano sapeva che ben pochi guerrieri giapponesi erano fuggiti dinanzi al suicidio riparatore della vergogna. Per la mentalità del samurai, quello poteva considerarsi un comportamento tanto vile da risultare inaudito. Era altrettanto convinto che la bella Venezia e la sua vita cittadina sarebbero riuscite a cancellare quei ricordi dalla mente del compagno. In tutti i casi, ciò che aveva spinto Crespi a convincere Humarawa alla fuga era un semplice calcolo di sopravvivenza: morto il daimyo, anche l’esistenza del suo più stretto collaboratore valeva quanto un soldo di latta.
Humarawa si volse verso di lui: un uomo di ghiaccio non poteva sciogliersi al primo calore. I suoi occhi scuri si fissarono in quelli del mercante veneziano.
«Ormai sono considerato un ronin. Devo abituarmi a vivere come un rinnegato.»
I ronin erano samurai senza terra e senza padrone che, per la morte del signore al quale avevano giurato obbedienza o, più raramente, per esser sopravvissuti al disonore, erano costretti a vagare, spesso trasformandosi in briganti sanguinari.
Wu, il mastodontico pirata cinese, interruppe la conversazione tra i due.
«Chiedo perdono, mio signore», disse tra i sibili che emetteva dopo lo sfregio provocatogli da Crespi. «Io vorrei seguirti nel tuo viaggio. Darei la mia vita per te, Hito Humarawa, e nessuno mi aveva mai battuto in combattimento, prima che il mercante veneziano diventasse il tuo Hatamoto, il tuo dipendente di fiducia. Credo voi possiate aver bisogno del grande Wu e della sua forza.» Le mani che avevano strozzato senza alcuna pietà uomini e donne si strinsero in segno di preghiera. Le parole erano uscite dalla bocca deforme del gigante come la poesia esce dalle labbra di un bambino. Quella supplica non fece leva sull’anima di Crespi o di Humarawa, ma aprì una breccia nelle loro menti di freddi calcolatori.
Wu poteva tornare utile. Era forte e coraggioso e avrebbe potuto dare verosimiglianza all’identità che Humarawa avrebbe assunto nel corso del viaggio: quella di un ricco mercante giapponese che, in compagnia del suo socio veneziano, si recava in Occidente per valutare nuove opportunità commerciali. E un servo fedele avrebbe reso più credibile il personaggio agli occhi dei curiosi, pronti a vibrare un pugnale nella schiena per incassare la consistente taglia che Ashikaga aveva sicuramente posto sulla testa del daimyo traditore.
La giunca prese il largo una ventina di giorni più tardi. Crespi, che già più volte aveva percorso quella rotta, cercava di catturare l’attenzione del compagno descrivendo l’itinerario, i porti che avrebbero toccato o le meraviglie di quell’imbarcazione, grande almeno cinque volte una normale nave commerciale d’Occidente e capace di caricare nelle sue stive un’infinità di merci.
Читать дальше