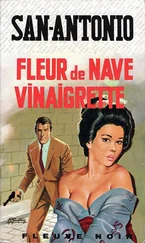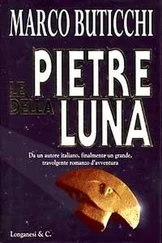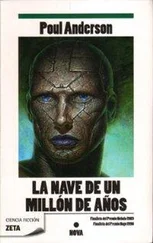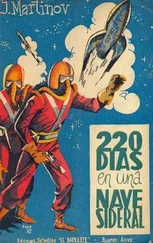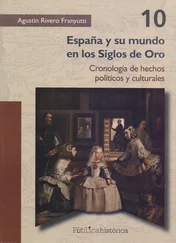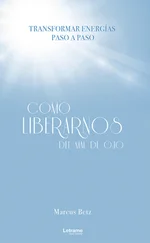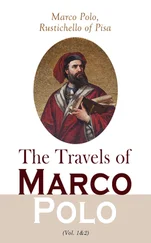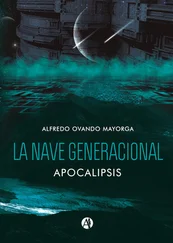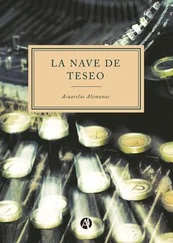Lisicrate avrebbe poi saputo che la casa di Agrippina, oltre a essere un luogo frequentato d’abitudine dai potenti, era un ritrovo particolarmente gradito dagli ospiti: i cibi erano prelibati e i migliori cuochi della capitale si alternavano in cucina per assecondare i desideri della loro padrona e degli illustri convitati. Ogni primizia e rarità culinaria compariva sulle tavole imbandite a fianco dei triclini ricoperti di cuscini soffici e pregiate stoffe orientali. Nel corso delle cene i commensali, accuratamente selezionati dalla padrona di casa, potevano gustare il migliore garum di sgombri proveniente dall’Iberia, miele dell’Imetto di Atene, ogni tipo di spezie e anche un dolcificante tanto raro quanto prezioso, ottenuto dalla distillazione di particolari canne dell’Egitto, che talvolta sostituiva l’immancabile miele.
Lisicrate notò che erano presenti soltanto quattro donne, rispetto ai ventuno ospiti adagiati sul lato sinistro: i romani non vedevano di buon grado la presenza di esponenti del sesso femminile ai banchetti e le signore erano accolte a patto che tenessero un comportamento ineccepibile nel corso della cena, non si saziassero a volontà, bevessero poco vino mielato e non si insudiciassero le mani e la faccia nel gustare le pietanze. In un angolo della sala, cinque scissores si occupavano di tagliare le carni in bocconi non troppo grandi da servire agli invitati, mentre una moltitudine di schiavi si aggirava fra i triclini, sorreggendo chi brocche d’acqua profumata per lavarsi mani e viso, chi piatti succulenti composti su vassoi in argento con effetti scenografici degni dei giochi del circo.
Giulia Litia diresse risoluta verso il triclinio centrale, dove si trovavano due uomini e una donna di bell’aspetto.
Agrippina parlava affabilmente con il commensale alla sua destra, aveva i capelli acconciati in riccioli e un diadema d’oro e pietre dure le coronava il bel viso all’altezza della fronte. A vederla, Lisicrate giudicò che fosse alta, con fianchi rotondi e seni piccoli ma proporzionati. Aveva gli occhi di un verde penetrante e uno sguardo fiero e volitivo.
«Questo è il giovane greco venuto ad aiutare Cherèmone, Anneo», disse Agrippina all’uomo che stava alla sua sinistra, non appena Giulia Litia condusse Lisicrate davanti alla sua signora.
Il greco rimase in piedi, mentre gli occhi di Agrippina e dell’altro commensale lo stavano esaminando. Gli altri invitati non vi prestavano grande attenzione, invece, e si attardavano a elogiare il gusto di una scrofa ripiena cotta nel latte.
«Così, tu saresti l’indispensabile collaboratore della biblioteca di Alessandria?» chiese l’uomo, guardandolo con aria distaccata.
Colui che lo stava interrogando dimostrava poco più di cinquant’anni, aveva un fisico ancora prestante e portava i capelli corti e curati, con una frangia che gli accarezzava la fronte.
«Mi chiamo Lisicrate di Atene e sono onorato di offrirti i miei servigi, signora.» In maniera quasi irriverente, anche se conforme all’educazione, il giovane si rivolse direttamente ad Agrippina.
«Vedremo quanto il tuo sapere potrà essere utile al giovane Lucio Domizio.» Di nuovo era l’uomo a parlare, e ora il suo sguardo sembrava volere soppesare Lisicrate.
«Non essere così severo con lui, Seneca», sorrise Agrippina con tono scherzoso. «Il nostro giovane precettore è appena giunto in città da un lungo viaggio e, a detta di Cherèmone, sarà perfettamente in grado di occuparsi di Lucio Domizio, anche perché avrà persone esperte come te a indicargli la strada.»
In quell’istante un servo si accostò all’orecchio di Agrippina. Questa ascoltò attentamente le parole che le venivano sussurrate, poi richiamò tutti i presenti e disse ad alta voce: «Ho appreso adesso la notizia che Claudio sta rientrando da Ostia in tutta fretta: Messalina ha passato ogni limite. Per festeggiare il suo matrimonio bigamo con Sillio, ha organizzato un baccanale orgiastico nelle stanze della residenza imperiale».
Tutti si produssero in espressioni di meraviglia. A Lisicrate non sfuggì l’aria di soddisfazione e compiacimento che traspariva dagli occhi di Agrippina che si erano fissati su quelli di Seneca.
Isole Egadi, ottobre 2001
Vittard e Grandi avevano assicurato il reperto al cavo della mancina elettrica, posta a poppavia tra i due scafi del C’est Dommage. Avrebbero atteso che scendesse l’oscurità per recuperare l’oggetto dal fondo: era sempre meglio agire al riparo da sguardi curiosi, quando si trattava di ritrovamenti relativi al patrimonio archeologico.
Terminata l’operazione di imbracatura, Grandi aveva raggiunto Henry a bordo del catamarano, dove lo skipper l’aveva preceduto per manovrare il braccio della mancina. Una volta svestita l’attrezzatura subacquea, l’ammiraglio raggiunse Vittard nel salotto della tuga, uno degli ambienti che erano stati ottenuti nel corso dei lavori di rifacimento collegando tra loro i due galleggianti con una struttura dotata di ampie finestre.
Henry si era tuffato nella lettura e confrontava le figure di un testo di archeologia con il disegno dell’anfora appena recuperata sott’acqua.
«Ci siamo, ammiraglio», disse poi, porgendo il volume a Grandi. «Guardi qua. Sembrerebbe identica a quella che abbiamo rinvenuto.»
L’ammiraglio confrontò i due disegni e, annuendo, confermò: «Stando a questa descrizione, pare che abbiamo ritrovato un’anfora costruita nella Spagna meridionale a collo svasato e con spalle poco marcate. E, quello che più ci interessa, è che tali anfore venivano usate in un periodo ben definito, che va dal primo al secondo secolo dopo Cristo».
«Già», intervenne Vittard, «un’ulteriore prova alle sue supposizioni, ammiraglio. È una vera fortuna che le anfore, modellate con terre ad alto contenuto metallico e quindi soggette a un’ulteriore ossidazione in acqua, ‘rispondano’ in molti casi al metal detector. Altrimenti la nostra scoperta poteva rimanere nella sabbia per altri duemila anni.»
«Ho avuto modo di osservare appena l’anforisco sott’acqua. Mi sembra non rechi marchi o signacula di sorta.»
«È vero. Non ci sono segni per accertare l’appartenenza o l’origine del manufatto, ma mi sembra che sia l’anfora sia il tappo siano in ottime condizioni e forse l’anforisco ha svolto il suo compito per secoli, sigillando in maniera stagna il contenuto.»
«Può darsi, non sono rari i rinvenimenti di anfore con miele o vino perfettamente conservati al loro interno. Che cosa crede potremmo trovare, Henry? Sempre ammesso che la chiusura ermetica dell’anfora abbia tenuto.»
«Magari stasera ceneremo con dell’ottimo garum proveniente dalle coste iberiche.»
«Io non so perché quella brodaglia di pesce sotto sale fosse ritenuta una prelibatezza nella cucina romana. Non mi consideri nel calcolo degli invitati alla cena, Henry», rispose Grandi sorridendo.
L’oscurità calava rapidamente. Grandi e Vittard attesero che il buio avesse reso indefiniti i contorni, poi, non senza trepidazione, Henry azionò il meccanismo elettrico che consentiva di riavvolgere il cavo metallico della mancina. Pochi istanti più tardi l’anfora brandeggiava nei pressi della tuga dove Vittard aveva disposto un treppiede in legno che avrebbe fatto da piedistallo.
Grandi sorrise, una volta che l’antico manufatto fu deposto sano e salvo a bordo del C’est Dommage. Con aria di scherno citò a memoria un articolo della legge, risalente al 1939, con cui lo Stato italiano disciplinava le scoperte archeologiche.
« ’Chiunque scopra fortuitamente reperti archeologici deve farne immediata denuncia alle autorità e provvedere alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti’… Be’, non stiamo proprio agendo ai sensi della legge…»
Читать дальше