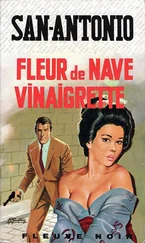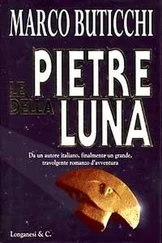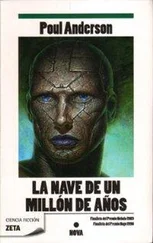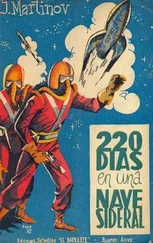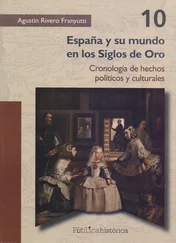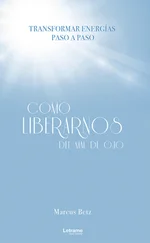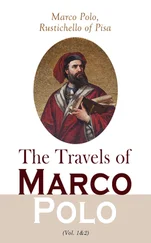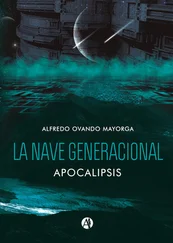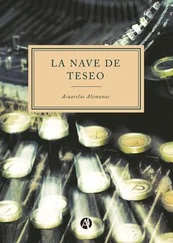Mar Mediterraneo, settembre 2001
Un vento teso increspava il mare all’interno della baia della Girolata, nella Corsica settentrionale. Il C’est Dommage stava all’ancora, meraviglia della tecnologia inserita nello spettacolo della natura. Le rocce rosse che si innalzavano sull’acqua vi si inabissavano in maniera altrettanto repentina.
Henry Vittard prese in mano il reperto che uno dei suoi ospiti aveva appena ripescato da una profondità di quaranta metri. Era una moneta antica, quasi certamente di scarso valore e, comunque, talmente consunta da renderne pressoché impossibile l’identificazione. Henry la strinse tra le dita, la osservò per qualche istante. L’oggetto sembrava volergli comunicare la sua storia, che poteva esser fatta di tempeste e di battaglie, di un semplice smarrimento o di una disattenzione.
L’intensa attività dei mesi estivi non aveva consentito a Henry di ripensare al singolare incontro avvenuto qualche mese prima con l’ammiraglio italiano. Il ritrovamento di quella moneta gli diede modo di ritornare con il pensiero a Guglielmo Grandi e alla nave d’oro.
Henry era certo della buona fede di quell’uomo di mare. Credeva però che la fantasia di Grandi avesse galoppato troppo. La certezza che le sette monete d’oro, sia pure di indubbio valore, facessero parte di un tesoro presupponeva una dose smisurata di ottimismo.
Eppure Henry decise di accogliere l’invito dell’ammiraglio. Appena terminato il noleggio in corso, si sarebbe recato a visionare di persona i reperti che Grandi aveva rinvenuto.
Genova si snodava con le sue strade tortuose in un saliscendi di ardite costruzioni. A mano a mano che Vittard, camminando a piedi per le vie strette, si avvicinava al porto, ne distingueva gli odori e i rumori. I vicoli si facevano sempre più angusti. Finalmente Henry giunse a destinazione, di fronte a un bel palazzo ottocentesco. Salì le scale e Grandi gli aprì la porta.
La casa dell’ammiraglio era costellata dei ricordi di una vita spesa sul mare. Grandi fece strada fino alla sala. Vittard notò dei bagliori su un tavolo, si avvicinò. Con meticoloso ordine erano disposti alcuni oggetti, un tempo lucenti, ma ancor oggi capaci di infondere quella strana sensazione di inarrestabile desiderio che solo il più nobile tra i metalli riesce a suscitare.
C’erano chiodi per carena, alcune barre e un oggetto più grande, simile a un grosso dito, del peso di oltre tre chilogrammi.
Henry si soffermò in silenzio dinanzi al tavolo. Nel corso della sua seppur occasionale carriera di archeologo subacqueo, non aveva mai visto nulla di simile. I manufatti, una trentina in tutto, avevano in comune il metallo con il quale erano stati forgiati. Vittard prese in mano un chiodo ritorto.
«Lei, ammiraglio, è convinto si tratti di oro?»
«Nei chiodi la percentuale è relativamente bassa, attorno al quattro per cento. Il titolo aureo si alza invece negli altri oggetti.» Grandi sollevò una delle barre, lunga circa settanta centimetri. «Queste che, a parer mio, dovevano essere le battagliole arrivano a una percentuale d’oro del trenta-trentacinque per cento. La cosa che mi sembra più importante», continuò Grandi, «è il procedimento con cui sono stati fusi i metalli: sembrerebbe del tutto simile a quello utilizzato in Oriente, in Cina per la precisione, per i manufatti destinati alla vita quotidiana degli imperatori. L’oro, nel corso di questi speciali procedimenti di fusione, tende a depositarsi nel lato esterno dell’oggetto, formando una patina di spessore variabile. Si immagini, Vittard, l’effetto ottico che una nave simile doveva produrre: un’imbarcazione di una sessantina di metri, larga poco meno di venti, interamente rivestita d’oro, ricca di statue e fregi anch’essi realizzati con leghe del nobile metallo.»
Gli occhi di Henry si fissarono su un punto della stanza. La sua mente incominciò a elaborare immagini: una nave che solcava le acque, maestosa e sicura, con i remi che si immergevano a intervalli regolari e con il sole che si rifletteva ovunque ed emanava bagliori d’oro.
Vittard sollevò l’oggetto a forma di grosso dito e l’ammiraglio prevenne la sua domanda.
«Credo si tratti di una delle punte del rostro di prora. Ha un titolo d’oro abbastanza alto, attorno al dodici per cento. La sua particolare conformazione ci aiuta anche a datare l’imbarcazione. Attorno al primo secolo dopo Cristo, i rostri perdono la tipica configurazione ‘a cresta’ e vengono forgiati con la forma di dita sovrapposte, magari decorati alla base con sculture o fregi. Il fatto che la punta di un rostro si sia spezzata credo ci possa fornire anche la testimonianza della violenza del naufragio. Anche se penso che, in una nave come quella che ho in mente, la funzione del rostro sia stata decorativa e non militare, il temibile sperone di prora doveva comunque essere costruito con tecniche a prova di urto.»
«Il C’est Dommage è in cantiere per le solite manutenzioni. Ritengo che nel corso della seconda settimana di ottobre potrà essere di nuovo in mare. La mia barca e io stesso siamo a sua disposizione, ammiraglio.»
«Allora penso che ora sia il caso di discutere del suo compenso, Henry… Come le ho detto, le mie finanze…»
«Questa avventura mi affascina, al di là di un eventuale risultato economico. Divideremo equamente le spese, ammiraglio, e se riusciremo a recuperare qualche cosa divideremo anche gli introiti o le eventuali ricompense dello Stato.»
Si guardarono negli occhi. Le loro mani si strinsero con forza. Erano uomini di mare e per loro una stretta di mano valeva quanto una firma sul più elaborato dei contratti.
Mar del Giappone, 1331
L’inseguimento si era protratto per l’intera nottata senza che il comandante della grande giunca cinese riuscisse a seminare i pirati. Le dieci navi dei wako seguivano la preda come un branco di iene incalza un animale ferito. Alle prime luci del mattino, gli inseguitori erano ormai a distanza di voce. Ancora il mercantile tentò una virata per allontanarsi, ma le vele si sgonfiarono, mentre l’equipaggio manovrava. Il vento calò all’improvviso e l’imbarcazione rimase intrappolata nella bonaccia, del tutto indifesa contro l’assalto.
Le imbarcazioni agili e leggere dei wako si avventarono sul mercantile inerme, la abbordarono da ogni lato e gli uomini, armati di sciabole ricurve, superarono con foga le murate e si lanciarono all’arrembaggio.
Alessandro Crespi, ricco mercante ma inesperto nell’arte del combattimento, si era armato con una delle spade che un marinaio gli aveva affidato non appena era iniziato l’inseguimento. Il terrore gli paralizzava le gambe. Un primo pirata lo affrontò. Con la forza della disperazione il veneziano menò un primo fendente, poi un secondo. Il wako arretrava, rendendo vani gli sforzi per colpirlo: sulla sua bocca era dipinto un sorriso di scherno. Poi il sorriso si trasformò in espressione omicida, ma mentre il pirata stava per vibrare un affondo mortale, un membro dell’equipaggio del mercantile lo attaccò provvidenzialmente alle spalle, distraendo l’attenzione dell’assalitore dalla facile preda.
Lo sguardo atterrito del veneziano si posò allora su alcune ceste di vimini che si trovavano a ridosso dell’albero di maestra. Rapido come un fulmine, Crespi si calò dentro la più grande. Aveva il petto scosso dall’affanno e la bocca priva di saliva. Rimase a guardare il massacro attraverso le fessure dell’impagliatura come un coniglio guarda la mattanza dei suoi simili dalla gabbia nella quale è rinchiuso.
Fu sufficiente poco più di un’ora agli oltre duecento pirati per aver ragione dei novanta marinai del mercantile.
Alla fine, stremati e feriti, una ventina tra membri dell’equipaggio e passeggeri stavano ammassati sul ponte, tenuti sotto la costante minaccia delle armi.
Читать дальше