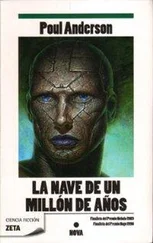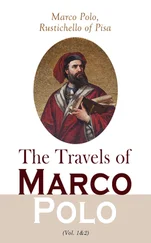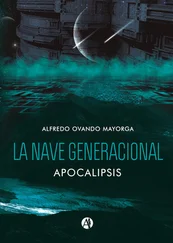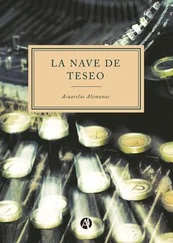Mar del Giappone, 1331
La nave cinese navigava lenta e maestosa. Il mare era calmo e nulla lasciava presagire il pericolo. Le vedette, poste sulla coffa dell’albero di prora, il più basso tra i due, stavano comunque all’erta: il braccio di mare che separava le coste giapponesi da Pusan, in Corea, era infestato dai pirati, i temibili wako.
La nave era interamente costruita in legno di canfora, particolarmente resistente all’azione corrosiva dell’acqua di mare. La prora e la poppa, molto alte, erano destinate ad alloggiare la cucina, i depositi dell’acqua potabile e delle armi, gli alloggi dei passeggeri e degli ufficiali. Al centro dell’imbarcazione si trovava l’imboccatura della stiva, nella quale erano appena stati caricati oggetti di grande valore destinati al mercato europeo, dove i prodotti dell’artigianato cinese venivano considerati di grande pregio.
Il mercante veneziano stava seduto poco distante da uno dei tre timoni di poppa. Osservava il mare con lo sguardo perso nella vastità della distesa d’acqua. Quante volte aveva già percorso quella rotta? Quante volte aveva sfidato il mare del lontano Oriente e i suoi terribili tifoni? Un enorme patrimonio era stato accumulato nei suoi forzieri con quel genere di commercio. Alessandro Crespi aveva poco più di trent’anni e una mente fervida e attenta. Nella sua Venezia aveva fama di mercante privo di scrupoli. A lui poco importava che cosa pensassero i suoi concittadini del suo modo di condurre gli affari. Era un uomo ricco, e questo per lui era sufficiente.
Vestiva in maniera elegante anche a bordo della nave che doveva condurre il carico sino alle coste dell’India, per essere poi da lì stivato su imbarcazioni che avrebbero fatto rotta per l’Europa. Aveva, negli anni, imparato quelle lingue così diverse dalla sua e ormai si esprimeva quasi correttamente in cinese, giapponese e in qualche altro idioma asiatico. Non aveva il fisico di un uomo abituato a combattere: era piuttosto esile e di media statura. La sua scaltrezza lo aveva però sempre tirato fuori dai guai in molte occasioni difficili.
L’urlo si levò alto dalla coffa.
« Wako! » Quella sola parola che la vedetta pronunciò fu in grado di far calare un velo di paura sugli occupanti del mercantile. Dieci velieri si erano appena materializzati all’orizzonte. Avanzavano in formazione serrata. Erano di sicuro più veloci della pesante nave da trasporto. Gli uomini a bordo si prepararono a combattere, pur sapendo che nessuno di loro sarebbe sopravvissuto se i pirati avessero avuto il sopravvento.
Tabarqa, 1331
Yousef era anziano, i capelli grigi si intravedevano sotto il cappello a forma di cono tronco. Nonostante l’età, quando i suoi occhi si posavano sulle cose o sulle persone, sembrava che egli volesse carpire conoscenza da quello che stava osservando. E adesso i suoi occhi erano fissi sul Muqatil.
Aveva destinato gran parte della sua vita a trasmettere ogni sua esperienza nella mente di quel ragazzo dagli occhi color del mare.
Il Muqatil si aggirava lungo il camminamento delle mura senza mostrare cenni di nervosismo. Scrutava la collina nella direzione dalla quale, da lì a poco, sarebbe spuntato il nemico.
Dapprima si levò la polvere, alta sulla cima, poi apparvero gli stendardi e le punte delle lance, una fitta e inestricabile ragnatela di pali, poi i cavalli e, in poco tempo, gli assalitori si schierarono in perfetto ordine dinanzi alla città.
Il Muqatil distolse per un istante lo sguardo e lo rivolse verso Yousef, che stava in disparte alle sue spalle. Il vecchio percorse in silenzio i pochi passi che li separavano. Lasciò correre i suoi occhi lungo le linee nemiche: un fronte imponente e ordinato, pronto a muovere contro Tabarqa. Poi Yousef parlò: «Sono molto più numerosi di noi, mio signore. Ma i nostri uomini non temono la morte, questo è il solo vantaggio che possediamo».
Il Muqatil si volse verso il lato opposto: dall’alto delle mura, poteva vedere buona parte della sua città. Le vie brulicavano di donne e bambini che, abbandonate le case costruite fuori dalla cinta muraria, avevano cercato scampo all’interno della fortificazione. Chi era fortunato poteva ripararsi nell’abitazione di un parente, ma la maggior parte degli sfollati si era dovuta accontentare dell’angolo di una piazza, di un cortile, del fondo di un vicolo, e si preparava a vivere le ristrettezze dell’assedio.
Ogni cittadino aveva però un compito preciso in circostanze come quella: c’era l’addetto a reperire le derrate necessarie alla sopravvivenza, chi raccoglieva l’acqua in secchi per spegnere gli incendi, chi aveva cura dei piccoli mentre i genitori erano impegnati in azioni difensive.
«La vera arma degli infedeli non è la superiorità numerica, ma il fatto di sapere i propri cari al sicuro», disse il Muqatil indicando la popolazione all’interno della città.
Alcuni cavalieri si mossero dallo schieramento nemico. Non appena furono più vicini, il Muqatil riconobbe, al centro del drappello, suo cugino ’Abd al-Hisàm. Uno degli stendardi era stato sostituito da un drappo bianco.
I cavalieri si tennero a una certa distanza dalle mura, quasi al limite della gittata delle frecce, ma sufficientemente vicini perché la voce fosse perfettamente udibile da tutti i soldati del Muqatil schierati e da buona parte della popolazione che aveva trovato riparo sotto l’imponente cinta.
’Abd al-Hisàm, poste le mani a cono sulla bocca, prese a parlare nella loro lingua.
«Lorenzo», chiamò a gran voce, «ti invito ad arrenderti, se non vuoi vedere Tabarqa, che occupi come usurpatore, rasa al suolo e buona parte dei suoi abitanti passati per le armi. O forse poco ti interessa di quegli innocenti, dato che nelle loro vene non scorre il tuo stesso sangue.»
Il Muqatil lo osservava in silenzio, apparentemente calmo. «Non mi rispondi, Lorenzo?» riprese il cugino. «Hai forse paura? Il tuo sangue impuro si sta ribellando? Ancora una volta ti invito alla resa e a restituire la città che hai rubato al suo legittimo emiro.»
«Tu vieni a parlare di inganni e sangue impuro, ’Abd al-Hisàm» — si alzò stentorea e potente la voce del Muqatil —, «scortato da un’armata di infedeli? Se qualcuno ha tradito la nostra gente, quello non sono certamente io.»
«Gente di Tabarqa», gridò ancora ’Abd al-Hisàm, «ribellatevi al traditore che vi governa e consegnatelo a me: vi prometto che nessuno subirà ritorsioni, una volta restaurato il legittimo governo. Consegnatemi quel bastardo fedifrago…»
Dapprima sembrò che un brusio si levasse dall’intera città, come uno sciame d’api che raggiunge l’alveare, poi il rumore si fece forte e musicale. Le donne presero a modulare suoni acuti che riempirono l’aria. Il rumore divenne un frastuono che coprì le parole della delegazione guidata da ’Abd al-Hisàm.
«Dio è grande!» mormorò il Muqatil mentre osservava il cugino che, invertita la marcia, si dirigeva verso le linee nemiche. «Prepariamoci a combattere.»
Alessandria, anno di Roma 794 (41 d.C.)
«Ormai sei un uomo, Lisicrate.» Dagli occhi severi di Cherèmone trasparivano sentimenti di affetto, orgoglio e rispetto. «E credo sia tempo che tu venga iniziato.»
Lo sguardo del giovane si alzò dalla tavoletta di cera. Lisicrate aveva diciotto anni, un’espressione intelligente e un fisico allenato dalle discipline ginniche. Possedeva una cultura notevole. Spesso erano gli stessi saggi a rivolgersi a lui per chiedere delucidazioni. Il giovane ricordava a menadito la collocazione di ogni testo nella biblioteca e, in molti casi, ne conosceva anche il contenuto.
«Iniziato?» domandò il giovane, anche se aveva capito che cosa Cherèmone avesse inteso dire.
«Ai riti di Osiride e al privilegio di far parte di un gruppo ristretto di persone.»
Читать дальше