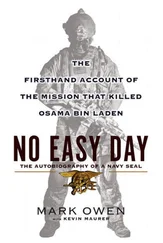Adil aveva superato brillantemente tutte le prove di letteratura, aritmetica, calligrafia, comportamento ed etichetta. Ma erano le arti marziali, gli esercizi con la spada e il tiro con l’arco le specialità in cui il giovane eccelleva.
Come un tempo era accaduto a Humarawa, durante la cerimonia di investitura gli venne consegnata l’armatura di lamelle d’acciaio laccate tenute assieme da fettucce di seta. Adil riconobbe subito che era quella appartenuta al suo maestro, così come il daisho , il baldacchino in legno intarsiato su cui erano collocate le due spade dei samurai.
Le mani di Adil presero dapprima la più lunga, la katana. Quindi le dita si serrarono attorno al manico della più corta, wakizashi , e la inserirono all’interno della cintura, sul fianco opposto rispetto a quello in cui si trovava la katana. Quindi chinò il capo in segno di saluto e di rispetto.
Fu allora che Humarawa parlò: «A questo punto un samurai dovrebbe giurare fedeltà all’imperatore e al sole nascente del Giappone. Questo non è possibile, ma dato che conosco il valore del tuo animo, ti chiedo di formulare un giuramento di fedeltà ai tuoi nobili ideali».
«Io giuro di esservi fedele per sempre, amici miei. Giuro di esser pronto a dare la mia vita per la vostra. Giuro che non avrò pace sino a che non sarà fatta vendetta: la stessa che le anime di mio padre e di mia madre reclamano nei confronti del loro assassino.»
«Capisco la tua foga, giovane Adil: quando avevo la tua età ero ben più focoso e gli argomenti che sollecitavano la lama della mia spada erano assai meno nobili dei tuoi. Ma sono ormai quasi nove anni che viviamo serenamente in questa valle, vedendo crescere le messi e osservando il lento scorrere del fiume. Quindi, pensaci bene prima di inondare nuovamente di sangue il tuo cuore.»
In quel momento, Dewei fece irruzione nella stanza. Il bimbo sembrava sconvolto: «Quell’uomo… quell’uomo ha preso mio fratello! Lo ha immobilizzato e portato via. Ve ne prego, aiutate Po-Sin».
«Calmati, Dewei!» disse sua madre, inginocchiandosi davanti a lui e cercando di capire che cosa fosse accaduto.
«Quell’uomo ha portato via mio fratello Po-Sin, madre!»
«Dov’è successo? Parla, figlio mio», chiese Wu, mentre impugnava una grossa mazza e si dirigeva verso la porta.
«Nel bosco, poco distante da qui. Stavamo giocando quando un uomo è apparso dal nulla e ha afferrato mio fratello», continuò Dewei tra i singhiozzi, «l’uomo è salito su un cavallo che due compari stavano tenendo fermo. Ha detto che un tale Campagnola nutrirà mio fratello sino a quando il figlio del Demonio non si consegnerà a lui. Se ciò non accadrà, smetterà di nutrirlo e mio fratello morirà di fame. Che cosa ha voluto dire, madre mia? Chi è questo Campagnola? Ho paura», disse Dewei scoppiando in lacrime.
Gli uomini si precipitarono fuori con le armi in pugno, salirono sui cavalli e si lanciarono in un inutile inseguimento: i rapitori del piccolo Po-Sin si erano dileguati senza lasciare traccia.
Il vecchio si chinò verso il bambino. La pelle raggrinzita e l’espressione rapace lo facevano assomigliare a un avvoltoio. «Vediamo quanto sei importante per loro, piccolo dagli occhi a mandorla.»
La mano di Po-Sin si mosse con estrema rapidità e le dita del bimbo andarono ad afferrare il naso adunco di Campagnola, insinuandosi nelle narici come artigli.
Campagnola cercò di ritrarsi, in preda al dolore, ma il bambino non mollava l’appiglio. Soltanto quando la mano del veneziano colpì il piccolo al volto il figlio di Wu lasciò la presa.
«Chiudetelo in una cella!» disse Campagnola premendosi un panno sul naso grondante di sangue. «Lasciatelo senza cibo per due giorni.»
Lo sguardo del veneziano si fece perfido: il palazzo sede del tribunale dei Dieci Sapienti era considerato uno tra i più sicuri di Venezia. Da quel luogo era praticamente impossibile riuscire a fuggire. Nel caso di una visita da parte dei due orientali e del figlio del Demonio, Campagnola era rassicurato dal fatto che, nel palazzo, fosse impossibile fare irruzione senza venire passati a fil di lama dal nutrito corpo di guardia.
Campagnola guardò il moncherino del suo indice e sibilò tra i denti: «Ti aspetto, figlio di Satana».
La maestosa cattedrale costruita da re Stefano quasi tre secoli prima si trovava al centro della città di Pécs. Era da tempo che il vescovo della città, Pannonio, avrebbe dovuto recarsi a Venezia in visita diplomatica. Il suo non sarebbe stato un viaggio ufficiale, ma tutti sapevano che il massimo esponente ecclesiastico di Pécs sarebbe stato latore di una proposta di pace da parte di re Luigi d’Ungheria.
Il giovane monaco benedettino si presentò nella cattedrale al vespero. Un anziano curato gli offrì ospitalità e gli chiese il motivo della visita.
«Sono qui per conferire con sua eminenza il vescovo», rispose il frate.
«Mi pare di capire che tu non abbia un appuntamento. Credo ti convenga aspettare sino al prossimo martedì, giorno in cui il vescovo concede udienza. Ma non attardarti oltre: sua eminenza ha in programma un lungo viaggio.»
«È proprio di questo viaggio che vorrei parlare con Pannonio: io vorrei accompagnarlo nel suo pellegrinaggio.»
«Allora la cosa si pone in altro modo, mio buon fratello: il vescovo è alla ricerca di persone giovani e forti che condividano con lui i pericoli e le scomodità del viaggio. Ti farò parlare con lui non appena saranno terminate le preghiere della sera.»
«Dio sia con te!» esclamò il giovane. Gli occhi color cobalto riflettevano la tenue luce delle candele.
Una settimana più tardi la carovana si mise in marcia. Giunti al primo ostacolo gli uomini erano stati obbligati a sganciare gli animali dai gioghi e proseguire a piedi sino a dove il percorso si faceva nuovamente praticabile. Soltanto a quel punto Adil aveva capito che cosa intendesse il curato quando gli aveva parlato della necessità che il vescovo fosse scortato da giovani robusti: l’alto prelato, comodamente seduto su una portantina, veniva trasportato a spalla in tutte le occasioni in cui avrebbe dovuto posare i piedi a terra.
Il canto stridente di una civetta si levò nella notte. Venezia distava ormai pochi giorni di viaggio. Adil si alzò dal giaciglio. Si mosse sino ai limiti del campo e rispose al richiamo: Humarawa e Wu non avevano perso di vista il convoglio nemmeno per un attimo.
«Questa volta non avrai scampo, Campagnola», sussurrò Adil, gli occhi ridotti a fessure colme di odio.
Il vescovo di Pécs era stato ricevuto in forma quasi privata: sembrava che il nuovo doge, Giovanni Dolfin, avesse timore di mostrare eccessiva apertura verso l’eterna nemica Ungheria, ma che al contempo non fosse così deciso a mantenere una posizione di netta inimicizia. Quando era stato eletto con una maggioranza risicata nel corso di una tumultuosa investitura nell’agosto del 1356, erano stati i suoi meriti militari a fargliela spuntare sugli altri contendenti. Il terreno di battaglia avrebbe però presto decretato ben altro verdetto: gli ungheresi incalzavano alle porte di Venezia, i Carrara di Padova espandevano i propri territori lungo il corso del Po, l’Austria era pronta a marciare su Trieste. Entro breve al doge di Venezia, spogliato dei suoi altisonanti marchesati, non sarebbe rimasto che il titolo beffardo di Dux Venetiarum et coetera , «principe delle Venezie… eccetera».
Sembrava invece che il Consiglio dei Dieci avesse compreso pienamente l’importanza della missione del vescovo Pannonio. L’organo che, nei casi in cui il governo legittimo si dimostrava debole, era uso prendere le redini della Repubblica, anche in quel frangente si sarebbe mostrato lungimirante.
Il vescovo stava percorrendo un lungo corridoio al terzo piano del Palazzo Ducale, corridoio sul quale si aprivano la Sala del Consiglio, la Sala dei Tre capi e la Sala della Bussola, là dove venivano deposte le anonime delazioni che sarebbero poi state esaminate dal Consiglio.
Читать дальше