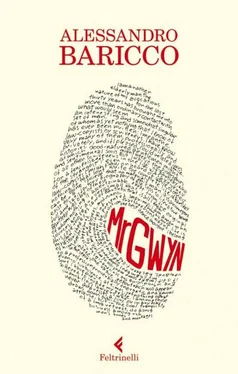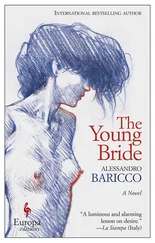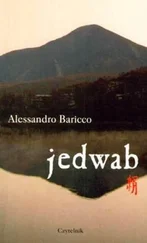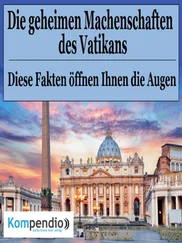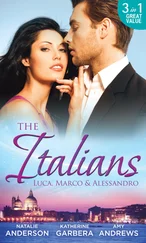– Ci ho pensano, a quella storia dei ritratti… be’, non ho voglia di stare a sentire tante chiacchiere. Mi è venuta un’idea migliore.
Prese la mano di Jasper Gwyn.
– Fallo.
– Cosa?
– Fammi un ritratto. E io capirò.
– Un ritratto a te?
– SÌ.
– Adesso?
– Qui. Hai due giorni. Non starmi a infinocchiare con tutte ste storie che hai bisogno di un mese, e lo studio, e la musica…
Strinse forte la mano di Jasper Gwyn. Era una forza illogica, nessuno avrebbe saputo dire da dove veniva.
– Fallo e basta. Se sai farlo, lo puoi fare anche qui. Jasper Gwyn pensò a un sacco di obiezioni, tutte sensate.
Comprese con lucidità assoluta che era una situazione grottesca, e si pentì di non aver spiegato ogni cosa al momento giusto, che era molto tempo prima, e sicuramente non ora, in quella stanza d’ospedale.
– Non è possibile, Tom.
– Perché?
– Perché non è un gioco di prestigio. È come attraversare un deserto, o scalare una montagna. Non lo si può fare in un salotto solo perché un bambino a cui vuoi bene te lo chiede. Facciamo così: ti operano, tutto andrà a meraviglia e quando torni a casa io ti spiego tutto, giuro.
Tom mollò la stretta sulla mano e per un po’ se ne stette in silenzio. Respirava un po’ affannoso, adesso.
– Non è solo quello, disse alla fine.
Jasper Gwyn dovette chinarsi un po’ per riuscire a sentire bene.
– Mi importa di capire cosa cazzo combini, ma non è solo quello.
Tornò a stringere forte la mano di Jasper Gwyn.
– Una volta mi hai detto che fare il ritratto a qualcuno è un modo di riportarlo a casa. E così?
– Sì, una cosa del genere.
– Un modo di riportarlo a casa.
– Sì.
Tom si schiarì la gola. Voleva che si capisse bene quello che stava per dire.
– Riportami a casa, Jasper.
Si schiarì un’altra volta la gola.
– Non ho molto tempo e ho bisogno di tornare a casa, disse.
Jasper Gwyn alzò lo sguardo perché non voleva guardare gli occhi di Tom. C’erano tutte quelle macchine, e il colore delle pareti, e il timbro dell’ospedale ovunque. Pensò che era tutto assurdo.
– Mi verrà da schifo, disse.
Tom Bruce Shepperd mollò la stretta e chiuse gli occhi.
– Tanto mica credi che te lo pago, disse.
Così, per due giorni e due notti, Jasper Gwyn rimase all’ospedale, senza quasi dormire, perché doveva fare un ritratto all’unico amico che gli fosse rimasto nella vita. Si era sistemato in un angolo, su una sedia, e vedeva passare medici e infermiere senza vederli. Andava avanti a caffè e sandwich, ogni tanto si sgranchiva le gambe in corridoio. Veniva Lottie e non osava dir niente.
Nel suo letto, Tom sembrava diventare più piccolo ogni ora, e il silenzio in cui sopravviveva era simile a una sparizione misteriosa. Ogni tanto si girava verso l’angolo in cui si aspettava di vedere Jasper Gwyn e sempre pareva sollevarlo il fatto di non trovarlo vuoto. Quando lo portavano fuori a fare qualche esame, Jasper Gwyn fissava il letto sfatto e in quel pasticcio di lenzuola gli sembrava di scorgere una forma di nudità così estrema da non aver bisogno neppure più di un corpo.
Lavorava intrecciando ricordi e ciò che ora riusciva a vedere in Tom che mai aveva visto. Neanche per un attimo cessò di essere un gesto difficile e doloroso. Nulla era come nello studio, in braccio alla musica di David Barber, e ogni regola che si era dato lì risultava impossibile. Non aveva i suoi foglietti, gli mancavano le Caterina de’ Medici e faceva fatica a pensare con intorno tutti quegli oggetti che non aveva scelto. Il tempo era insufficiente, rari i momenti di solitudine. Notevoli le probabilità di fallire.
Tuttavia, la sera prima dell’intervento, verso le undici, Jasper Gwyn chiese se c’era un computer, nel reparto, dove potesse scrivere una cosa. Finì in una stanza dell’amministrazione, dove gli diedero una scrivania e la password per entrare nel pc dell’impiegata. Non era una procedura regolamentare e ci tennero a sottolinearlo. Sulla scrivania c’erano due foto incorniciate e una desolante collezione di topini a molla. Jasper Gwyn si sistemò la sedia, che era fastidiosamente alta. Vide con raccapriccio che la tastiera era sporca, e lo era in modo intollerabile nei tasti che si usano di più. Avrebbe detto dovesse accadere il contrario. Si alzò, andò a spegnere il neon centrale e tornò dai topini. Accese la lampada da tavolo. Iniziò a scrivere.
Cinque ore dopo si alzò e cercò di capire dove diavolo era la stampante che, lo sentiva benissimo, stava sputando fuori il suo ritratto. E curioso dove mettano la stampante, negli uffici, quando ce n’è una sola per tutti. Dovette riaccendere il neon centrale per individuarla, e alla fine si ritrovò con nove fogli in mano, stampati in un font che non gli piaceva particolarmente, e impaginato con margini di una banalità offensiva. Tutto era sbagliato, ma anche tutto era come doveva essere – una esattezza frettolosa, a cui era stato sottratto il lusso dei dettagli. Non stette a rileggere, mise solo i numeri alle pagine. Aveva stampato due copie: ne piegò una in quattro, se la mise in tasca, e poi con l’altra in mano andò verso la camera di Tom.
Saranno state le quattro del mattino, nemmeno si mise a controllare. Nella stanza c’era una sola luce accesa, abbastanza calda, alle spalle del letto. Tom dormiva con la testa girata da una parte. Le macchine collegate a lui ogni tanto comunicavano qualcosa e lo facevano emettendo piccoli suoni, odiosi. Jasper Gwyn avvicinò al letto una sedia. Non aveva nessun senso, ma appoggiò una mano sulla spalla di Tom e iniziò a dare degli scrolloni. Non era il genere di cosa che sarebbe piaciuto a un’infermiera di passaggio, se ne rendeva conto. Avvicinò la bocca all’orecchio di Tom e pronunciò un po’ di volte il suo nome. Tom aprì gli occhi.
– Non stavo dormendo, disse. Stavo solo aspettando. Che ora è?
– Non so. Tardi.
– Ce l’hai fatta?
Jasper Gwyn teneva i nove fogli in mano. Li posò sul letto.
– Mi è venuto un po’ lungo, disse. Quando si è di fretta viene sempre tutto un po’ lungo, lo sai.
Parlavano piano e avevano l’aria di due ragazzi che stavano rubando qualcosa.
Tom prese i fogli in mano e gettò un’occhiata. Forse lesse le prime righe. Aveva sollevato un po’ la testa dal cuscino, con l’aria di fare una fatica tremenda. Ma negli occhi aveva qualcosa di sveglio che nessuno gli aveva mai visto, in quell’ospedale. Lasciò ricadere la testa sul cuscino e allungò i fogli a Jasper Gwyn.
– Okay. Leggi.
– Io?
– Devo chiamare un’infermiera?
Jasper Gwyn si era immaginato qualcosa di diverso. Tipo Tom che si leggeva tutto quanto mentre lui se ne tornava a casa a farsi finalmente una doccia. Aveva sempre questo certo ritardo ad ammettere la nuda realtà delle cose.
Prese i fogli in mano. Odiava leggere a voce alta le cose che aveva scritto – leggerle ad altri. Gli era sempre sembrato un gesto senza vergogna. Ma lì iniziò a farlo, cercando di farlo bene – con la lentezza che era necessaria, e la cura. Molte frasi già gli sembravano inesatte, ma si costrinse a leggere tutto proprio come l’aveva scritto. Ogni tanto Tom ridacchiava. Una volta gli fece un cenno, per fermarlo. Poi gli fece capire che poteva proseguire. L’ultima pagina Jasper Gwyn la lesse ancora più lenta, e a dire il vero gli sembrò impeccabile.
Prese i fogli, alla fine, li sistemò, li piegò in due e poi li posò sul letto.
Le macchine continuavano a dare messaggi imperscrutabili, con un’ottusità vagamente militare.
– Vieni qui, disse Tom.
Jasper Gwyn si chinò su di lui. Adesso erano proprio vicini. Tom tirò fuori un braccio dalle coperte e appoggiò una mano sulla testa dell’amico. Sulla nuca. Poi lo strinse a sé – si appoggiò la testa dell’amico sulla spalla e la teneva lì. Muoveva appena le dita, come per essere sicuro di qualcosa.
Читать дальше