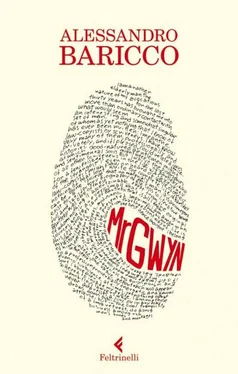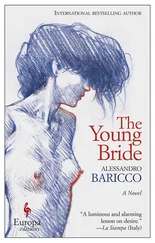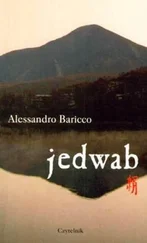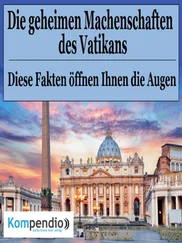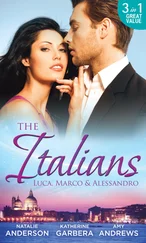– Grazie, disse.
Poi aggiunse che non era stato così difficile. Parve dirlo a se stesso, ma anche si voltò verso Rebecca, come se si aspettasse una specie di risposta.
– No, non è stato difficile, lei disse allora. Disse che nulla, lì dentro, era difficile.
Jasper Gwyn andò a regolare il volume della musica, e il loop di David Barber sembrò sparire dentro ai muri, lasciando poco più che una scia, dietro di sé, nella luce fragile delle ultime sei lampadine rimaste.
L’ultima la aspettarono nel silenzio, il trentaseiesimo giorno di quello strano esperimento. Quando furono le otto, sembrò loro scontato che l’avrebbero aspettata insieme, perché non contava più nessun tempo che non fosse quello scritto nei filamenti di rame generati dal talento folle del vecchietto di Camden Town.
Nella luce delle due ultime lampadine, lo studio era già una sacca nera, mantenuta in vita da due pupille di luce. Quando rimase l’ultima, era un sussurro.
La guardavano da lontano, senza avvicinarsi, come per non sporcarla.
Era notte, e si spense.
Dalle finestre oscurate, passava giusto la luce utile a segnare l’orlo delle cose, e non subito, ma solo all’occhio assuefatto all’oscurità.
Parve ogni oggetto concluso, e solo loro due, ancora, viventi.
Una simile intensità Rebecca non l’aveva mai conosciuta. Pensò che in quel momento qualsiasi gesto sarebbe stato inadatto, ma capì che era vero anche il contrario, e che era impossibile, in quel momento, fare un gesto che fosse sbagliato. Così si immaginò molte cose, e alcune aveva iniziato a immaginarle molto tempo prima. Finché sentì la voce di Jasper Gwyn.
– Credo che aspetterò la luce del mattino qui dentro. Ma lei naturalmente può andare, adesso, Rebecca.
Lo disse con una specie di dolcezza che poteva anche sembrare rimpianto, così Rebecca gli si avvicinò e quando trovò le parole giuste disse che le sarebbe piaciuto restare ad aspettare lì con lui – solo quello.
Ma Jasper Gwyn non disse nulla, e lei capì.
Si rivestì lentamente, per l’ultima volta, e quando fu davanti alla porta si fermò.
– Sono sicura che dovrei dire qualcosa di speciale, ma a essere sincera non mi viene proprio in mente niente.
Jasper Gwyn sorrise nel buio.
– Non si preoccupi, è un fenomeno che conosco molto bene.
Si salutarono stringendosi la mano, e la cosa sembrò ad entrambi di un’esattezza e di un’idiozia memorabili.
Jasper Gwyn ci mise cinque giorni a scrivere il ritratto – lo fece a casa, al computer, uscendo di tanto in tanto per camminare, o mangiare qualcosa. Lavorava ascoltando a ripetizione dischi di Frank Sinatra.
Quando pensò di aver finito, copiò il file su un ed e lo portò da uno stampatore. Scelse fogli quadrati di una carta vergata piuttosto pesante, e un inchiostro blu che sfiorava il nero. Decise l’impaginazione in modo che fosse sufficientemente ariosa senza diventare futile. Per il font si orientò, dopo lunga riflessione, su un carattere che simulava alla perfezione le lettere che una volta uscivano dalle macchine per scrivere: nel tondo delle o c’era anche un accenno di sbavatura dell’inchiostro. Non volle nessuna rilegatura. Si fece fare due copie. Alla fine lo stampatore era visibilmente provato.
Il giorno dopo Jasper Gwyn passò ore a cercare una carta velina che ai suoi occhi apparisse appropriata, e una cartellina con gli elastici non troppo grande, non troppo piccola, non troppo cartellina. Trovò entrambe in una cartoleria che stava per chiudere, dopo ottantasei anni di attività, e svuotava i magazzini.
– Perché chiudete?, chiese, arrivato alla cassa.
– Il titolare va in pensione, rispose, senza emozione, una signorina con certi capelli senza importanza.
– Non ha figli?, insisté Jasper Gwyn. La signorina alzò lo sguardo.
– La figlia sarei io, disse.
– Bene.
– Vuole una busta regalo o è per lei?
– E un regalo per me.
La signorina fece un sospiro che poteva voler dire molte cose. Tolse i prezzi dalle cartelline e infilò tutto in una busta elegante chiusa da un sottile spago dorato. Poi disse che suo nonno aveva aperto quel negozio al ritorno dalla Prima guerra mondiale, investendo tutto quello che aveva. Non aveva mai chiuso, neanche sotto i bombardamenti, nel ’40. Sosteneva di aver inventato lui il sistema per sigillare le buste leccandone un bordo. Ma probabilmente, aggiunse, era una palla.
Jasper Gwyn pagò.
– Non si trovavano più buste come quelle, disse.
– Mio nonno le faceva al gusto fragola, disse lei.
– Sul serio?
– Così diceva. Limone e fragola, ma quelle al limone la gente non le voleva, chissà perché. Io comunque mi ricordo di aver provato, da piccola. Non sapevano di niente. Sapevano di colla.
– La prenda lei, la cartoleria, disse allora Jasper Gwyn.
– No. Io voglio cantare.
– Davvero? Opera?
– Tanghi.
– Tanghi?
– Tanghi.
– Fantastico.
– Lei invece che fa?
– Il copista.
– Fantastico.
La sera Jasper Gwyn rilesse i sette fogli quadrati che, su due colonne, contenevano il testo del ritratto. L’idea era quella di avvolgerli poi nella carta velina e riporli nella cartellina con gli elastici. A quel punto il lavoro era finito.
– Come le sembra?
– Proprio niente male, rispose la signora con il foulard impermeabile.
– Sia sincera.
– Lo sono. Voleva fare un ritratto e c’è riuscito. Francamente non ci avrei scommesso un penny.
– No?
– No. Scrivere un ritratto, che idea è? Ma adesso ho letto i suoi sette fogli e so che è un’idea che esiste. Lei ha trovato il modo di farla diventare un oggetto reale. E devo ammettere che ha trovato un sistema semplice e geniale. Chapeau.
– E merito anche suo.
– Dice?
– Molto tempo fa, forse non se lo ricorda, lei mi disse che se proprio dovevo fare il copista cercassi almeno di copiare la gente, e non dei numeri, o dei referti medici.
– Certo che me lo ricordo. E l’unica volta che ci siamo incontrati in vita mia.
– Disse che mi sarebbe riuscito benissimo. Copiare la gente, dico. Lo disse con una sicurezza priva di ombre, come se non fosse neanche il caso di discuterne.
– Quindi?
– Non credo che mi sarebbe mai venuta in mente questa idea dei ritratti se lei non mi avesse detto quella frase. In quel modo. Sono sincero: non sarei qui, senza di lei.
La signora allora si voltò verso di lui ed aveva la faccia di quando certe vecchie maestre sentono suonare alla porta ed è quel vigliacco del secondo banco che le viene a ringraziare, il giorno che si è laureato. Fece un gesto come una carezza, guardando da un’altra parte, però.
– Lei è un bravo ragazzo, disse.
Rimasero un po’ zitti. La signora con il foulard impermeabile tirò fuori un grande fazzoletto e si soffiò il naso. Poi posò una mano sul braccio di Jasper Gwyn.
– C’è una cosa che non le ho mai raccontato, disse. La vuole sentire?
– Certo.
– Quel giorno, quando lei mi accompagnò a casa… Continuavo a pensare alla storia che lei non voleva più scrivere libri, non riuscivo a farmi passare dalla mente che era un dannato peccato. Non ero nemmeno sicura di averle chiesto perché, o comunque non mi ricordavo che lei mi avesse spiegato veramente come mai non voleva più saperne. Insomma, mi era rimasto qualcosa di traverso, ha presente?
– Sì.
– E durata qualche giorno. Poi una mattina vado dal solito indiano sotto casa, e vedo la copertina di una rivista. C’era tutta una pila di quella rivista, appena arrivata, l’avevano appoggiata sotto le patatine al formaggio. In quel numero avevano intervistato uno scrittore, così sulla copertina c’era il suo nome e una frase, il suo nome bello grande e la sua frase tra virgolette. E la frase diceva: “In amore mentiamo tutti”. Giuro. E guardi che era un grande scrittore, potrei sbagliarmi ma credo che sia addirittura un Nobel. Nel resto della copertina c’era un’attrice non tanto svestita, che prometteva di raccontare tutta la verità. Non ricordo su che stupida faccenda.
Читать дальше