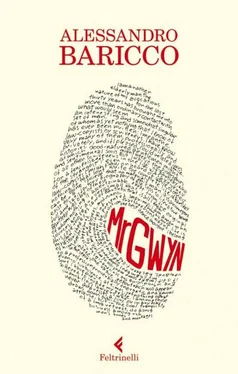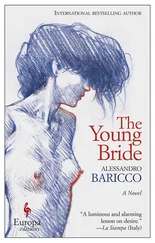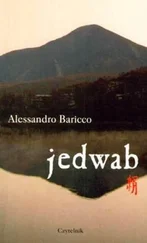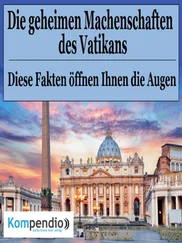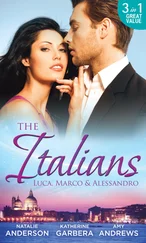Il giorno dopo arrivò in ritardo, apposta: giusto qualche minuto, ma per Jasper Gwyn, lei lo sapeva, era un’enormità. Entrò, e lo studio era deserto. Rebecca si spogliò ma poi non trovò da nessuna parte il cinismo, o la semplicità, per non pensare a nulla – passò il tempo a misurare l’ansia che cresceva. Non riusciva a fare quello che doveva fare – essere se stessa, semplicemente – benché ricordasse benissimo come le era sembrato facile, il primo giorno, quando lui non si era presentato. Evidentemente qualcosa doveva essere successo – come una peregrinazione. Adesso non le riusciva di tornare indietro da nessuna parte, e nessun cammino pareva possibile, d’altronde, senza di lui.
Sei scema, pensò.
Sarà ammalato. Starà lavorando a casa. Forse ha già finito. Forse è morto.
Ma sapeva che non era vero, perché Jasper Gwyn era un uomo esatto, anche nell’errore.
Si sdraiò sul letto, per la prima volta le parve di avere un inizio di paura, a starsene lì da sola. Cercò di ricordare se aveva chiuso a chiave. Si chiese se era sicura che fossero passati davvero tre giorni da quando l’aveva visto l’ultima volta. Ripercorse con la memoria quei tre pomeriggi pieni di niente. Le parve ancora peggio. Rilassati, pensò. Arriverà, si disse. Chiuse gli occhi. Iniziò ad accarezzarsi, prima lentamente, il corpo, poi in mezzo alle gambe. Non pensava a niente di particolare, e questo le fece bene. Si girò leggermente su un fianco, perché era così che le piaceva farlo. Riaprì gli occhi, davanti a sé aveva la porta d’ingresso. Si aprirà e non smetterò, pensò. Lui non esiste, esisto io, ed è questo che adesso mi va di fare, caro Jasper Gwyn. Mi va di accarezzarmi. Entra solo da quella porta, e poi vediamo cosa ti verrà da scrivere. Continuerò a farlo, fino alla fine, non mi importa se guardi. Richiuse gli occhi.
Alle otto si alzò, si rivestì, e tornò a casa. Pensò che mancava una decina di giorni, forse qualcuno di più. Non le riusciva di capire se era poco o tanto. Era un’eternità minuscola.
Il giorno dopo entrò nella stanza e Jasper Gwyn stava seduto su una sedia, in un angolo. Sembrava il custode di una sala, in un museo, che vigilava su un’opera d’arte contemporanea.
Istintivamente Rebecca si irrigidì. Guardò interrogativamente Jasper Gwyn. Lui si limitò a fissarla. Allora lei, per la prima volta da quando tutto era iniziato, parlò.
– Sono tre giorni che non viene, disse.
Poi si accorse dell’altro uomo. Stava in piedi, appoggiato al muro, in un angolo.
Due uomini, ce n’era un altro, seduto sul primo gradino della scala che portava al bagno.
Rebecca alzò il tono di voce e disse che non era nei patti, ma senza chiarire a cosa si stesse riferendo. Disse ancora che lei si riteneva libera di smettere quando le pareva, e che se lui pensava che per cinquemila sterline si potesse permettere di fare tutto quello che gli pareva si sbagliava di grosso. Poi rimase lì, immobile, perché Jasper Gwyn non aveva l’aria di voler rispondere.
– Che merda, lei disse, ma più che altro a se stessa. Andò a sedersi sul letto, vestita, e lì rimase, per un bel po’. C’era quella musica di David Barber.
Decise di non aver paura.
Loro, se mai, dovevano avere paura di lei.
Si svestì con gesti secchi, si alzò, e iniziò a camminare per la stanza. Stava lontano da Jasper Gwyn, ma passava accanto agli altri due uomini, senza guardarli, dove diavolo li avrà presi, pensò. E coi passi calpestava i foglietti di Jasper Gwyn, prima solo passandogli sopra, poi proprio stracciandoli con la pianta dei piedi, sentiva il duro delle puntine graffiarle la pelle – non le importava. Ne sceglieva alcuni, li distruggeva – altri li lasciava sopravvivere. Pensò che sembrava un servitore che la sera spegne le candele, in giro per il palazzo, e ne lascia accese alcune, per un qualche precetto della casa. Le piacque l’idea e a poco a poco cessò di farlo con rabbia, e prese a farlo con la mansuetudine che si sarebbe aspettata da quel servitore. Rallentò il passo, e perse durezza nello sguardo. Continuava a spegnere quei foglietti, ma con una cura diversa, mite. Quando le sembrò di avere finito – qualsiasi cosa avesse iniziato – tornò a sdraiarsi sul letto, e affondò la testa nel cuscino, chiudendo gli occhi. Non sentiva più rabbia, e anzi si stupì di sentire arrivare una sorte di quiete che, capì, stava aspettando da giorni. Nulla si muoveva attorno a lei, ma a un certo punto qualcosa si mosse, dei passi, e poi il secco rumore di una sedia, forse più sedie, spostate accanto al letto. Non aprì gli occhi, non aveva bisogno di sapere. Si lasciò sprofondare in un buio muto, e quel buio era se stessa. Lo poteva fare, e senza paura, e facilmente, perché qualcuno la stava guardando – se ne rese immediatamente conto. Per qualche ragione che non capiva, era finalmente sola, in modo perfetto, come soli non si è mai – o di rado, pensò, in qualche abbraccio d’amore. Finì lontano, perdendo qualsiasi nozione del tempo, sfiorando forse il sonno, a tratti pensando a quei due uomini, se l’avrebbero toccata – e al terzo uomo, l’unico per cui davvero era lì.
Aprì gli occhi, ebbe paura che fosse tardi. Nella stanza non c’era più nessuno. Accanto al letto, una sedia, una sola. Uscendo la sfiorò. Lentamente, col dorso di una mano.
Quando entrò nello studio, alle quattro precise del giorno dopo, la prima cosa che vide furono i foglietti di Jasper Gwyn, di nuovo al loro posto, neanche uno spiegazzato, rimessi a nuovo, con le puntine e tutto. Erano centinaia, ormai. Non sembrava che qualcuno ci avesse mai passeggiato sopra. Rebecca alzò lo sguardo e Jasper Gwyn era lì, seduto per terra, in quella che sembrava essere diventata la sua tana, la schiena appoggiata al muro. Ogni cosa era al suo posto, la luce, la musica, il letto. Le sedie allineate su un lato della stanza, in ordine, tranne quella che ogni tanto usava lui, messa in un angolo, il taccuino dei foglietti posato per terra. Quale sensazione di salvezza, pensò – che mai ho conosciuto prima.
Si tolse i vestiti, prese una sedia, la spostò in un punto che le piacque, non troppo vicino a Jasper Gwyn, non troppo lontano, e si sedette. Rimasero così per lungo tempo, Jasper Gwyn ogni tanto la guardava, ma più spesso fissava qualcosa della stanza, facendo dei piccoli gesti nell’aria, come se inseguisse qualche musica. Sembrava mancargli il suo taccuino, lo cercò un paio di volte con lo sguardo, ma poi in realtà non si alzava a prenderlo, gli andava di rimanere lì, appoggiato al muro. Questo fino a quando, d’improvviso, Rebecca si mise a parlare.
– Questa notte ho pensato una cosa, disse. Jasper Gwyn si voltò a guardarla, colto di sorpresa.
– Sì, lo so, non dovrei parlare, smetto subito. La voce era pacata, tranquilla.
– Ma c’è una cosa stupida che ho deciso di fare. Non ho nemmeno ben capito se la faccio per me o per lei, voglio dire soltanto che mi sembra giusta, come qui è giusta la luce, la musica, è giusto tutto, tranne una cosa. Così ho deciso di farla.
Si alzò, si avvicinò a Jasper Gwyn, e si inginocchiò davanti a lui.
– Lo so, è una cosa stupida, mi scusi. Ma me la lasci fare. E, come avrebbe fatto con un bambino, si sporse verso di lui e lentamente gli tolse la giacca. Jasper Gwyn non oppose resistenza. Parve rassicurato dal fatto di vedere Rebecca piegare la giacca nel modo giusto, e sistemarla per terra con attenzione.
Poi lei gli sbottonò la camicia, lasciando per ultimi i bottoni dei polsini. Gliela sfilò via, e di nuovo la piegò con ordine, appoggiandola sulla giacca. Parve soddisfatta, e per un po’ non si mosse.
Poi si spostò un po’ indietro, e si chinò a slacciare le scarpe di Jasper Gwyn. Gliele tolse. Jasper Gwyn ritirò indietro i piedi perché tutti gli umani maschi si vergognano delle calze. Ma lei sorrise, e gli sfilò anche quelle. Mise poi tutto in ordine, come avrebbe potuto fare lui, stando attenta che ogni cosa fosse allineata.
Читать дальше