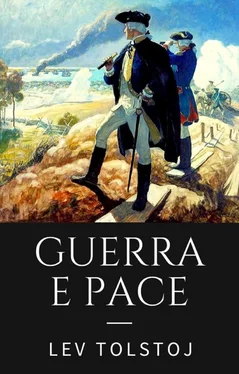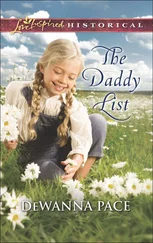— Uh! uh! uh! – esclamò.
— A posto – gridò Dolochow, respingendo l’ufficialotto, il quale, imbrogliatosi con gli sproni, venne a cader goffamente in mezzo alla camera.
Posata la bottiglia sul davanzale, Dolochow, cauto e lento, si arrampicò sulla finestra. Poi, spenzolate fuori le gambe, puntate le mani sull’orlo di questa, cercò l’equilibrio, si acconciò, gettò le mani indietro, e spostandosi ora a destra ora a sinistra, afferrò la bottiglia. Anatolio portò due candele e le collocò di qua e di là, benchè fosse quasi giorno chiaro. La schiena e la testa ricciuta di Dolochow erano illuminate da ambo i lati. Tutti si accalcarono verso la finestra. L’inglese era in prima linea. Piero sorrideva e stava muto. Uno degli astanti, più attempato degli altri, si slanciò irritato e spaurito e volle agguantar Dolochow per la camicia.
— Queste, signori miei, sono follie! questo è un suicidio! – gridò.
Anatolio lo fermò.
— Non toccarlo!... Gli farai paura, e andrà di sotto... Ah? e allora? ah?
Dolochow si voltò di sghembo, tornò ad acconciarsi e puntò di nuovo le mani.
— Se un altro di voi mi si accosta, – sibilò fra i denti serrati, – lo butto giù come niente... Orsù!
E così dicendo, strinse forte il collo della bottiglia, portò questa alla bocca, rovesciò indietro la testa e levò alto, per mantener l’equilibrio, la mano libera. Uno dei servi, chinatosi a raccattare i vetri, si arrestò così curvo com’era, senza toglier gli occhi dalla finestra e dalla schiena del bevitore. Anatolio stava ritto e ad occhi sbarrati. L’inglese, sporgendo il muso, guardava di sbieco. L’amico giudizioso, che avea tentato d’impedire quella delittuosa pazzia, scappò in un angolo della camera e si gettò sopra un canapè con la faccia rivolta alla parete. Piero si coprì gli occhi, sempre sorridendo, benchè d’un sorriso che esprimeva ora la paura. Tutti tacevano. Piero si tolse le mani dagli occhi. Dolochow sedeva sempre nella stessa posizione; soltanto la testa era più arrovesciata di prima, tanto che i capelli dell’occipite toccavano il colletto della camicia, e la mano con la bottiglia si alzava sempre più con un tremito che tradiva lo sforzo. La bottiglia s’andava vuotando, e nel tempo stesso si capovolgeva curvando indietro la testa. «Ma com’è che dura tanto?» pensò Piero. Parevagli fosse passata più di mezz’ora. Di botto, Dolochow sussultò, tirandosi indietro con le spalle, e la mano gli tremò più rapida e convulsa; bastò quel movimento per spostare in avanti tutto il corpo sul davanzale in pendio. Egli si torse e s’irrigidì con uno sforzo supremo: la mano destra e la testa tremavano più forte. La sinistra si agitò in aria per afferrarsi ad un qualunque sostegno, ma subito ricadde. Piero da capo chiuse gli occhi, e pensò che non li avrebbe aperti più mai. Un gran tramestio intorno lo riscosse. Guardò. Dolochow, ritto sul davanzale, era pallido come un morto e rideva.
— Vuota!
Scagliò la bottiglia all’inglese che destramente l’afferrò a volo. Con un salto, Dolochow fu a terra. Sentiva terribilmente di rum.
— Bravo! Stupendo! Questa sì che è una scommessa! Diavolo che vi pigli tutti! – si gridava da varie parti.
L’inglese, cavata una sua borsa, contava i danari. Dolochow taceva, accigliato. Piero saltò sulla finestra.
— Signori! – Chi vuol scommettere con me? Farò anch’io lo stesso! – disse in tono di sfida. – Anzi, senza scommessa... Fammi dare una bottiglia... Vedrete... Qua una bottiglia, dico!
— Venga pure la bottiglia... Vediamo che sa fare, – disse Dolochow ridendo.
— Ma che sei matto? Anche a scendere una scala ti piglia il capogiro! Scendi, scendi! – si levarono altre voci.
— Ed io vi dico che beverò!... Qua, qua la bottiglia! – urlò Piero, scaraventando un pugno sulla tavola vicina. Lo afferrarono per le braccia, ma egli era così forte, che mandava tutti ruzzoloni.
— No, no, così non se ne fa nulla, – disse Anatolio. – Aspettate. Adesso lo piglio io in trappola... Senti veh, accetto io la scommessa, ma per domani... Adesso, andiamo tutti da ***
— Andiamo, – approvò Piero, – andiamo! Ci porteremo anche l’orso...
E afferrato l’animale, lo sollevò di peso e si diè a far salti e giravolte per la camera.
Il principe Basilio mantenne la promessa fatta alla Drubezkoi, che sollecitava una nuova destinazione per l’unico figlio Boris. Ne fu parlato all’imperatore, e il giovane, eccezionalmente, fu trasferito col grado d’alfiere nel reggimento Semenovski. Ma non valsero insistenze e raccomandazioni a farlo nominare aiutante di Kutusow. Subito dopo la veglia da Anna Scherer, la Drubezkoi se ne tornò a Mosca in casa dei Rostow suoi ricchi parenti, presso i quali fin dall’infanzia era stato allevato il suo adorato Boris, testè nominato alfiere in un reggimento di linea e di là passato alla Guardia. Questa era partita da Pietroburgo il 10 agosto, e Boris fermatosi a Mosca per equipaggiarsi, l’avrebbe raggiunta a Radzivilow.
In casa Rostow si solennizzava il giorno onomastico della madre e della figlia minore, che si chiamavano entrambe Natalia. Fin dal mattino, era un andare e venire di carrozze. Tutti si facevano un dovere di portare le loro felicitazioni alla casa magnatizia della contessa Rostow in via Povarscaia. La contessa e la figlia maggiore erano in salotto a ricevere le visite.
La contessa era un tipo orientale, magra, quarantacinquenne, visibilmente sciupata da una feconda maternità. Aveva avuto ben dodici figli. La lentezza dei movimenti e del discorso, effetto di debolezza, le conferiva una gravità che inspirava reverenza. La principessa Drubezkoi, come persona di famiglia, l’aiutava alla meglio, accogliendo anch’essa e intrattenendo gli ospiti. La gioventù se ne stava nelle camere interne, non trovando necessario di partecipare al cerimoniale del ricevimento. Il conte andava incontro agli ospiti e li riconduceva, invitandoli tutti a pranzo.
— Grato, gratissimo, cara o caro (tutti per lui erano cari, senza eccezione), per conto mio e delle care Natalie. Vi aspetto a pranzo, badate, se no mi offendo, caro. Ve ne prego, cara, cordialmente, a nome di tutta la famiglia.
Queste precise, identiche parole ripeteva a tutti, accompagnandole con la stessa stretta di mano, con gli stessi inchini, con la stessa espressione della faccia piena, liscia e gioviale. Accomiatatosi da un ospite, tornava a quelli che erano ancora in salotto, si adagiava in una poltrona col fare soddisfatto di uno che ami la compagnia, allargava le gambe, posava le mani sui ginocchi, si dondolava, discorreva del tempo e della salute, e tornava poi, stanco ma ligio al dovere, ad accompagnare, a salutare, ad invitare. A momenti, tornando indietro, attraversava il giardino e le camere di servizio, e dava un’occhiata all’ampia sala marmorea, dove si andava preparando la tavola per ottanta commensali. Osservava un po’ i servi, che portavano argenterie e maioliche o stendevano tovaglie damascate, e poi chiamava a sè Demetrio Vassilevic, un nobile scaduto che gli faceva da amministratore e gli raccomandava di badare a che tutto andasse bene.
— Bravo, così! – diceva, aggiustandosi sulla testa pelata i radi e grigi capelli. – Quel che importa è il servizio, capisci...
E qui traeva un sospiro di soddisfazione e facea ritorno in salotto.
— Maria Caraghin di Leone con la signorina! – annunciò con voce baritonale il cameriere della contessa, mostrandosi sulla soglia.
La contessa stette un po’ in sospeso e annasò in una tabacchiera d’oro col ritratto del marito.
— Non ne posso più con queste visite! – sospirò. – Via, riceverò anche costei, una vera pettegola presuntuosa... Venga, venga pure, – soggiunse con voce dolente e rassegnata, come se dicesse: – Ebbene, ecco qua la vittima!
Читать дальше