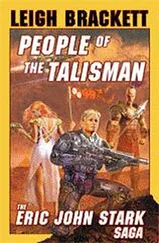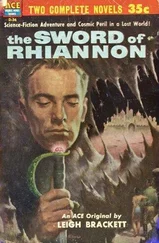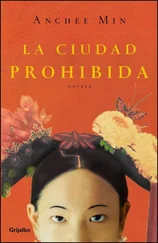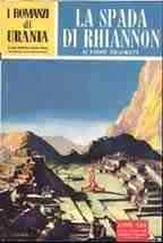«Va bene,» gridò Len, intrappolato in un angolo, privo di ogni possibilità di scampo. «Se non è questa la via da seguire, quale altra via rimane?»
«La via della ragione,» disse Sherman. «E ora vi posso dire per quale motivo Bartorstown è stata costruita.»
C’erano tre livelli, a Bartorstown. Essi salirono in quello di mezzo, sotto i laboratori e sopra la caverna dove il male antico si nascondeva dietro la sua tana di cemento. Len camminava davanti a Hostetter, e gli altri erano intorno a lui, Esaù ancora scosso da un tremito nervoso, e sudato, gli uomini di Bartorstown silenziosi e gravi. E la mente di Len era una distesa di oscurità selvaggia, come un cielo notturno senza stelle.
Stava fissando un’immagine. L’immagine si trovava su di un lungo pannello di vetro curvo, più alto di un uomo e illuminato dall’interno, e l’immagine appariva reale, dotata di prospettiva e profondità e distanza, e colori, e ogni minimo particolare era netto, facile da distinguere. Era un’immagine terribile. Raffigurava una desolazione arsa e frantumata, nella quale si ergeva soltanto un piccolo edificio solitario, inclinato, come se fosse stato molto stanco, e avesse voluto crollare.
«Voi parlate della bomba e di quello che ha fatto, ma non l’avete mai vista,» disse Sherman. «Gli uomini che costruirono Bartorstown l’avevano vista, invece, e ne avevano visto gli effetti… loro, o i loro padri. Era una realtà, una cosa del loro tempo. Posero questa immagine qui, al centro di questa sala, perché la sua visione ricordasse sempre una cosa… che essi non avrebbero mai, mai dovuto dimenticare il loro lavoro. In questa immagine vedete gli effetti della prima bomba atomica. Le rovine sono quelle della città di Hiroshima. Ora procedete, dietro l’angolo della parete.»
Obbedirono, e Gutierrez era già davanti a loro, e camminava a testa bassa.
«Le ho già viste troppe volte,» disse. Scomparve attraverso una porta che si apriva dall’estremità di un ampio, breve corridoio, sulle cui pareti c’erano numerose immagini. Erdmann fece per seguirlo, esitò, e poi rimase con gli altri. Neppure lui guardò le immagini.
Sherman le guardò, invece, e disse:
«Queste sono fotografie. Raffigurano persone sopravvissute a quel primo bombardamento… se possiamo usare il termine ’sopravvissute’, nel loro caso.»
Esaù borbottò:
«Gesù Benedetto!» Cominciò a tremare più violentemente, e muoveva la testa in modo strano, osservando le fotografie con brevi sguardi furtivi, come se avesse voluto vedere il meno possibile.
Len non disse niente. Fissò Sherman duramente, con occhi accusatori, e Sherman disse:
«In quei tempi, il problema della bomba era molto, molto sentito, perché la gente viveva sotto l’ombra di esso. In quelle vittime, la gente di allora vedeva i propri cari, le proprie famiglie. C’era un desiderio generale… tutti volevano che non vi fossero altre vittime, né altre Hiroshima, e sapevano che vi era un solo mezzo per raggiungere questo scopo.»
«Non avrebbero potuto distruggere le bombe?» domandò Len.
Era una domanda stupida, e subito si arrabbiò con se stesso per averla fatta, perché conosceva già la risposta: aveva parlato a lungo di quei tempi con il giudice Taylor, aveva letto diversi libri sull’argomento. Così si affrettò a prevenire la risposta di Sherman, dicendo:
«Lo so, pensavano che il nemico non avrebbe distrutto le sue. La cosa migliore sarebbe stata quella di non avere mai creato la bomba.»
Sherman rispose:
«La cosa migliore sarebbe stata quella di non imparare mai ad accendere un fuoco, così nessuno si sarebbe mai bruciato. Inoltre, era un po’ troppo tardi per questo. Dovevano affrontare una realtà, non un argomento filosofico.»
«E allora,» disse Len, «Qual era la risposta?»
«Una difesa: non la difesa imperfetta del radar e di altre armi, ma qualcosa molto più fondamentale e totale, un concetto completamente nuovo. Un campo di forza in grado di controllare le reazioni delle particelle nucleari al loro stesso livello, in modo che non potesse verificarsi alcun processo di fissione, o di fusione, dovunque quel campo protettivo fosse in funzione. Un completo controllo, Len. La padronanza assoluta dell’atomo. La fine delle bombe, di tutte le bombe.»
Silenzio, calma, ed essi lo osservarono di nuovo, per vedere quali sarebbero state le sue reazioni. Lui chiuse gli occhi, per non vedere quelle immagini, e riuscire a pensare, o almeno tentare di farlo, e le parole risuonavano nella sua mente, forti e fredde, per il momento senza significato. Controllo completo. La fine delle bombe, di tutte le bombe. La cosa migliore sarebbe stata quella di non averle mai costruite, né le bombe, né il fuoco, né le città…
No.
No, una parola ripetuta, lentamente, con attenzione, no. Controllo completo. La fine delle bombe, di tutte le bombe. La bomba è un fatto. L’energia atomica è un fatto. È un fatto concreto, qui, sotto i miei piedi, la terribile energia che ha prodotto le immagini che vedo intorno. Non posso negare questo fatto, non posso distruggerlo, solo perché è male, e il male è un serpente che muore e si rinnova perennemente dalle proprie ceneri…
No, no, no. Queste sono le parole del predicatore, le parole di Burdette. Completo controllo dell’atomo. La fine delle bombe. La fine delle vittime, la fine della paura. Sì. Si costruiscono delle stufe, per tenere prigioniero, docile e mansueto, il fuoco, e si tiene l’acqua a portata di mano per spegnerlo, se si ribellasse. Sì.
Ma…
«Ma non trovarono quella difesa,» disse. «Perché il mondo venne bruciato dalle bombe, malgrado ogni sforzo.»
«Tentarono di farlo. Ci hanno indicato la strada. Noi la stiamo ancora seguendo. E adesso, proseguiamo.»
Varcarono la porta oltre la quale Gutierrez se ne era andato, e si trovarono in uno spazio ricavato dalla roccia solida, come tutti gli altri, pareti lisce e colonne e tanto spazio che sfuggiva via in lontananza, inondato da torrenti di luce. C’era una grande parete, davanti a loro. Non era una vera parete, però, ma un immenso pannello, grande come una parete, isolato, collegato a due piccole macchine. Era alto quasi due metri, non raggiungeva il soffitto. C’era un labirinto di quadranti e lancette e lampade. Le lampade erano tutte spente, buie, e le lancette dei quadranti erano immobili. Gutierrez era in piedi davanti a esso, e il suo viso era torvo, triste, angosciato.
«Questa è Clementina,» disse, senza girare la testa al loro ingresso. «Un nome stupido per una cosa sulla quale può poggiare il futuro del mondo.»
Len abbassò le braccia, e in quel gesto c’era il significato di abbandonare molte cose pesanti, troppo pesanti o troppo dolorose per essere portate. Nella mia testa non c’è niente, deve restare così. Il vuoto si deve riempire lentamente di nuove cose, e le vecchie cose devono disporsi secondo nuovi disegni, e allora forse, forse riuscirò a capire… che cosa? Non lo so. Non so niente, e tutto è buio e confusione, e solo la Parola…
No, non quella Parola. Un’altra. Clementina.
Sospirò e disse, ad alta voce:
«Non capisco.»
Sherman si avvicinò al grande pannello buio.
«Questo è un computer. È il più grande che sia mai stato costruito, il più complesso. Vedete, qui…»
Puntò il braccio, indicando un punto oltre il pannello, nello spazio sorretto da colonne che si stendeva là, e Len vide che c’erano innumerevoli file di strane disposizioni di fili e tubi, messi tutti in ordine, uno dopo l’altro, interrotti a intervalli da grandi cilindri di cristallo scintillante.
«Tutto ciò ne fa parte.»
La passione che Esaù provava per le macchine si stava ridestando, un raggio ancora debole attraverso la nebbia della paura.
Читать дальше