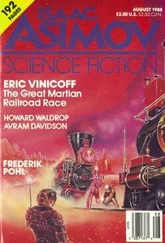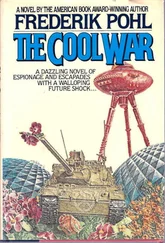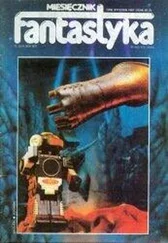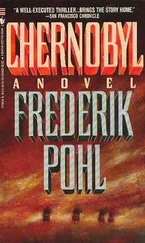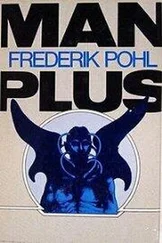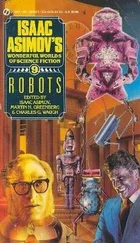— Sembra che i loro nemici — spiegò John, — siano l’Unione Sovietica e la Repubblica Popolare Cinese.
Fece una pausa e gettò un’occhiata all’ambasciatore, che con aria aggrondata restò seduto nella sua poltrona e non fece alcun commento. — Quale Cina? — chiesi io, come chiunque altro avrebbe fatto. Si riferiva al Protettorato Coreano, o all’Han Pekinese, o al Regno di Hong Kong, o alla Manciuria, o all’Impero Taiwanese, o ad uno degli altri dodici o quindici staterelli in cui la Cina s’era divisa dopo la Rivoluzione Culturale?
— Hanno una Cina soltanto — disse John. — Una nazione unita, la quale, per loro, è la più grande della Terra.
Ci fissammo l’un l’altro. Questa era abbastanza dura da mandar giù. E l’idea che l’Unione Sovietica minacciasse qualcun altro mi sembrava perfino più assurda. Cercai di leggere nell’espressione di Lavi, ma su di essa non era ancora emerso niente: si limitava ad ascoltare. Dopo un po’ allungò una mano e prese uno dei sigari del senatore, benché sapessi che di solito non fumava. Lo esaminò rigirandoselo lentamente fra le dita, e continuò a star zitto.
Potevo accorgermi che certi aspetti di quella situazione lo mettevano assai più a disagio di noi. Dopotutto era stata la guerra atomica con l’U.R.S.S. che aveva precipitato la Cina nella Rivoluzione Culturale. Ciò che i russi avevano subito, con la perdita di Mosca e Leningrado e la distruzione economica, era stato ancor peggiore.
Cercai di ricordare un po’ della storia russa. C’erano stati gli zar. Poi Lenin, che era morto assassinato o qualcosa del genere. Poi Trotzky, sotto cui la nazione era stata trascinata in una serie di guerre con stati confinanti come la Finlandia e l’Estonia, quasi tutte perdute. Quindi era andato al potere per un po’ di tempo il nonno di Lavrenti (travagliato da carestie e insurrezioni interne) che aveva dato il via alle ricerche atomiche costringendoci a una vera e propria gara nucleare, terminata solo quando i cinesi avevano annientato Mosca, la loro industria nucleare e tutto quanto…
Ma nell’altra linea temporale, a quanto pareva, Trotzky non era andato al Cremlino. Il nonno di Lavrenti invece sì, per molti anni. C’era stata una sola grande guerra, chiamata Seconda Guerra Mondiale, e l’avevano fatta contro un uomo chiamato Hitler, un tedesco che intendeva conquistare il mondo, e che quasi c’era riuscito prima che il resto del mondo si alleasse contro di lui.
Questo era ben strano. La Germania era una nazione come tante! Io avevo suonato là! Non era neppure minimamente abbastanza grossa e forte da poter minacciare il mondo intero!
E comunque… lì c’era Lavrenti, seduto dall’altra parte del salotto, che accendeva con calma il suo Cuban Claro. Naturalmente, di nome era comunista. Ma i russi non erano in alcun modo militanti come, ad esempio, i Bolscevici Inglesi, con le loro basi militari sparse in tutte quelle che chiamavano le Repubbliche Federali del Commonwealth. Grazie al cielo il Canada e l’Australia li avevano sbattuti fuori… Scossi la testa. Queste faccende non avevano mai avuto senso per me.
Lo avevano, sfortunatamente, per Lavrenti Djugashvili. Prima che Kennedy avesse finito di leggere il rapporto della CIA, era arrivato a metà del sigaro, e lo stava masticando pensosamente allorché il senatore depose il fascicolo e si volse a interrogarlo con lo sguardo.
— Capisco dove volete arrivare — annuì Lavi. — E la cosa è molto preoccupante. Se quest’invasione della vostra terra è, in definitiva, diretta contro la mia…
— Non esattamente contro la tua, direi — lo corresse subito John. — Suppongo invece contro l’Unione Sovietica della loro linea temporale.
— La cui gente — disse Lavi, cupo, — è pur sempre la mia gente, o no?
Kennedy non disse nulla, però ebbe un gesto d’assenso impercettibile.
Lavi si alzò. — Col suo permesso, mia cara signora Kennedy — disse gravemente, — penso che adesso dovrò fare una capatina alla mia ambasciata. La ringrazio per le informazioni, senatore. Forse si deciderà di fare qualcosa, anche se ora come ora non posso immaginare cosa.
Ci alzammo tutti, anche noi donne. Non fu tanto un segno di rispetto quanto una muta dichiarazione di simpatia. Quando se ne fu andato, il senatore Kennedy suonò per il maggiordomo e gli chiese di portarci i soprabiti. — Povero Lavrenti — sospirò. E poi: — Poveri noi, anche, in quanto a questo, perché neppure io immagino cosa si debba fare.
Ad onta della sua schiena indolenzita il senatore decise di riaccompagnarmi all’albergo lui stesso. Jackie si aggregò a noi tanto per fare un giro in macchina. Il tragitto non fu esilarante. Aveva ricominciato a piovere, e sull’asfalto c’era una patina scivolosa d’acqua e morchia.
Nel largo sedile anteriore ci stavamo comodamente tutti e tre. Non parlammo molto, neppure Jackie, che innervosita si preoccupava solo di suggerire al marito l’una o l’altra strada… da quando i suoi due fratelli più giovani erano morti in modo spiacevolissimo, uno investito e l’altro arso vivo fra le lamiere contorte, bastava un po’ di traffico a tenerla sulle spine. E io avevo i miei pensieri. Le dieci di sera erano appena passate. A Chicago erano le nove. Senza dubbio Ferdie era ancora in piedi. Avrei dovuto chiamarlo? Avevo il diritto di stabilire quale fosse il bene di me e di Dom? Avevo il diritto di stabilire cosa fosse o non fosse meglio anche per Ferdie?
Così non mi accorsi subito che avevamo rallentato a causa di un inatteso ingorgo un po’ più avanti, e l’imprecazione irritata del senatore mi fece sussultare. — Che diavolo fanno? — sbottò, cercando di vedere al di là delle auto bloccate di fronte alla nostra.
— È successo qualcosa? — chiese Jackie. — Un incidente?
Non si trattava di un incidente.
Kennedy imprecò. Attraverso il parabrezza della macchina più avanti intravidi un veicolo che veniva nella nostra direzione, sull’altra corsia. Era grosso e veloce, ma non aveva i lampeggiatori della polizia o delle ambulanze. Anzi non aveva luci per niente, a parte un faro che sciabolava ritmicamente di qua e di là un raggio nitido e tagliente come una lama. E quella luce si rifletteva su qualcosa che sporgeva sul davanti del veicolo stesso.
Mi sembrò quello che avrei detto un cannone.
— Gesù Cristo e tutti i Santi! — esclamò il senatore. — È un maledetto carro armato!
Jackie mandò un’esclamazione simile a un gemito… e così anch’io, credo, perché il senatore aveva dato gas con una violenta sterzata a sinistra. Fece compiere alla grossa Chrysler un mezzo giro, sfiorando il marciapiede opposto così da vicino che un coprimozzo si staccò e rotolò via. Poi cambiò marcia e accelerò energicamente, conservando una ventina di metri sul carro armato che ci arrivava alle spalle. Continuò ad aumentare velocità sul tortuoso lungofiume, superando i centocinquanta all’ora, ma il mezzo blindato non aveva perso molto terreno, e voltandomi vidi con orrore che il cannone si abbassava. Ci stava mirando dritto addosso. Anche il senatore dovette accorgersene, perché al primo incrocio inchiodò i freni e girò a destra di colpo. La sbandata ci portò fin sul marciapiede opposto di quella traversa, e dopo che una delle ruote posteriori lo ebbe urtato — e lo urtò a non meno di settanta all’ora — ci fermammo di traverso sulla strada.
Un taxi ci stava arrivando addosso strombazzando disperatamente.
Non mi ero mai sentita tanto vicina alla morte. Con un miracolo di abilità l’autista del taxi riuscì a fermarsi, anch’egli di traverso, e con non più di un palmo di spazio fra la portiera e il nostro parafanghi. Attraverso il finestrino vidi l’autista che urlava maledizioni a John, rosso in faccia e sconvolto.
Non gli prestammo alcuna attenzione.
Читать дальше