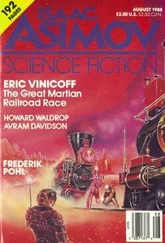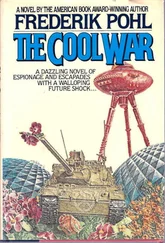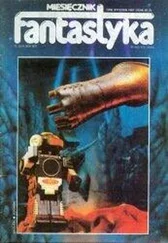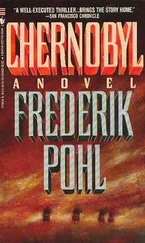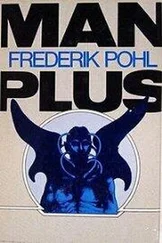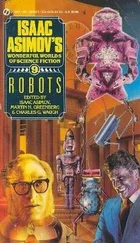Il nostro motore era in folle, ma John non tentò neppure di ripartire. Aprì la portiera e uscì, raddrizzandosi con un grugnito di sofferenza, gli occhi fissi sull’altra strada. Il carro armato ci passò davanti in un rombare di cingoli, veloce e minaccioso, seguito da una dozzina di camion da trasporto-truppe. Erano aperti, e potei veder luccicare gli elmetti di molti soldati in assetto di guerra. A chiudere la fila c’era un altro grosso tank.
— Da non credersi — mormorò John Kennedy.
— Perché stiamo facendo pattugliare le strade da mezzi blindati? — domandai. Lui si volse a fissarmi. John non era certo un giovanotto, ma non l’avevo mai visto così vecchio e stanco come in quel momento. Mise un braccio attorno alle spalle di Jackie con fare protettivo.
— Non siamo noi a farlo — disse. — Quelli non sono nostri. Non ho mai visto carri armati di quel genere.
La giovane veterinaria aveva appena ventiquattr’anni ed era terrorizzata. S’insaponò e si sciacquò sotto la doccia sei volte di seguito, come le era stato ordinato, e completamente nuda uscì nella sconosciuta camera da letto di quella fattoria, dove il capitano dell’esercito la stava aspettando. A spaventarla non era il fatto d’essere nuda davanti a un uomo, mentre lui le passava il contatore Geiger su ogni centimetro di pelle, gli orecchi tesi allo sporadico crepitio dell’apparecchio. — Sembra che vi siate lavata via tutta la polvere — dichiarò infine il militare. — Avete detto d’aver trovato altro bestiame in queste condizioni? E polvere come questa dappertutto? — Lei annuì, ad occhi sbarrati. — Potete rivestirvi. Penso che siate a posto — disse lui. Ma nel guardarla uscire non riuscì a trattenere un brivido. Fallout radioattivo! Un miglio quadrato di terreno ricoperto da particelle altamente radioattive… lì, a neanche quaranta miglia da Dallas, quando non erano in corso esperimenti atomici da nessuna parte, per quel che ne sapeva. Era un enigma senza risposta. Ma intanto quel pensiero lo raggelava fino all’osso… cosa sarebbe successo se la nuvola di particelle mortali fosse ricaduta nel cuore della città?
26 Agosto 1983
Ore 6,40 del mattino — Nicky DeSota
Stavo sognando che Mrs. Laurence Rockefeller mi aveva incaricato di stipularle ipoteche su tutto il complesso di appartamenti da seicento milioni di dollari che aveva sul lungolago, solo che voleva partire con una rata mensile di centocinquanta dollari e tutta in monetine da dieci cents… e quando finalmente avevo il contratto pronto, lei non poteva firmare perché non aveva i pollici. Poi il sussulto dell’aereo che toccava la pista mi svegliò, e la prima cosa che mi chiesi non fu dove mi trovavo, né cosa mi sarebbe accaduto, ma se Mr. Blakesell aveva saputo del mio arresto in tempo per mandare qualcuno dai tre clienti che avevo lasciato in sospeso. Io non potevo farci niente, naturalmente.
E non c’era nessun’altra cosa che potessi fare, perché ero stato ammanettato alla spalliera del sedile di fronte. Il mio primo volo sulla lunga distanza a bordo di quel nuovo grosso quadrimotore Boeing era stato un’interminabile tortura. Avevo sofferto su quella poltroncina per sette ore, oltre alle due fermate intermedie, mentre sotto di me scorrevano centinaia o forse migliaia di miglia. Ma i dolori che avevo addosso me li portavo dietro da prima che mi spingessero su per la scaletta dell’aereo, con le mani imprigionate dietro la schiena e quel ringhioso agente dell’FBI, Moe Nonsochi, che mi minacciava di tutte le condanne del codice qualora avessi parlato, o cercato di fuggire, o tentato di levarmi il cappello e quel velo sulla faccia che mi avevano messo per evitare che chiunque potesse riconoscermi. Lui sapeva tutto sui dolori con cui ero giunto all’aeroporto. Aveva lavorato duramente per procurarmeli.
Dovevo ammettere ormai che quella gente dell’FBI, uomini e donne, la sapevano lunga su come far male senza lasciarvi un segno addosso.
Al di là del passaggio centrale anche l’altro prigioniero, lui pure con cappello e velo sulla faccia, s’era svegliato. Potevo vederlo muovere la testa. La sua guardia continuò a russare vigorosamente come la mia, intanto che l’aereo rullava avanti lungo una pista che si sarebbe detta senza fine.
Almeno ero fuori da quella cella di sicurezza nel loro quartier generale di Chicago dove avevo trascorso la più parte degli ultimi… quanti erano stati? Giorni, di sicuro, anche se nessuno mi aveva detto quanti. Era stato un soggiorno assai sgradevole, malgrado la compagnia di un gruppetto d’individui socialmente indesiderabili (sindacalisti sulla via del campo di concentramento, speculatori falliti, negri che non avevano voluto stare al loro posto) ma avevo finito per trovarli amabili, a confronto di quelli che ogni tanto venivano a prendermi per interrogarmi ancora. Da me non avevano saputo nulla, naturalmente. Io non avevo nulla da dire… ma, mio Dio, quanto avrei desiderato averlo!
Poi Moe era venuto a scuotermi dal sonno, mi aveva fatto fare il corridoio a spintoni e da lì a non molto m’ero ritrovato su un aereo. Diretto il Cielo sapeva dove.
No. Sia il Cielo che io sapevamo dove, adesso, perché attraverso il velo e il cristallo del finestrino potevo vedere il terminale di un piccolo aeroporto. Su di esso una grossa insegna augurava:
BENVENUTI AD ALBUQUERQUE,
NEW MEXICO
Altitudine 5196 piedi
Il New Mexico, sant’Iddio! Cosa potevano volere da me nel New Mexico?
Ovviamente Moe non si sarebbe preso la briga di dirmelo. La hostess venne a battergli su una spalla per svegliarlo, e subito lui si sporse a scuotere l’altra guardia, ma tutto ciò che disse a me fu: — Ricorda quel che ti ho detto. — Con un cenno lo tranquillizzai sulle mie capacità mnemoniche. Ci fecero aspettare finché tutti i passeggeri furono scesi dal Boeing, poi ci fecero aspettare ancora un po’, mentre i meccanici controllavano qualcosa dei grossi motori e un’autocisterna riforniva i serbatoi di benzina a 100 ottani.
Poi alla porta del terminal comparve un uomo che alzò un pollice verso Moe, in attesa al finestrino.
Le manette scattarono e fui fatto incamminare verso l’uscita, ma mi costò uno sforzo non vacillare qua e là ed evitare d’inciampare sulla scaletta. Io e l’altro prigioniero venimmo indirizzati alla porta di un terminal che sembrava esser stato costruito come scenario per un musical d’ambiente latinoamericano. C’era gente che ci guardava. I curiosi più vicini furono scostati con un cortese «Circolare!» e una spinta, ma non erano molti, perché gli scagnozzi dell’FBI non erano difficili da riconoscere e la gente sapeva quand’era il caso di tirar via diritto. Fuori c’era una grossa auto. Moe mi affiancò sul sedile anteriore, e l’altro prigioniero con la sua guardia sedettero dietro. Una macchina della polizia cittadina ci fece strada, l’autista diede gas e le schizzammo dietro. A velocità fin troppo sostenuta attraversammo la cittadina e quindi girammo sulla statale, che serpeggiava verso una zona collinosa.
Dopo quasi un’ora di corsa apparve un crocevia, e l’auto rallentò rapidamente. Era una terra quasi desertica, le strade silenziose si allontanavano verso i quattro punti cardinali, e gli unici edifici erano una stazione di rifornimento ed un motel. L’insegna sull’ufficio diceva: «LA CUCARACHA — Il riposo del viaggiatore». L’ultimo nome che io avrei mai dato a un motel.
E se fossi stato un viaggiatore desideroso di riposarmi, la vista delle guardie armate sul vialetto mi avrebbe incoraggiato a riposare altrove.
Le guardie, comunque, erano un tocco decorativo a cui cominciavo ad assuefarmi. Così c’erano segni buoni e segni cattivi. Quello cattivo consisteva nel proseguimento della mia detenzione. Quello buono nel fatto che la detenzione sarebbe proseguita a Leavenworth o in un campo consimile, dove mi avrebbero tenuto finché non fossero stati pronti a farmi uscire… se ne sarei uscito. Doveva essere una delle isolette nell’arcipelago dell’FBI. Non potevano aver intenzione di trattenermi a lungo. Avrebbero dovuto lasciarmi andare.
Читать дальше