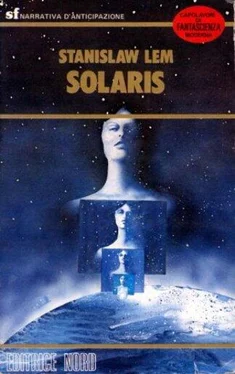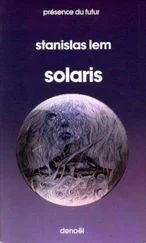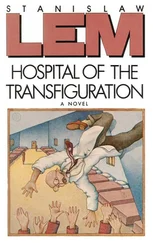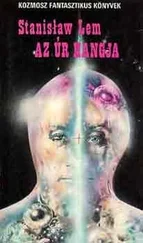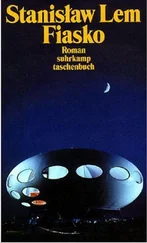Mi avvicinai all’armadio e incominciai a smuovere le tute.
Snaut mi osservò in silenzio e infine disse: — Non mi va a genio.
— Cosa? — Mi girai con la tuta in mano. Da tempo non ero così eccitato. — Che c’è? Hai paura che…? E’ assurdo. Ti do la mia parola che no. Non ci avevo nemmeno pensato. No, veramente no.
— Vengo con te.
— Grazie, ma preferisco andare da solo. E’ qualcosa di nuovo per me, qualcosa di completamente nuovo — dissi, indossando rapidamente la tuta.
Snaut brontolò non so che; non lo ascoltavo, cercavo in fretta l’equipaggiamento che mi occorreva. Mi seguì fino all’aeroporto. Mi aiutò a far uscire l’apparecchio dal box e a portarlo in mezzo alla piattaforma di partenza. Mentre stavo per chiudere la tuta, mi domandò: — La parola d’onore ha qualche valore per te?
— Mio Dio, Snaut! Ancora? Te l’ho già data. Dove sono le bombole di riserva?
Non mi disse più niente. Quando chiusi la cupola trasparente, gli feci cenno con la mano. Mise in moto l’ascensore, che mi portò fuori, sulla parte superiore della stazione. Il motore si svegliò, rumoreggiò, la tripla elica girò e l’apparecchio si alzò, stranamente leggero, lasciando dietro di sé il disco argenteo, sempre più piccolo, della base spaziale.
Ero per la prima volta solo sopra l’oceano. L’impressione era diversa da quella che si aveva dalla finestra, forse per la bassa quota dell’apparecchio. Volavo a una distanza di appena qualche decina di metri sopra le onde. Solo ora capivo e sentivo che le increspature e gli avvallamenti della superficie si muovevano non come le onde del mare, o come le nuvole, ma come un animale. Pareva la contrazione continua ma straordinariamente lenta dei muscoli di un corpo che secerneva una schiuma scarlatta. Quando feci per dirigermi verso il mimoide simile a un’isola che andava lentamente alla deriva, il sole mi colpì dritto negli occhi, gettò sprazzi sanguigni sul vetro curvo, e l’oceano nero divenne di un azzurro scuro con delle macchioline di fuoco.
La manovra, compiuta con non troppa abilità, mi fece scadere sottovento, lontano dalla sagoma lunga e chiara del mimoide che si sollevava irregolarmente sull’oceano. Aveva perso il color rosa di cui si rivestiva nella nebbia, era giallastro come un osso essiccato; per un momento lo persi di vista e invece scorsi in lontananza la stazione, simile per forma a uno degli antichi dirigibili, che pareva posato sulla superficie oceanica. Ripetei la manovra con maggiore attenzione; la massa del mimoide, col suo rilievo tormentato e grottesco, crebbe rapidamente avvicinandosi. Per timore di urtare le protuberanze a bulbo raddrizzai l’apparecchio così bruscamente che, perdendo velocità, si mise a rollare; la precauzione era stata inutile, perché le cime arrotondate di quelle torri si abbassavano. Regolai il volo sulla deriva dell’isola e lentamente, un metro per volta, scesi fino a sfiorare le vette corrose. Non era enorme. Da un capo all’altro misurava poco più di un chilometro, su una larghezza di un paio di centinaia di metri. In certi punti mostrava un restringimento che annunciava che presto si sarebbe spaccato. Doveva essere un pezzo staccato di una formazione incomparabilmente più grande.
Sulla scala di Solaris era appena una scheggia, un residuo già vecchio di chissà quante settimane o mesi.
Tra gli scogli a strapiombo sull’oceano c’era un’apertura, una specie di spiaggia di qualche decina di metri quadrati, in pendio ma piatta. Diressi lì il velivolo. La discesa fu più difficile del previsto, andai a un pelo dal toccare con l’elica un dirupo che mi ero trovato improvvisamente dinanzi. Spensi il motore e aprii la cupola respingendola all’indietro. In piedi sull’alettone verificai che l’elicottero non rischiasse di scivolare verso il basso, nell’oceano; le onde lambivano la riva a pochi passi dal punto di discesa, ma l’apparecchio stava al sicuro sui suoi appoggi largamente divaricati. Saltai a… «terra». Quello che mi era parso un dirupo era una grandissima membrana sottile e traforata, una lastra pietrificata posata verticalmente e percorsa da rigonfiamenti. Una breccia larga alcuni metri fendeva di sbieco la parete e consentiva di esaminare l’interno dell’isola, già intravista attraverso le sue immense e irregolari aperture. Mi arrampicai con prudenza sulla sporgenza più vicina, ed ebbi la prova che le scarpe facevano presa, che la tuta non impacciava i miei movimenti.
Ora, trovandomi a un’altezza di quattro piani sopra l’oceano, in mezzo al paesaggio scheletrico, finalmente potevo vederlo per intero.
Assomigliava in modo sorprendente a un’arcaica città in rovina, una borgata esotica e secolare del Marocco, distrutta da un terremoto o da un altro cataclisma. Si vedeva chiaramente il labirinto di stradine tortuose, in parte coperte dalle macerie, con i vicoli in ripido pendio verso la riva, bagnati dalla massa gelatinosa; più in alto merlature intatte e bastioni dai contrafforti smussati, nelle pareti rigonfie le aperture buie erano come finestre e feritoie di una fortezza. Quest’isolacittà era tutta inclinata su un fianco, come una nave che affonda, e andava alla deriva, con un movimento senza senso né costanza, girando molto lentamente su se stessa, com’era confermato dal cambiamento di posizione del sole sull’orizzonte, che provocava anche lo spostarsi delle ombre tra i ruderi della città in rovina; di tanto in tanto una superficie levigata gettava il bagliore di un raggio di sole fin dove mi trovavo. Mi arrampicai più in alto, non senza rischio, finché dalle forme sospese sopra la mia testa cominciarono a cadere dei calcinacci; cadendo sollevavano parecchia polvere, tra le stradine e i burroni. Il mimoide non è roccia naturale, e la rassomiglianza sparisce quando se ne prende un pezzetto in mano: è una materia molto più leggera e porosa della pomice.
Da quell’altezza percepivo i suoi movimenti: non soltanto avanzava, spinto dalle contrazioni muscolari dell’oceano, ma anche s’inclinava, una volta su un lato, una volta sull’altro, sempre lentamente, un languido dondolio accompagnato dal fruscio della schiuma scura e gialla che scorreva e si riversava lungo il bordo emerso. Questa oscillazione durava in virtù della sua immensa massa: osservai dal mio luogo tutto ciò che potevo, e prudentemente scesi in basso. Allora — cosa strana — mi resi conto che il mimoide non m’interessava affatto, che non ero andato fin là per osservarlo, ma per guardare l’oceano.
Sedetti sulla superficie ruvida e screpolata; dietro di me, a una decina di passi, l’elicottero. Un’onda nera venne a coprire pesantemente la riva, spianandosi e nel contempo scolorando; quando si ritirò, dei fili di mucosa scivolarono via sul bordo della massa. Scesi ancora più in basso e tesi la mano verso la successiva. Si ripeté fedelmente il fenomeno sperimentato dalla gente un secolo prima: l’onda esitò, retrocesse, sommerse la mia mano, senza comunque toccarla, cosicché tra la superficie del guanto e l’interno della cavità, che di colpo cambiò consistenza diventando da liquida quasi solida, rimase come un filo d’aria. Alzai allora lentamente il braccio; l’onda, o meglio la sua esigua propaggine, lo seguì, continuando a coprire la mia mano come un sacco sempre più trasparente, verdastro. Dovetti alzarmi per poter sollevare il braccio più in su; la sostanza gelatinosa si allungò come un cordone teso, ma non si spezzò; la base dell’onda completamente appiattita sulla riva mi avvolgeva i piedi (senza nemmeno toccarli), come un essere in paziente attesa della fine dell’esperimento. Sembrava che dall’oceano fosse nato un fiore, il cui calice mi circondava le dita, diventandone l’esatto negativo. Retrocessi. Il gambo vibrò, vacillò e, come controvoglia, ricadde; l’onda lo riassorbì e sparì dietro il bordo della riva. Ripetei questo gioco finché non accadde, come cento anni prima, che un’onda arrivò e se ne andò indifferente, come sazia di questa nuova impressione, e sapevo che per ridestare la sua «curiosità» avrei dovuto aspettare ore. Sedetti di nuovo; ma, in un certo senso, mutato dal fenomeno che avevo provocato e che già conoscevo, per quanto solo in teoria; la teoria non può mai rendere la reale impressione della cosa reale.
Читать дальше