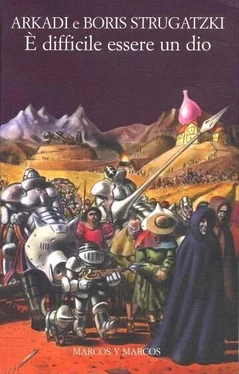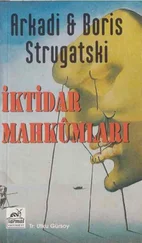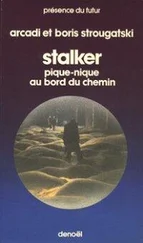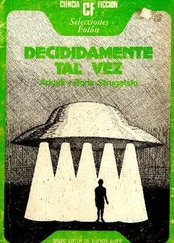Smise di resistere per conservare le forze. Per un po’ lo presero a calci, silenziosamente, accanitamente, ansando di gioia. Poi lo afferrarono per le caviglie e lo trascinarono via. Passando davanti alla porta aperta della stanza da letto Rumata vide il maresciallo del principe inchiodato al muro da una lancia, e un mucchio di lenzuola insanguinate sul letto. «Ecco come va a finire… Povero ragazzo». Lo trascinarono giù per le scale, e perse i sensi.
Disteso su una collina erbosa, guardava le nuvole che salpavano nel cielo alto e azzurro. Si sentiva tranquillo, ma sulla collina sedeva accanto a lui l’incarnazione del dolore più lancinante. Il dolore era esteriorizzato, eppure lo sentiva anche dentro di sé, soprattutto nel fianco sinistro e nella nuca. «Ha tirato le cuoia, vero? Vi taglierò la testa!» Poi un fiotto di acqua gelata gli piovve addosso dal cielo. Infatti era disteso sulla schiena e guardava il cielo: non da una collina erbosa, ma da dentro una pozza d’acqua. Il cielo non era azzurro, ma grigio e plumbeo, striato di rosso. «Niente affatto» disse un’altra voce. «È vivo. Strizza le palpebre».
«Sono io» pensò. «Stanno parlando di me. Sono io che strizzo le palpebre. Cosa sono queste sciocchezze? Non sono capaci di parlare come si deve?» Qualcuno si mosse e colpì l’acqua con un oggetto pesante. Sul cielo apparve il profilo nero di una testa con un berretto piatto.
«Che ne dice, signore, riesce a camminare da solo o devo farla trasportare?»
«Slegatemi le gambe!» disse bruscamente Rumata, e immediatamente sentì una fitta bruciante nelle labbra livide. Vi passò sopra la lingua. «Più che labbra» pensò «sembrano una frittata».
Qualcuno si attaccò ai suoi piedi e cominciò a tirarli e spingerli senza tante cerimonie. Alcune persone stavano parlando sottovoce.
«Lo avete ridotto piuttosto male».
«È stato necessario, stava quasi per sfuggirci… E un demonio, le frecce rimbalzano su di lui…»
«Una volta ho conosciuto un uomo: potevi spaccargli un’ascia addosso e non batteva ciglio».
«Un contadino, probabilmente».
«Chiaro».
«E con questo? Lui è un nobile».
«Al diavolo! Guarda come hanno stretto i nodi! Neanche san Michele riuscirebbe a slegarlo! Passami una torcia».
«Meglio usare un coltello».
«Ehi, ragazzi, lasciatelo legato. Se no ricomincerà a darcele. Mi ha quasi spaccato la testa».
«No, no, non farà niente».
«Gli altri possono dire quello che vogliono, camerati, ma io l’ho colpito con la lancia. Gli ha trapassato la corazza».
Una voce echeggiò perentoria nell’oscurità.
«Volete smetterla?»
Rumata ora si sentiva le gambe libere. Le distese e cercò di alzarsi in piedi, ma ricadde subito. Alcuni Sturmovik accucciati per terra l’osservarono in silenzio mentre barcollava nella pozzanghera fangosa. Il giovane digrignò i denti per la rabbia e l’umiliazione. Tirò indietro le scapole: aveva le mani legate e rigirate sulla schiena, ma così strettamente che non riusciva a capire dove fossero le palme e dove i gomiti.
Raccolse tutte le forze e le tirò violentemente verso l’alto, ma si piegò subito in due per il dolore. Gli Sturmovik scoppiarono a ridere.
«Così non scappa di certo» disse uno.
«Sembra un po’ stanco. Ehi, dormi in piedi?»
«Ehi, signore, non è divertente, vero?»
«Silenzio! Smettetela con queste idiozie!» disse la voce imperiosamente. «Venite qui, Don Rumata!»
Rumata si sforzò di stare in piedi e si diresse verso la voce. Si sentiva barcollare.
Da qualche parte spuntò un uomo con una torcia in mano che gli fece strada. Rumata capì dov’era: uno degli innumerevoli cortili interni del ministero della Sicurezza, vicino alle scuderie reali.
Rifletté velocemente: «Se mi portano a destra significa la Torre, le segrete. A sinistra, invece, ci sono gli uffici del ministero». Scosse la testa. «Che importa» pensò.
«Sono ancora vivo. Ce la farò…» Girarono a sinistra.
«Almeno non subito» pensò Rumata. «Prima l’interrogatorio, il contraddittorio.
Terribile. In questo caso, di cosa potrebbero accusarmi? È abbastanza ovvio. Di aver istigato il prigioniero Budach ad avvelenare il Re, di aver cospirato e complottato contro la corona. Forse anche di aver assassinato il principe. E naturalmente di aver fatto la spia per gli irukani, i soaniani, i barbari, i baroni, il Sacro Ordine, eccetera.
Mi stupisco di essere ancora vivo. Questo significa che quel serpente deve aver pensato anche qualcos’altro».
«Da questa parte» disse l’uomo dalla voce imperiosa.
Si aprì una porticina. Rumata chinò la testa ed entrò in una grande stanza illuminata da una decina di candelieri. Gli uomini seduti o sdraiati sul tappeto consumato al centro della stanza erano legati e insanguinati. Certi erano già morti, oppure erano svenuti. Erano quasi tutti a piedi nudi e indossavano solo delle camicie da notte strappate. Lungo le pareti, alcuni Sturmovik con il naso rosso erano appoggiati indolentemente alle loro asce. Si guardavano intorno con espressione bestiale e soddisfatta. Avevano vinto. L’ufficiale di guardia camminava avanti e indietro davanti a loro, con le mani dietro la schiena. Aveva un’uniforme grigia dal colletto molto unto. Il compagno di Rumata, un uomo alto che portava un mantello nero, gli si avvicinò e gli sussurrò qualcosa all’orecchio. L’ufficiale annuì, osservò brevemente Rumata con grande interesse e scomparve dietro le tende pesanti e multicolori all’altro capo della stanza.
Gli Sturmovik esaminarono a turno il nuovo prigioniero, anch’essi molto interessati. Uno di loro, guercio, disse: «Guarda, sulla fronte ha una pietra preziosa!»
«Non male, quella pietra» disse un altro. «Bottino per il Re. E il cerchietto è d’oro massiccio».
«Il Re siamo noi, adesso».
«Giù le mani, eh, che vi credete?»
«Via di là» disse l’uomo con il mantello nero.
I soldati lo guardarono sorpresi.
«Un altro che ci fa la predica?» disse il guercio.
L’uomo con il mantello nero non rispose, ma gli voltò le spalle e si avvicinò a Rumata. Gli Sturmovik lo squadrarono dalla testa ai piedi, diffidenti.
«Un prete, forse?» disse quello senza un occhio.
«Ehi, prete, vuoi che ti spacchi la faccia?»
Gli altri ghignarono divertiti. Il guercio si sputò sulle palme, si passò l’accetta da una mano all’altra e andò verso Rumata. «Adesso vedrai» pensò Rumata, tirando lentamente indietro il piede destro.
«Ho sempre picchiato i preti» disse lo Sturmovik, fermandosi davanti all’uomo vestito di nero e guardandolo con insolenza. «I preti, i topi di biblioteca e i nostri cosiddetti padroni. Una volta ho…»
L’uomo in nero alzò la mano tesa. Improvvisamente si sentirono uno scatto e un ronzio, appena sotto il soffitto. Sh-sh-sh. Lo Sturmovik lasciò cadere l’accetta e cadde all’indietro. Nella fronte era conficcata una grossa freccia. Subito tutti tacquero. I soldati si dondolavano nervosamente sulle gambe, con gli occhi fissi alle feritoie sotto il soffitto.
«Portate via il cadavere, svelti!» Alcuni Sturmovik si chinarono, afferrarono il loro camerata per le braccia e le gambe e lo trascinarono fuori. Un ufficiale Grigio sbucò da dietro le tende e fece un cenno a Rumata e all’uomo in nero.
«Andiamo, Don Rumata» disse questi.
Rumata passò davanti ai corpi dei prigionieri e si avviò. «Non ci capisco più niente» pensò. Appena fu dietro le tende, al buio, mani invisibili lo afferrarono e lo frugarono dappertutto, gli strapparono dalla cintura i foderi vuoti e lo spinsero poi nella luce.
Rumata capì all’istante dove si trovava.
Era il famigerato studio di Don Reba negli appartamenti lilla. Don Reba era seduto nello stesso punto, nella stessa posizione della volta precedente: la schiena dritta, i gomiti sulla scrivania e le dita intrecciate. «Scommetto che ha le emorroidi» pensò improvvisamente Rumata. Ne provò quasi compassione. A destra di Don Reba si era sistemato Padre Zupik, che si mordicchiava nervosamente le labbra con espressione attenta, mentre alla sua sinistra era seduto un pancione sorridente: le spalline indicavano che era capitano dell’Armata Grigia. Nella stanza non c’era nessun altro.
Читать дальше