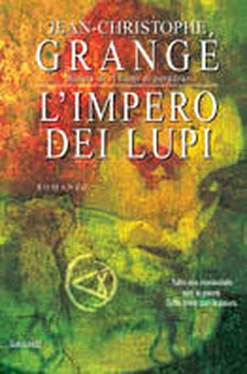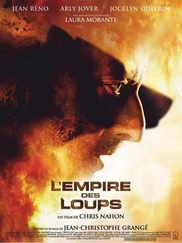Stava per mettersi al riparo, quando percepì il borbottio di un motore. Più che un vero rumore, era una sorta di vibrazione sotto la pelle. Girò la testa e scorse la barca che andava all’assalto di ogni onda per poi scendere bruscamente, scavando dietro di sé due ali di schiuma.
A pilotarla era Azer, chiuso nella sua giacca abbottonata fino al collo. Al suo fianco, Sema, seminascosta dalle pieghe svolazzanti della sua cerata, sembrava minuscola. Sapeva che aveva cambiato faccia. Ma, anche a quella distanza, riconosceva il suo portamento. Quell’aria leggermente arrogante che, vent’anni prima, gliel’aveva fatta notare in mezzo ad altre centinaia di bambini.
Azer e Sema.
L’assassino e la ladra.
I suoi soli figli.
I suoi soli nemici.
Appena si mosse, il giardino si animò.
Una prima guardia del corpo venne fuori da un boschetto. Una seconda apparve dietro un tiglio. Altre due si materializzarono sul vialetto di ghiaia. Tutte impugnavano un MP-7, un’arma per la difesa ravvicinata caricata con cartucce subsoniche capaci di forare una protezione di titanio o di kevlar a cinquanta metri di distanza. Almeno, questo era quanto gli aveva assicurato il suo fornitore. Ma c’era un senso in tutto ciò? Alla sua età, i nemici che temeva davvero non viaggiavano alla velocità del suono e non perforavano il policarbonato: erano dentro di lui e si dedicavano a un paziente lavoro di distruzione.
Proseguì lungo il viale. I suoi uomini lo circondarono all’istante, formando uno scudo umano. Ormai era sempre così. La sua vita era custodita come un gioiello prezioso, ma quel gioiello non brillava più. Era murato vivo, sempre dentro il perimetro dei suoi giardini e sempre attorniato dalle sue guardie.
Si diresse verso il palazzo, uno degli ultimi yalis di Yeniköy. Una residenza estiva, in legno, a pelo d’acqua, eretta su pilastri catramati. Un palazzo a sviluppo verticale, irto di torrette, imponente come una cittadella, ma, nel contempo, semplice come un capanno di pescatori.
Le scandole del tetto, incurvate per l’usura, mandavano riflessi vivi come quelli di uno specchio, mentre le facciate assorbivano la luce, rinviando barbagli opachi di un’infinita dolcezza. Intorno all’edificio regnava un’atmosfera da luogo di transito, da molo, da imbarcadero; l’aria salmastra, il legno consunto, lo sciabordio, tutto faceva venire in mente al vecchio una località di villeggiatura.
Tuttavia, avvicinandosi e scorgendo i dettagli orientaleggianti della facciata, le travature dei terrazzi, i soli scolpiti sui balconi, le stelle e le mezzelune delle finestre, capiva che quel palazzo sofisticato era qualcosa di ben diverso: un edificio elaborato, solido, definitivo. Era la tomba che si era scelto. Un sepolcro in legno dal quale si poteva vedere arrivare la morte ascoltando il rumore del mare…
Giunto nell’atrio, Ismaïl Kudseyi si tolse la cerata e gli stivali. Poi si infilò delle pantofole, una giacca di seta indiana e si concesse il tempo di contemplarsi nello specchio.
Il suo volto era il suo solo motivo d’orgoglio.
Il tempo aveva prodotto i suoi inevitabili danni, ma le ossa avevano tenuto bene e gli tendevano la pelle rendendo più netti i lineamenti. Più che mai, manteneva quel profilo da cervo, con le mascelle prominenti e quella smorfia sdegnosa sulle labbra.
Prese un pettine dalla tasca e si pettinò. Lisciò lentamente le ciocche grigie, ma si arrestò di colpo comprendendo il significato di quel gesto: si stava preparando per Loro. Perché temeva quell’incontro. Perché aveva paura di affrontare il senso profondo di tutti quegli anni…
Dopo il colpo di stato del 1980, era dovuto fuggire in Germania. Quando era tornato, nel 1983, la situazione in Turchia si era calmata, ma la maggior parte dei suoi compagni d’arme, gli altri Lupi grigi, era in prigione. Sebbene isolato, Ismaïl Kudseyi aveva rifiutato di abbandonare la causa. Anzi, nella massima segretezza, aveva deciso di riaprire i campi di addestramento e di creare il proprio esercito. Stava dando vita ai nuovi Lupi grigi. O meglio, stava formando dei Lupi superiori, al servizio dei propri interessi politici e criminali al tempo stesso.
Si era messo sulle strade dell’Anatolia per scegliere personalmente i predestinati. Aveva organizzato i campi, aveva osservato gli adolescenti durante l’addestramento, li aveva schedati per selezionare un gruppo d’élite. Molto presto, il gioco lo aveva catturato. Si era appassionato soprattutto alla formazione dei bambini.
Sentiva nascere in sé una viscerale complicità con quei piccoli contadini che gli ricordavano il ragazzo di strada che era stato molto tempo prima. Preferiva la loro compagnia a quella dei suoi figli, quei figli avuti in tarda età, dalla figlia di un ex ministro, e ora lontani, a seguire i loro studi a Oxford e alla libera università di Berlino, quegli ereditieri, divenuti degli estranei.
Di ritorno dai suoi viaggi, si isolava nella sua tenuta e studiava a fondo ogni dossier, ogni profilo. Seguiva da vicino i loro talenti, i loro doni naturali, ma anche la loro voglia di emergere, di fuggir dalle campagne… Individuava i candidati più promettenti, quelli da sostenere con le borse di studio e poi da integrare nel proprio clan.
Poco a poco, la sua ricerca divenne una malattia, una mania. L’alibi della causa nazionalista non bastava più a mascherare le sue ambizioni. Quello che lo esaltava era l’idea di forgiare a distanza degli esseri umani. Di manipolare dei destini, come se fosse stato un invisibile demiurgo.
Due nomi cominciarono a interessarlo in modo particolare.
Un ragazzo e una ragazza.
Due promesse allo stato puro.
Originario di un villaggio che sorgeva vicino all’antico sito di Nemrut Daği, Azer Akarsa aveva cominciato molto presto a manifestare doti particolari. A sedici anni era, al tempo stesso, un combattente accanito e uno studente brillante. Ma soprattutto, mostrava una vera passione per l’antica Turchia e per il credo nazionalista. Si era iscritto al comitato clandestino di Adiyaman e si era offerto volontario per i gruppi commando. Voleva arruolarsi nell’esercito e combattere sul fronte curdo.
Azer aveva però un handicap: era diabetico. Ma Kudseyi aveva deciso che quel punto debole non avrebbe impedito al ragazzo di diventare un Lupo: gli avrebbe garantito le cure migliori.
L’altro dossier riguardava Sema Hunsen, quattordici anni. Nata tra le pietraie vicino a Gaziantep, era riuscita a entrare in un liceo e a ottenere una borsa di studio statale. In apparenza era solo una giovane intelligente che desiderava rompere con le proprie origini, ma in realtà non voleva unicamente cambiare il proprio destino, voleva cambiare anche il suo paese. Nel comitato degli Idealisti di Gaziantep, Sema era la sola donna. Aveva fatto domanda per uno stage nel campo di Kayseri, per poter stare vicino a un ragazzo del suo stesso paese, Kürsat Milihit.
Quell’adolescente aveva subito attratto la sua attenzione. Gli piaceva quella volontà feroce, quel desiderio di uscire dalla propria condizione. Fisicamente, era una ragazza dai capelli rossi, piuttosto grassottella, con l’andatura da campagnola. Niente lasciava intuire le sue doti e la sua passione politica. Niente, tranne quello sguardo che ti lanciava dritto in faccia come una pietra.
Ismaïl Kudseyi lo sapeva: Azer e Sema sarebbero stati ben più che dei semplici borsisti, più che degli anonimi soldati al servizio delle sue idee di destra e dei suoi traffici criminali. Sarebbero stati, l’uno e l’altra, i suoi protetti, i suoi figli adottivi. Ma loro non avrebbero dovuto saperne nulla. Li avrebbe aiutati a distanza, nell’ombra.
Gli anni erano passati e i due eletti avevano mantenuto le loro promesse. A venticinque anni Azer si era laureato in fisica e chimica all’Università di Istanbul, poi, due anni dopo, aveva preso un diploma di commercio internazionale a Monaco. Sema, a diciassette anni, era uscita dal liceo Galatasaray con il massimo dei voti, ed era entrata nell’università inglese di Istanbul; parlava già quattro lingue: il turco, il francese, l’inglese e il tedesco.
Читать дальше