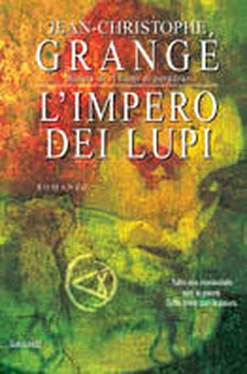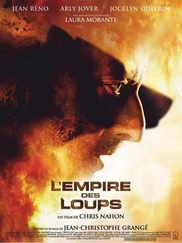Jean-Christophe Grangé
L’impero dei lupi
Per Priscilla
«Rosso.»
Anna Heymes si sentiva sempre più a disagio. L’esperimento non presentava alcun pericolo, ma l’idea che si potesse leggere a ogni istante nel suo cervello la turbava profondamente.
«Blu.»
Era distesa su un tavolo d’acciaio, al centro di una sala immersa nella penombra, la sua testa inserita nel foro centrale di una macchina bianca e circolare. Proprio sopra il suo viso c’era uno schermo inclinato sul quale venivano proiettati dei piccoli quadrati. Lei doveva semplicemente riconoscere i colori.
«Giallo.»
Una flebo colava lenta nel suo braccio sinistro. Il dottor Eric Ackermann le aveva brevemente spiegato che si trattava di un liquido di contrasto che permetteva di localizzare gli afflussi di sangue al cervello.
Si susseguirono altri colori. Verde. Arancio. Rosa… Poi lo schermo si spense.
Anna restò immobile, le braccia lungo il corpo, come in un sarcofago. Distingueva, a qualche metro sulla sua sinistra, il chiarore vago, acquatico, di una cabina vetrata dove c’erano Eric Ackermann e Laurent, suo marito. Immaginava i due uomini di fronte ai monitor a scrutare l’attività dei suoi neuroni. Si sentiva spiata, depredata, come violata nella sua intimità più segreta.
La voce di Ackermann risuonò nell’auricolare fissato al suo orecchio:
«Molto bene, Anna. Ora i quadrati si animeranno. Tu dovrai semplicemente descrivere i loro movimenti. Utilizzando una sola parola ogni volta: destra, sinistra, alto, basso…»
Subito le figure geometriche cominciarono a spostarsi, formando un mosaico screziato, fluido e morbido come un banco di piccoli pesci. Nel microfono collegato all’auricolare disse:
«Destra.»
I quadrati risalirono verso il bordo superiore dello schermo.
«Alto.»
L’esercizio durò diversi minuti. Lei parlava con una voce lenta, monocorde, si sentiva vinta dal torpore; il calore dello schermo accresceva quella pesantezza. Non avrebbe tardato a piombare nel sonno.
«Perfetto», disse Ackermann. Ora ti sottoporrò una storia, raccontata in diverse maniere. Ascolta attentamente ciascuna versione.
«Cosa devo dire?»
«Niente. Ascolta e basta.»
Dopo qualche secondo, una voce femminile risuonò nell’auricolare. Il discorso era pronunciato in una lingua straniera; sonorità asiatiche forse, o orientali.
Breve silenzio. La storia ricominciò, in francese. Ma la sintassi non era rispettata: verbi all’infinito, articoli senza accordo, preposizioni sbagliate…
Anna tentò di decrittare questo linguaggio sgangherato ma intanto era già cominciata un’altra versione. Adesso c’erano parole assurde che si infilavano nelle frasi… Cosa significava tutto ciò? D’un tratto il silenzio riempì i suoi timpani, sprofondandola ancor più nell’oscurità del cilindro.
Dopo un po’ il medico riprese:
«Test successivo. Per ogni nome di paese dimmi la capitale.»
Anna cercò di annuire quando il primo nome risuonò al suo orecchio:
«Svezia.»
Senza riflettere disse:
«Stoccolma.»
«Venezuela.»
«Caracas.»
«Nuova Zelanda.»
«Auckland. No, Wellington.»
«Senegal.»
«Dakar.»
Ogni capitale le veniva in mente con naturalezza. Le sue risposte erano semplici riflessi, ma lei era felice di quei risultati; dunque la sua memoria non era totalmente perduta. Cos’è che Ackermann e Laurent vedevano sui loro schermi? Quali zone si stavano attivando nel suo cervello?
«Ultimo test», avvertì il neurologo. «Appariranno dei volti. Tu identificali ad alta voce, il più rapidamente possibile.»
Aveva letto da qualche parte che un semplice segno — una parola, un gesto, un dettaglio visivo — scatenava il meccanismo della fobia; quello che gli psichiatri chiamano il segnale dell’angoscia. Segnale: il termine era perfetto. Nel suo caso, la sola parola «volto» era sufficiente a provocare il malessere. Immediatamente si sentiva soffocare, il suo stomaco diventava pesante, le sue membra si anchilosavano — e quel raschiare che le bruciava la gola…
Sullo schermo apparve un volto di donna, in bianco e nero. Riccioli biondi, labbra corrucciate, neo di bellezza sopra la bocca. Facile:
«Marilyn Monroe.»
Alla fotografia fece seguito un’incisione. Sguardo tenebroso, mascella quadrata, capelli ondulati:
«Beethoven.»
Un viso rotondo, liscio come una bomboniera, solcato da due occhi a mandorla.
«Mao Tse-Tung.»
Anna era stupita di riconoscerli così facilmente. Ne seguirono altri: Michael Jackson, la Gioconda, Albert Einstein… Aveva l’impressione di contemplare le proiezioni lucenti di una lanterna magica. Rispondeva senza esitazione. Il suo turbamento già diminuiva.
Ma all’improvviso, un ritratto la tenne in scacco; un uomo d’una quarantina d’anni, l’espressione ancora giovanile, gli occhi prominenti. Il biondo dei capelli e delle sopracciglia gli dava un’aria indecisa, da adolescente.
La paura la attraversò, come un’onda elettrica. Quei tratti risvegliavano in lei una reminiscenza che però non richiamava alcun nome, alcun ricordo preciso. La sua memoria era in un tunnel oscuro. Dove l’aveva già vista quella faccia? Un attore? Un cantante? Un lontano conoscente? L’immagine lasciò il posto a un volto allungato con due occhialini rotondi. Con la bocca secca disse:
«John Lennon.»
Apparve Che Guevara, ma Anna implorò:
«Eric, aspetta.»
Il carosello continuò. Scintillò un autoritratto di Van Gogh dai colori aciduli. Anna prese lo stelo del microfono:
«Eric, per favore!»
Le immagini continuarono a scorrere. Anna sentiva i colori e il calore riflettersi sulla sua pelle. Dopo una pausa Ackermann domandò:
«Cosa c’è?»
«Chi è quello che non ho riconosciuto?»
Nessuna risposta. Gli occhi chiari di David Bowie vibrarono sullo schermo. Lei si alzò e disse più forte:
«Eric, ti ho fatto una domanda: chi era?»
Lo schermo si spense. In un secondo i suoi occhi si abituarono all’oscurità. Vide il suo riflesso nel rettangolo obliquo del monitor: livido, ossuto. Il viso di una morta.
Alla fine, il medico rispose:
«Era Laurent, Anna. Laurent Heymes, tuo marito.»
«Da quanto tempo soffri di queste amnesie?»
Anna non rispose. Era quasi mezzogiorno: era stata sottoposta a esami per tutta la mattina. Radiografie, tomografie, risonanze e, per finire, tutti quei test nella macchina circolare… Si sentiva svuotata, spossata, perduta. E quell’ufficio non aggiustava certo le cose: una stanza stretta, senza finestre, troppo illuminata, dove, negli armadi metallici e persino sul pavimento, si accatastavano disordinatamente dei dossier. Sui muri c’erano stampe che raffiguravano cervelli, crani rasati con linee di perforazione che sembravano fustellature. Proprio quello che ci voleva per lei…
Eric Ackermann ripeté:
«Da quanto tempo, Anna?»
«Più di un mese.»
«Sii precisa. Tu ti ricordi la prima volta, non è vero?»
Certo che se ne ricordava: come avrebbe potuto dimenticarlo?
«Era il 4 febbraio scorso. Un mattino. Uscivo dal bagno. Ho incrociato Laurent nel corridoio. Era pronto per andare in ufficio. Mi ha sorriso. Mi sono spaventata: non capivo chi fosse.»
«Del tutto sconosciuto?»
«Sì, per un secondo. Poi, nella mia testa tutto si è sistemato.»
«Descrivimi esattamente quello che hai provato in quell’istante.»
Lei scosse le spalle, un gesto d’indecisione sotto lo scialle nero e oro:
«Era una sensazione strana, fugace. Come l’impressione di aver già vissuto qualche cosa. Il malessere è durato solo il tempo di un lampo», disse schioccando le dita. «Poi tutto è tornato normale.»
Читать дальше