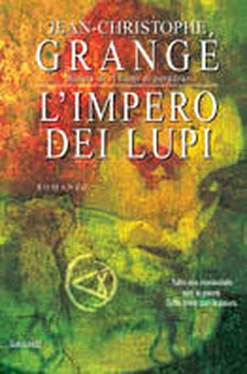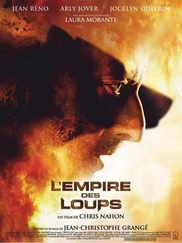«Poi?»
«Poi, niente. Non ho mai più avuto notizie.»
«Non mi prendere per il culo.»
Beauvanier esitò. La sua fronte era imperlata di sudore, gli occhi bassi.
«Il giorno dopo mi ha chiamato Charlier in persona. Mi ha fatto un mucchio di domande su quella faccenda. Dove avevamo trovato la ragazza turca, in quali circostanze, cose così.»
«Cosa gli hai risposto?»
«Quello che sapevo.»
«Cioè niente», pensò Schiffer. Il poliziotto con il cappellino terminò:
«Charlier mi ha avvertito che si sarebbe incaricato lui della questione. La comunicazione alla Procura, al Servizio di controllo degli stranieri, la procedura abituale insomma. Mi ha anche fatto capire che era nel mio interesse dimenticare il tutto.»
«Hai ancora il tuo rapporto?»
«Secondo te? Sono passati a prenderlo il giorno stesso.»
«E il registro?»
Il sorriso si trasformò in risata.
«Quale registro? Ehi, man , hanno cancellato tutto. Anche le registrazioni del traffico radio. Hanno fatto sparire il testimone! Completamente e semplicemente.»
«Perché?»
«E io che cosa ne so? Quella ragazza non poteva dire niente. Era fuori come un balcone.»
«E tu, perché non hai fatto niente?»
Il poliziotto abbassò la voce:
«Charlier mi tiene in pugno. Una vecchia storia…»
Schiffer gli piazzò un diretto nel braccio, in modo amichevole, poi si alzò. Cercava di digerire quelle informazioni, camminando per la stanza. Per incredibile che potesse sembrare, il sequestro di Sema Gokalp da parte della DNAT riguardava un affare diverso. Un affare che non aveva niente a che vedere con la serie di omicidi e con i Lupi grigi. E tuttavia, l’importanza della testimone per la sua inchiesta non veniva messa in discussione. Doveva trovare Sema Gokalp, perché lei aveva visto qualcosa.
«Hai ripreso servizio?» arrischiò Beauvanier.
Schiffer si risistemò i pantaloni bagnati e ignorò la questione. Notò sulla scrivania uno degli identikit di Nerteaux. L’afferrò, come un cacciatore di taglie, e domandò:
«Ti ricordi il nome del medico che ha preso in carico Sema al Sainte-Anne?»
«Eccome. Jean-François Hirsch. Mi ha dato una mano per delle ricette…»
Schiffer non ascoltava più. Il suo sguardò si posò di nuovo sull’identikit. Era un’abile sintesi dei volti delle tre vittime. Lineamenti larghi e dolci che splendevano timidamente sotto i capelli rossi. Gli tornò in mente un frammento di una poesia turca:
« Il padichah aveva una figlia / Che assomigliava alla luna nel quattordicesimo giorno… »
Beauvanier azzardò ancora:
«La storia della Porte Bleue ha qualche rapporto con questa tizia?»
Schiffer si mise in tasca l’identikit. Afferrò la visiera del cappellino del poliziotto e la raddrizzò:
«Se qualcuno ti fa delle domande non avrai certo difficoltà a trovare qualcosa da raccontare a ritmo di rap, man. »
Ospedale Sainte-Anne, ore ventuno.
Conosceva bene il posto. Il lungo muro di cinta con le pietre fittamente accostate, la piccola porta, al 17 di rue Broussais, discreta quanto l’ingresso degli artisti in un teatro. Poi la città nella città, complessa, immensa. Un insieme di blocchi e di padiglioni in un miscuglio di secoli e di architetture. Una vera fortezza, che racchiudeva un universo di demenza.
Tuttavia, quella sera la cittadella non sembrava così ben sorvegliata. Fin dai primi edifici, gli striscioni annunciavano un clima particolare: «Sicurezza in sciopero», «Assunzioni o morte!» Più in là, altre scritte: «No agli straordinari», «Ferie rubate»…
Schiffer fu divertito dall’idea del più grande ospedale psichiatrico di Parigi abbandonato a sé stesso, con i pazienti che gironzolavano liberamente. Immaginava già una rivolta dei pazzi, un casino generalizzato dove, nottetempo, i malati prendevano il posto dei medici. Ma, entrando, scoprì solo una città fantasma, totalmente deserta.
Seguì i cartelli rossi che indicavano la direzione del pronto soccorso neurochirurgico e neurologico, e, di sfuggita, notò i nomi dei vialetti. Aveva appena lasciato il viale Guy de Maupassant e ora risaliva il sentiero Edgar Allan Poe. Si chiese se chi aveva concepito quell’ospedale avesse avuto un intento ironico. Maupassant era sprofondato nella follia, e anche l’autore di Il pozzo e il pendolo , ormai alcolizzato, certo non aveva finito la sua esistenza con le idee molto chiare. Nelle città comuniste le vie si chiamavano Karl Marx o Pablo Neruda. Al Sainte-Anne, avevano il nome di pazzi famosi.
Schiffer tirò su il colletto, sforzandosi di giocare il suo consueto ruolo da duro, ma sentiva la paura crescere dentro di sé. Troppi ricordi, troppe ferite dietro quei muri…
Dopo l’Algeria era finito lì, in uno di quegli edifici; e aveva solo vent’anni. Nevrosi di guerra. Era stato internato per diversi mesi, inseguito dalle sue allucinazioni, roso dalle idee di suicidio. Altri che, ad Algeri, avevano lavorato al suo fianco ai Distaccamenti operativi di protezione, non avevano esitato tanto. Si ricordava di un ragazzo di Lille che si era impiccato appena tornato a casa. E di quel bretone che, nella fattoria di famiglia, con un’ascia si era tagliato la mano destra, la mano che aveva collegato gli elettrodi, che aveva spinto le nuche dentro le vasche da bagno…
La sala del pronto soccorso era deserta.
Un grande quadrato vuoto, rivestito di piastrelle color porpora. La polpa di un’arancia sanguigna. Schiffer premette il campanello e vide arrivare un’infermiera all’antica: grembiale allacciato in vita, capelli raccolti e occhiali bifocali.
Nel vederlo così male in arnese ebbe un gesto di disappunto, ma lui, con un movimento secco, le mostrò il tesserino e le spiegò ciò che voleva. Senza dire una parola, l’infermiera partì, alla ricerca del dottor Jean-François Kirsch.
Si sedette su una delle panche fissate al muro. Gli sembrò che le pareti di mattonelle si stessero scurendo. Malgrado i suoi sforzi, non riusciva ad arginare i ricordi che sorgevano dal fondo della sua memoria.
1960
Quando era arrivato ad Algeri per diventare «agente dei servizi informazioni», non aveva cercato di defilarsi, né di attenuare l’atrocità del lavoro con l’alcol o con le pastiglie dell’infermeria. Al contrario: ci si era buttato a capofitto, giorno e notte, convinto che sarebbe rimasto padrone del proprio destino. La guerra lo aveva costretto alla grande scelta, la sola, l’unica: la sua scelta di campo. Non poteva tornare indietro, né voltarsi. E non poteva permettersi di aver torto: andare avanti o farsi saltare le cervella.
Aveva praticato la tortura giorno e notte, strappando confessioni ai ribelli algerini. Dapprima con i metodi consueti: pugni, scosse elettriche, vasca da bagno. Poi con tecniche personali. Aveva organizzato finte esecuzioni, portando i prigionieri incappucciati fuori della città e guardandoli mentre si pisciavano addosso quando puntava loro la pistola alla tempia. Aveva preparato cocktail a base di acido che somministrava a forza, ficcando l’imbuto in gola. Aveva rubato strumenti medici all’ospedale, per creare qualche variante, come quella pompa per lo stomaco che utilizzava per iniettare l’acqua nelle narici…
La paura lui la modellava, la scolpiva, le dava forma in modo sempre più intenso. Quando aveva deciso di dissanguare i propri prigionieri per indebolirli e per dare il loro sangue alle vittime degli attentati, aveva provato una strana ebbrezza. Si era sentito un dio che possedeva il diritto di vita e di morte. Talvolta, nella sala degli interrogatori, rideva da solo, accecato dal proprio potere, mentre contemplava con meraviglia il sangue che gli ricopriva le dita.
Читать дальше