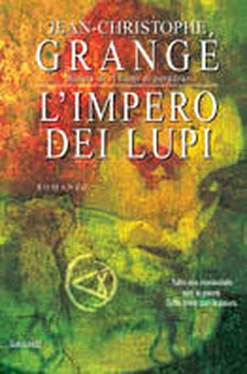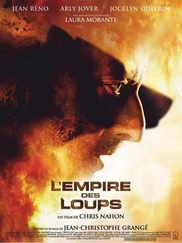Adorava quell’angolo del quartiere, nascosto agli sguardi, sconosciuto persino alla maggior parte degli abitanti dell’isolato; un cuore nel cuore, una trincea che faceva perdere tutti i punti di riferimento, verticali e orizzontali. Il passaggio era sbarrato da una porta di ferro arrugginita. Vi posò sopra una mano: era tiepida.
Sorrise, poi bussò con forza.
Dopo un po’, un uomo venne ad aprire, liberando una nuvola di vapore. Schiffer diede qualche spiegazione in turco. Il portiere si scostò per lasciarlo entrare. Il poliziotto notò che era a piedi nudi. Nuovo sorriso: nulla era cambiato. Si tuffò in quell’afa.
La luce bianca gli rivelò un quadro familiare: il corridoio di ceramica, i grossi tubi coibentati sospesi al soffitto e rivestiti di tessuto d’un pallido verde chirurgico, i ruscelli di lacrime sul pavimento, le porte bombate in ferro, imbiancate a calce, che sembravano portelloni di caldaia.
Camminarono per qualche minuto. Schiffer sentiva lo sciacquio delle scarpe nelle pozzanghere. Il suo corpo era già madido di sudore. Svoltarono in un nuovo budello di piastrelle bianche, saturo di nebbia. A destra, un’apertura rivelò la presenza di un laboratorio dal quale giungeva un rumore di respiro.
Schiffer si fermò a contemplare lo spettacolo.
Sotto un soffitto di tubi e canalizzazioni punteggiate qua e là da luci, una trentina di operaie, con i piedi nudi e maschere bianche sul viso, si affannava sulle vasche e sugli assi da stiro. Getti di vapore fischiavano a ritmo regolare nell’aria satura di odori di detergenti e di alcol.
Schiffer sapeva che la stazione di pompaggio del bagno turco si trovava nelle vicinanze, da qualche parte sotto i loro piedi, e attingeva acqua a più di ottocento metri di profondità, facendola circolare nelle condutture demineralizzata, clorata, riscaldata prima di essere portata sia al bagno turco vero e proprio, sia verso quella tintoria clandestina. Gurdilek aveva avuto l’idea di accostare la lavanderia ai propri bagni, per sfruttare un unico sistema di canalizzazione. Un modo per fare economia: non una sola goccia d’acqua andava perduta.
Passando, il poliziotto si rifece gli occhi osservando le donne con la maschera di cotone e la fronte lucida di sudore. Le bluse bagnate fasciavano i seni e le natiche, grandi e morbide come piacevano a lui. Si accorse di essere in erezione. Lo considerò un buon auspicio.
Ripresero il loro cammino.
Il calore e l’umidità continuavano a crescere. Per un attimo si sentì uno strano profumo, poi sparì, tanto che Schiffer credette di averlo sognato. Ma qualche passo più in là ricomparve e divenne più netto.
Questa volta Schiffer ne era certo.
Si mise a respirare a basso regime. Sentiva pizzicare le narici e la gola. Il suo sistema respiratorio fu assalito da sensazioni contraddittorie. Aveva la sensazione di succhiare un cubetto di ghiaccio, ma la sua bocca era in fiamme. Quell’odore bruciava e rinfrescava al tempo stesso, aggredendo e purificando in un unico respiro.
La menta.
Avanzarono ancora. L’odore divenne un fiume, un mare nel quale Schiffer si stava immergendo. Era ancora peggio di quanto si ricordasse. A ogni passo egli si trasformava sempre più in una bustina d’infusione sul fondo di una tazza. I suoi polmoni erano paralizzati da un freddo da iceberg, mentre la faccia sembrava una maschera di cera bollente.
Respirava ormai solo con brevi boccate, e quando arrivò in fondo al corridoio era sull’orlo dell’asfissia. Pensò che stava avanzando in un inalatore gigante e, sapendo che non era lontano dalla verità, entrò nella sala del trono.
Era una piscina vuota, poco profonda, circondata da fini colonne bianche che si stagliavano sullo sfondo sfocato del vapore; il bordo era segnato da piastrelle blu di Prussia, nello stile delle vecchie stazioni del metrò. La parete di fondo era tappezzata di paraventi in legno sui quali erano traforati motivi ornamentali ottomani: lune, croci, stelle.
Al centro della vasca c’era un uomo seduto su un blocco di ceramica, con uno spesso asciugamano bianco annodato intorno alla vita, il viso annegato nelle tenebre.
Il suo riso risuonò nel vapore bollente.
Il riso di Talat Gurdilek, l’uomo menta, l’uomo dalla voce bruciata.
Nel quartiere turco la sua storia la conoscevano tutti.
Era arrivato in Europa nel 1961, nel doppio fondo di un’autobotte, secondo il metodo classico. In Anatolia avevano messo su di lui e sui suoi compagni di viaggio una paratia di ferro che poi avevano imbullonato. I clandestini dovevano restare così, distesi, senza aria né luce, per circa quarantotto ore.
Ben presto erano stati oppressi dal caldo e dalla mancanza d’aria. Poi, durante la traversata delle montagne, in Bulgaria, il freddo, trasmesso dal metallo, gli era penetrato fin nelle ossa. Ma il peggio era cominciato ai confini con la Jugoslavia, quando la cisterna, piena di acido, aveva cominciato a perdere.
Lentamente, la vasca aveva distillato i suoi vapori tossici nel sarcofago di metallo. I turchi avevano urlato, bussato, scosso la paratia che li schiacciava, ma il camion aveva proseguito la sua strada. Talat aveva capito che nessuno sarebbe venuto a liberarli prima dell’arrivo e che gridare e muoversi non faceva che aumentare i danni dell’acido.
Era rimasto tranquillo, respirando il meno possibile.
Alla frontiera italiana, i clandestini si erano dati la mano e si erano messi a pregare. Alla frontiera tedesca, la maggior parte di loro era morta. A Nancy, dov’era previsto il primo sbarco, il guidatore aveva scoperto trenta cadaveri allineati, immersi nell’urina e negli escrementi, la bocca aperta in un ultimo spasmo.
Solo un adolescente era sopravvissuto. Ma il suo apparato respiratorio era distrutto. La sua trachea, la laringe e le fosse nasali erano irrimediabilmente bruciate, e il ragazzo aveva perso la voce e l’odorato. Quanto alla respirazione, un’infiammazione cronica l’avrebbe obbligato a inalare in permanenza suffumigi caldi e umidi.
All’ospedale, il dottore aveva fatto venire un traduttore per spiegare al giovane immigrato la triste situazione e per comunicargli che sarebbe ripartito nel giro di dieci giorni, a bordo di un volo charter, alla volta di Istanbul. Tre giorni dopo, Talat Gurdilek scappava, con il volto bendato come una mummia, e raggiungeva la capitale a piedi.
Schiffer l’aveva sempre visto con in mano il suo inalatore. Quando era un giovane capo officina, non lo lasciava mai e parlava tra una vaporizzazione e l’altra. Più tardi, aveva adottato una maschera traslucida che imprigionava la sua voce roca. Poi, il male si era ulteriormente aggravato, ma i suoi mezzi finanziari erano aumentati. Alla fine degli anni Ottanta, Gurdilek aveva costruito l’hammam La Porte Bleue, in rue du Faubourg-Saint-Denis, e aveva attrezzato una sala a uso personale. Una sorta di polmone gigante, un rifugio piastrellato, saturo di vapori di balsamo mentolato.
« Salaam aleikum , Talat. Scusa se ti disturbo durante le tue abluzioni.»
L’uomo si lasciò sfuggire una nuova risata, avvolta in una miscela di vapori:
« Aleikum salaam , Schiffer. Ritorni dal regno dei morti?»
La voce del turco ricordava il sibilo di rami in fiamme.
«Più che altro, sono i morti che mi mandano.»
«Aspettavo la tua visita.»
Schiffer, bagnato fino al midollo, si tolse l’impermeabile e scese gli scalini della vasca:
«Si direbbe che mi aspettano tutti. Degli omicidi che cosa mi dici?»
Il turco fece un respiro profondo e i suoi polmoni produssero un raschiamento di ferraglia:
«Quando ho lasciato il mio paese, mia madre ha versato dell’acqua dietro ai miei passi. Ha disegnato la strada del destino, la strada che avrebbe dovuto farmi tornare. Io non sono mai tornato, fratello. Sono rimasto a Parigi e ho continuato a vedere le cose che peggioravano. Non c’è più niente che vada bene qui.»
Читать дальше