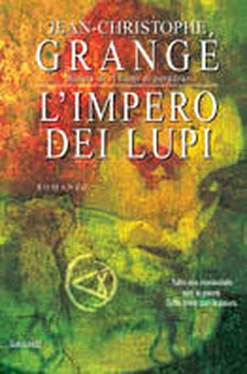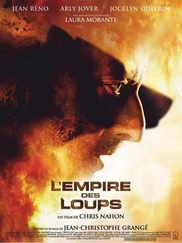«Per il resto, nessuna traccia significativa di un ambiente, di una atmosfera.»
Prese un piccolo flacone e si avvicinò di nuovo ad Anna:
«I suoi globuli non hanno conservato i ricordi che speravo, signora. Passiamo a un altro tipo di analisi. Ci sono regioni del nostro corpo che non conservano l’impronta, ma direttamente le particelle degli agenti esterni. Frugheremo in questi “microstok”.»
Brandì il flacone.
«Devo chiederle di fare pipì in questo recipiente.»
Anna si alzò lentamente e raggiunse la cabina. Un’autentica sonnambula. Mathilde riprese la parola:
«Non capisco cosa lei speri di trovare nell’urina. Stiamo cercando tracce che risalgono a circa un anno e…»
Lo studioso la fermò sorridendo:
«L’urina è prodotta dai reni, che agiscono come dei filtri. In questi filtri si accumulano dei cristalli. Io posso mostrare le tracce di quelle concrezioni. Hanno parecchi anni e possono informarci, ad esempio, sulle abitudini alimentari del soggetto.»
Anna tornò nella stanza con in mano il flacone. Sembrava sempre più assente, sempre più estranea al lavoro di cui era l’oggetto.
Veynerdi utilizzò di nuovo la centrifuga per separare gli elementi, poi andò a un’altra macchina, più imponente: uno spettrometro di massa. Depositò il liquido dorato all’interno della vaschetta, poi lanciò il processo di analisi.
Sullo schermo di un computer si visualizzarono delle onde verdastre. Lo scienziato schioccò la lingua con disappunto:
«Niente. Ecco una ragazza che non si lascia decifrare facilmente…»
Cambiò atteggiamento. Raddoppiò la concentrazione, moltiplicò i prelievi, le analisi, si tuffò letteralmente nel corpo di Anna.
Mathilde seguiva ogni suo movimento e ascoltava i commenti.
Dapprima raccolse delle particelle di dentina, tessuto vivo situato all’interno dei denti che accumulava alcuni prodotti drenati dal sangue, come gli antibiotici. Poi si interessò alla melatonina prodotta dal cervello. Secondo lui, il tasso di quell’ormone, secreto soprattutto la notte, poteva rivelare le vecchie abitudini «sonno/veglia» di Anna.
In seguito prelevò con precauzione alcune gocce del liquido contenuto nell’occhio, dove potevano accumularsi residui infinitesimali prodotti dal cibo. Infine, tagliò dei capelli, sapendo che essi conservavano la memoria delle sostanza esogene, fino al punto da secernerle a loro volta. Il fenomeno era noto: un cadavere avvelenato con l’arsenico continua a essudare quella sostanza anche dopo la morte e lo fa attraverso la radice dei capelli.
Dopo tre ore di ricerche, lo scienziato batté in ritirata: non aveva scoperto niente, o quasi. Il ritratto che poteva fare dell’Anna di prima era insignificante. Una donna che fumava e che, per il resto, conduceva una vita molto sana. Una donna che doveva soffrire di insonnia, a giudicare dal tasso irregolare di melatonina; una donna che, fin dall’infanzia, aveva consumato dell’olio d’oliva, come dimostravano le tracce di acidi grassi trovate al fondo dell’occhio. L’ultimo punto era che si tingeva i capelli di nero; al naturale lei era invece castana, un castano che virava sul rosso.
Alain Veynerdi si tolse i guanti e si lavò le mani nel lavandino del bancone. La sua fronte era imperlata da minuscole goccioline di sudore. Sembrava deluso e spossato.
Si avvicinò ad Anna, che ora dormiva di nuovo. Le girò intorno, come se volesse cercare ancora, seguendo una traccia, un segno, un sospetto che gli permettesse di decifrare quel corpo diafano.
All’improvviso di chinò sulle sue mani. Prese le dita e le osservò con attenzione. La svegliò con uno scossone. Appena aprì gli occhi, lui, con un’eccitazione trattenuta a malapena, le chiese:
«Su una delle sue unghie c’è una macchia scura: sa da dove viene?»
Anna lanciò intorno a sé un’occhiata smarrita. Poi si guardò la mano e inarcò le sopracciglia:
«Non so», borbottò. «Nicotina, no?»
Mathilde si avvicinò e scorse anche lei una minuscola puntina d’ocra in cima all’unghia.
«Con quale frequenza si taglia le unghie?» chiese il biologo.
«Non so. Forse… Più o meno ogni tre settimane.»
«Ha la sensazione che crescano in fretta?»
Anna sbadigliò senza rispondere. Veynerdi ritornò verso il bancone, mormorando: «Come ho fatto a non pensarci.» Prese delle forbicine, una scatola trasparente, poi si avvicinò ad Anna e tagliò il frammento che sembrava così interessante.
«Se crescono normalmente», commentò a voce bassa, «queste estremità cornee risalgono al periodo che precede il suo incidente. Questa macchia appartiene alla sua vita passata.»
Riaccese le macchine. Mentre i motori ronzavano di nuovo, diluì il campione in una provetta contenente del solvente.
«Abbiamo avuto fortuna», riprese. «Ancora qualche giorno e lei si sarebbe tagliata le unghie, perdendo così questa preziosa testimonianza.»
Piazzò la provetta nella centrifuga e avviò il meccanismo.
«Se è nicotina», arrischiò Mathilde, «non vedo cosa possa…»
Veynerdi mise il liquido nello spettrometro:
«Forse posso trovare la marca di sigarette che questa signorina fumava prima dell’incidente.»
Mathilde non capiva il suo entusiasmo; un simile dettaglio non avrebbe significato molto. Sullo schermo della macchina, Veynerdi osservava i diagrammi luminescenti. I minuti passavano.
«Professore», si spazientì Mathilde, «non capisco. Non c’è davvero da essere così contenti. Io…»
«Straordinario.»
Illuminato dal monitor, il viso del biologo assunse un’espressione di meraviglia:
«Non è nicotina.»
Mathilde si avvicinò allo spettrometro. Anna si sedette sulla tavola metallica. Veynerdi girò la sedia verso le due donne.
«È henné.»
Il silenzio si aprì come un mare.
Il ricercatore strappò il nastro di carta millimetrata che la macchina aveva appena finito di stampare, poi digitò dei dati sulla tastiera di un computer. Lo schermo mostrò una lista di componenti chimici.
«Secondo il mio catalogo delle sostanze, questa macchia corrisponde a una composizione vegetale specifica. Un henné molto raro, coltivato nelle pianure dell’Anatolia.»
Alain Veynerdi posò il suo sguardo trionfante su Anna. Sembrava che avesse sempre vissuto per quell’istante:
«Signora, nella sua vita precedente lei era turca.»
La bocca impastata di incubi.
Tutta la notte, Paul Nerteaux aveva sognato un mostro di pietra, un titano malefico che percorreva in lungo e in largo il decimo arrondissement; un Moloch che terrorizzava il quartiere turco ed esigeva vittime sacrificali.
Nel suo sogno, il mostro portava una maschera mezza umana e mezza animale, d’origine greca e persiana al tempo stesso. Le sue labbra minerali erano al calor bianco, il suo sesso armato di lame. Ogni suo passo provocava un tremito che sollevava la polvere e fessurava gli edifici.
Aveva finito per svegliarsi alle tre del mattino, coperto di sudore. Tremando, nel suo piccolo appartamento di tre stanze, si era fatto un caffè e si era immerso nei nuovi documenti archeologici che i ragazzi della Brigata anticrimine gli avevano portato la sera precedente.
Fino all’alba, aveva sfogliato i cataloghi dei musei, i depliant turistici, i libri scientifici, osservando nei dettagli ogni scultura, comparandola con le foto delle autopsie e, inconsciamente, con la maschera del suo sogno. Sarcofagi di Antalia. Affreschi della Cilicia. Bassorilievi di Karatepe. Busti di Efeso…
Aveva attraversato le età, le civiltà, senza ottenere il minimo risultato.
Paul Nerteaux entrò nella brasserie Les Trois Obus, alla Porte de Saint-Cloud. Affrontò gli odori del caffè e del tabacco, sforzandosi di sigillare i propri sensi e di reprimere la nausea.
Читать дальше