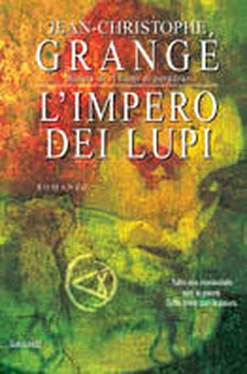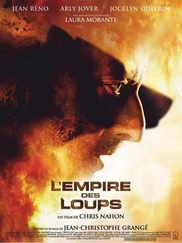Aveva finito per litigare con gli amici più intimi e si era ritrovata sola, veramente sola. In mancanza di avversari, si era dedicata allo sport, per confrontarsi con sé stessa. L’ansia di risultati passò attraverso l’alpinismo, il canottaggio, il parapendio, il tiro… L’allenamento era diventato una sfida permanente, un’ossessione che drenava le sue angosce.
Ora, aveva chiuso con quegli eccessi, ma la sua vita era ancora punteggiata di prove ricorrenti. Stage di parapendio nelle Cévennes, ascensione annuale delle «Dalles», vicino a Chamonix, prova di triathlon in Valle d’Aosta. A cinquantadue anni aveva una forma fisica da far impallidire qualsiasi adolescente. E ogni giorno guardava, con un filo di vanità, i trofei che scintillavano sul suo comò, un pezzo autentico della scuola di Oppenordt.
Per la verità, c’era un’altra vittoria che la riempiva d’orgoglio; una prodezza intima e segreta. Non una sola volta, in quegli anni di solitudine, era ricorsa ai farmaci. Non un ansiolitico, non un antidepressivo.
Ogni mattina si guardava allo specchio e si ricordava di quella performance. Il gioiello del suo palmarès. Una prova di resistenza a testimonianza del fatto che non aveva esaurito le sue scorte di coraggio e di volontà.
La maggior parte delle persone vive nella speranza di qualcosa di meglio.
Mathilde Wilcrau non temeva più il peggio.
Certo, nel bel mezzo di quel deserto le restava il lavoro. Le consulenze all’ospedale Sainte-Anne, le sedute nel suo studio privato. Lo stile duro e lo stile morbido, come si diceva nelle arti marziali che aveva praticato. La cura psichiatrica e l’ascolto psicanalitico. Ma i due poli, alla lunga, avevano finito per confondersi nella stessa routine.
I suoi orari erano ora segnati da alcuni rituali, intimi e necessari. Una volta alla settimana cenava con i figli, che parlavano solo dei loro successi e delle sconfitte del padre e della madre. Ogni fine settimana, tra due sessioni di allenamento, andava per antiquari. E poi, il martedì sera, partecipava ai seminari della Società di Psicanalisi, dove incrociava volti familiari. Soprattutto volti di ex amanti, che le erano sempre sembrati insulsi e dei quali, talvolta, aveva perfino dimenticato il nome. Ma forse era lei che aveva perso il gusto dell’amore. Come quando ci si brucia la lingua e non si sentono più i gusti dei cibi…
Diede un’occhiata all’orologio; più di cinque minuti alla fine della seduta. L’uomo continuava a parlare. Lei si agitò sulla sua poltrona. Il suo corpo già formicolava delle sensazioni che sarebbero giunte di lì a poco: la secchezza della gola nel pronunciare le parole di conclusione dopo il lungo silenzio, la dolcezza della stilografica sull’agenda nell’annotare l’appuntamento successivo, il fruscio del cuoio al suo alzarsi…
Più tardi, nell’ingresso, il paziente si girò e domandò con voce angosciata:
«Non mi sono spinto troppo in là, dottore?»
Mathilde fece cenno di no, con un sorriso, e aprì la porta. Cos’aveva trascurato di così importante quel giorno? Non era grave, la prossima volta avrebbe fatto meglio. Uscì sul pianerottolo e premette l’interruttore.
La vide e lanciò un grido.
La donna stava acquattata contro il muro, stretta nel suo kimono nero. Mathilde la riconobbe subito: Anna qualcosa. Quella che aveva bisogno di un buon paio d’occhiali. Tremava dalla testa ai piedi, livida. Cos’era quel delirio?
Mathilde sospinse l’uomo nelle scale e si voltò incollerita verso la piccola bruna. Non tollerava che un paziente arrivasse così, senza avvertire, senza appuntamento. Un buon psicanalista doveva sempre fare pulizia davanti alla propria porta.
Era pronta a darle una buona lavata di capo, ma la donna fu più veloce e le mise sotto il naso la propria radiografia facciale:
«Hanno cancellato la mia memoria. Hanno cancellato il mio volto.»
Psicosi paranoica.
La diagnosi era chiara. Anna Heymes sosteneva di esser stata manipolata dal marito e da Eric Ackermann, nonché da uomini delle forze di polizia francesi. Diceva di aver subito, a propria insaputa, un lavaggio del cervello che l’aveva privata di una parte della memoria. Di essere stata sottoposta a interventi di chirurgia estetica che le avevano modificato il viso. Non sapeva né come né perché, ma era stata vittima di un complotto, di un esperimento che aveva mutilato la sua personalità.
Le aveva spiegato tutto questo con un tono affannato, brandendo la sigaretta come la bacchetta di un direttore d’orchestra. Mathilde l’aveva ascoltata pazientemente, notando a ogni passaggio la sua magrezza: l’anoressia poteva essere sintomo di paranoia.
Anna Heymes aveva poi finito di raccontare una storia che non stava né in cielo né in terra. Aveva scoperto la macchinazione quel mattino stesso, in bagno, notando delle cicatrici in faccia, mentre il marito si preparava a portarla nella clinica di Ackermann.
Era scappata dalla finestra, era stata inseguita da poliziotti in borghese, armati fino ai denti, equipaggiati di ricetrasmittenti. Si era nascosta nella chiesa ortodossa, poi si era fatta radiografare il volto all’ospedale Saint-Antoine per avere una prova tangibile della sua operazione. Infine aveva vagabondato fino a sera, aspettando il buio per rifugiarsi presso la sola persona in cui aveva fiducia: Mathilde Wilcrau. Ecco tutto.
Psicosi paranoica.
All’ospedale Sainte-Anne, Mathilde aveva curato centinaia di casi analoghi. La prima cosa da fare era calmare la crisi. A forza di parole di conforto, era riuscita a iniettare alla giovane donna cinquanta milligrammi di Tranxene intramuscolo.
Ora, Anna Heymes dormiva sul divano. Mathilde stava seduta dietro la scrivania, nella sua posizione abituale.
Avrebbe dovuto telefonare a Laurent Heymes. Avrebbe potuto occuparsi di persona del ricovero di Anna all’ospedale, o avvisare direttamente Eric Ackermann, il medico curante. Nel giro di qualche minuto tutto sarebbe stato sistemato. Un semplice affare di routine.
E allora perché non chiamava? Da più di un’ora stava là, senza alzare il telefono. Osservava i frammenti di mobili che luccicavano nell’oscurità, alla luce della finestra. Erano anni che Mathilde era circondata da quei pezzi d’antiquariato in stile rococò; oggetti acquistati per la maggior parte da suo marito e per i quali si era battuta al momento del divorzio. In un primo momento per rompergli le scatole; poi, se n’era resa conto, per conservare qualcosa di lui. Non si era mai decisa a venderli e ora viveva in un santuario. Un mausoleo pieno di vecchie cose lucenti che le ricordavano i soli anni che avevano contato veramente.
Psicosi paranoica. Un vero caso da manuale.
Salvo il fatto che c’erano quelle cicatrici. Quelle linee che aveva visto sulla fronte, sulle orecchie e sul mento della giovane donna. Aveva persino sentito, sotto la pelle, le viti e gli impianti che sostenevano la struttura ossea del viso. Cucita sulla faccia, Arma Heymes portava una vera e propria maschera. Una crosta di pelle, lavorata, suturata, che dissimulava le sue ossa spezzate e i suoi muscoli atrofizzati.
Era possibile che dicesse semplicemente la verità? Che degli uomini, dei poliziotti per di più, le avessero fatto subire un simile trattamento? Che le avessero fracassato le ossa della faccia? Che le avessero manomesso la memoria?
In quell’affare c’era poi un altro elemento che la turbava: la presenza di Eric Ackermann. Si ricordava di quel tipo, rosso di capelli, dal viso deturpato da macchie e dall’acne. Uno dei suoi numerosi spasimanti all’università, ma soprattutto uno dall’intelligenza particolare, quasi un esaltato.
All’epoca era appassionato dal cervello e dai «viaggi interiori». Aveva seguito gli esperimenti di Timothy Leary sull’LSD, all’università di Harvard, e con quel metodo pretendeva di esplorare regioni sconosciute della coscienza. Consumava ogni sorta di droga psicotropa, analizzando i suoi stessi deliri. Arrivava persino a mettere di nascosto dell’LSD nel caffè degli altri studenti, solo «per vedere». Mathilde sorrise ricordando quei deliri. Tutta un’epoca: il rock psichedelico, le contestazioni, il movimento hippy…
Читать дальше