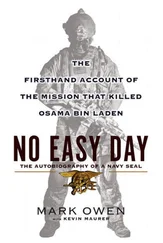«Petru parla un ottimo italiano. A proposito di dimestichezza con le lingue, maggiore, dal comando della brigata mi chiedono conferma sulle vostre capacità di poliglotta. A loro risulta che voi ve la caviate ottimamente con l’inglese, col francese e col tedesco, per non parlare dell’arabo.»
«Confermo, signor colonnello. La mia famiglia, da generazioni, si occupa di trasporti marittimi e, per tradizione, ai maschi vengono insegnate diverse lingue sin dalla tenera età. Credo di aver trascorso più anni all’estero che nella mia Genova: sono in grado di parlare senza inflessioni straniere il tedesco, l’arabo e l’americano, non l’inglese», precisò Sciarra, «e so leggere e scrivere correttamente in queste lingue. Col francese me la cavo un po’ meno bene, ma comunque saprei come districarmi in una conversazione.»
Il commercio per mare era il motivo per cui la famiglia dei marchesi Sciarra della Volta aveva abbandonato la nativa Palermo e si era trasferita a Genova, dove il bisnonno di Alberto aveva fondato un’agenzia marittima che, nel corso delle due generazioni seguenti, era diventata una tra le più rinomate e attive nel campo. I marchesi Sciarra della Volta erano ormai una famiglia molto in vista a Genova, una città che nei primi anni del secolo aveva assistito al rinascere dei suoi traffici marittimi. L’antica repubblica marinara, raccolta tra i monti e il mare azzurro, sembrava essere risorta ai fasti del passato: la città sbocciava e cresceva, austera ed elegante, offrendo ai suoi abitanti un tenore di vita sempre più alto.
Tutto questo sino a quel maledetto maggio del 1915.
Da allora tutto era stato cancellato dal freddo dei ghiacciai e dalla minaccia di morte che incombeva costante sugli uomini impegnati al fronte.
Tabarqa, 1347
Gli occhi sottili di Hito Humarawa percorsero le coste rocciose dell’Ifrikyia, e volsero un ultimo saluto alla terra che lo aveva visto vincitore. Un denso pennacchio nero di fumo si innalzava sopra ai resti di Tabarqa. Il fuoco avrebbe vinto la peste e, entro poco tempo, i veneziani si sarebbero impossessati di ciò che rimaneva della città, diventandone finalmente padroni.
Le tenui brezze autunnali delle coste africane avevano lasciato spazio a un clima più rigido, ma gli uomini mancavano da troppo tempo da Venezia: per questo motivo Humarawa aveva deciso di prendere il largo ugualmente, malgrado l’approssimarsi della cattiva stagione. Ormai lui e i suoi guerrieri avrebbero avuto ben poco da fare sotto le mura della città capitolata.
La soddisfazione della vittoria non riusciva a colmare il vuoto che aleggiava nel cuore del samurai. Strano, un uomo che era incapace di amare stava provando sentimenti profondi e contraddittori per il suo più valoroso nemico. Il Muqatil gli mancava, così come manca lo scopo di una vita, il traguardo che ci si è prefissati. La meta di Humarawa poteva dirsi raggiunta e, adesso che il Muqatil era stato sconfitto, al guerriero giapponese la vita appariva insulsa.
Wu, il gigantesco pirata di origine cinese, inseparabile ombra del suo padrone, interruppe i pensieri che affollavano la mente del samurai: «Contro chi potremo combattere da oggi in poi, mio signore? Chi riuscirà a respingere i nostri assalti con altrettanta arguzia ed esperienza? È strano, sino a ieri avrei dato qualsiasi cosa pur di passare a fil di lama il Muqatil e i suoi uomini. Oggi mi sembra che una parte della mia esistenza non abbia più senso».
«Come sta la bambina?» chiese Humarawa, cercando di cambiare discorso.
«Continua a non parlare. Rimane in silenzio nella cabina che le abbiamo assegnato, avvinghiata alla sua balia. Le poche volte che è salita sul ponte è rimasta muta a guardare il mare.»
La bimba teneva lo sguardo fisso in direzione della terraferma. Gli occhi del colore dell’acqua profonda sembravano voler imprimere nella mente i particolari del paesaggio che lentamente si allontanava a poppa. Le coste di Tabarqa stavano ormai scomparendo all’orizzonte.
Il samurai le si fece vicino. Raramente si era trovato a esprimersi con toni diversi da quelli in uso tra soldati. Adesso il guerriero indomito e senza paura pareva in imbarazzo nel rivolgere la parola a una bambina di dieci anni.
«Tu… tu parli la lingua dei cristiani, Celeste?» chiese titubante Humarawa.
Gli rispose solamente un impenetrabile silenzio.
«Io non conosco a sufficienza la tua lingua, piccola», disse il giapponese con le poche parole che conosceva in arabo.
Una lacrima scese lungo le gote della bimba, lambendole le labbra, ma negli occhi color cobalto balenò per un istante un lampo d’orgoglio e di sfida; quindi Celeste fuggì, correndo sul ponte della galea. Si arrestò solo quando la cinsero le braccia della donna che dalla nascita aveva provveduto a lei.
Humarawa tacque. Il giapponese sapeva che avrebbe tenuto fede per sempre all’ultima promessa fatta al più valoroso tra i guerrieri che avesse mai conosciuto. A qualunque costo.
Celeste aveva ancora lo sguardo appannato dal pianto quando, avvicinatasi di nuovo al samurai, si rivolse a lui nella lingua dei veneziani. Il piglio fiero ereditato dal padre attraversò i suoi occhi: «Mia madre è morta per l’epidemia che avete diffuso a Tabarqa. Tu hai ucciso mio padre e distrutto la nostra città. Io ti odio!»
Humarawa rimase impassibile. Non era capace di provare risentimento nei confronti della bambina: alcune delle cose di cui lo accusava corrispondevano a verità, ma una folla di pensieri nuovi e sconosciuti si affacciarono alla mente del guerriero.
«Se si trattasse di un giovane», si trovò a pensare Humarawa, «saprei come catturare il suo interesse: saprei insegnargli l’arte del combattimento e renderlo partecipe di ogni mio segreto… ma con una fanciulla… non so davvero come fare. Avrò tempo e modo di pensarci. Questa non è che una tra le tante battaglie che ho disputato. E certo non si tratterà della più difficile.»
In cuor suo, Humarawa cercava soltanto di convincersi della facilità di un compito arduo come quello di educare una bambina priva dei genitori.
Agosto 2002
La città sembrava immersa in una sostanza fluida, appiccicosa e invisibile, una specie di melassa bollente che rallentava e rendeva difficoltoso ogni movimento. Le strade erano pressoché deserte e le poche persone che avevano il coraggio di affrontare l’afa erano costrette a frequenti soste all’ombra.
La temperatura oltre i quaranta gradi centigradi e l’umidità prossima al cento per cento avevano messo in ginocchio New York.
In Federal Plaza, al trentaseiesimo piano dell’edificio, sede del Federal Bureau of Investigation, una decina di uomini pareva immune dall’epidemia di «apatia da calore» che aveva colpito la metropoli. L’unica eccezione rispetto alle altre riunioni che avevano tenuto con ogni tempo e in ogni luogo era costituita dalla concessione che il direttore generale aveva appena fatto ai propri collaboratori: nel corso di quel meeting avrebbero potuto levare le giacche e rimboccare le maniche delle camicie.
Il direttore generale dell’Agenzia era un uomo rigoroso, altrimenti non sarebbe mai arrivato a dirigere la più efficiente polizia federale del mondo. Conrad Deuville, questo il nome di colui che era seduto a capo del grande tavolo ovale per presiedere la riunione dei vertici dell’FBI, aveva una serie di precise convinzioni. Il rispetto della forma da parte dei suoi diretti sottoposti faceva parte di queste.
«Merda!» esclamò Deuville, mostrando la prima pagina del giornale ai suoi collaboratori. «Dio stramaledica questa manica di figli di puttana che risponde al nome di eletta casta dei giornalisti! Ci mancavano anche loro, come se non ne avessimo abbastanza!»
Читать дальше