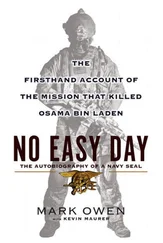Dalla imperfetta trasparenza di un vetro ancor ruvido e spesso, Crespi osservò gli uomini che scavalcavano la murata della cocca e si avviavano lungo la riva: non si trattava certo di seppellitori o di frati intenti a recuperare i corpi degli ammalati. Quelli sembravano piuttosto un drappello di guardie che, armi in pugno, si stavano dirigendo… si stavano dirigendo… «All’imboscata! Svegliatevi tutti! Ci stanno attaccando!» gridò a gran voce Crespi, mentre un forte colpo annunciava che gli uomini armati stavano sfondando il portone d’ingresso.
Humarawa fu il più pronto ad accorrere. Crespi lo intravide con la coda dell’occhio e gli sembrò una figura spettrale, avvolto nella lunga camicia da notte e non nella consueta armatura da samurai. La spada del giapponese sibilò nell’aria e la rapida posizione di guardia assunta da Humarawa infuse un immediato senso di sicurezza anche in Crespi, che si sentì pronto a fronteggiare l’assalto.
Lo scalone in legno massiccio del palazzo era ampio, perciò avrebbe consentito agli assalitori di salirlo in quattro o cinque alla volta: e loro erano solo in due a respingere l’attacco. A questo stava pensando Humarawa quando il respiro reso sibilante dalla antica ferita alla bocca lo avvertì che anche Wu si era unito a loro. Lo scontro sembrava inevitabile.
Sia per il giapponese che per Wu si sarebbe trattato di uno dei tanti duelli all’ultimo sangue a cui avevano partecipato. Diverso era invece lo stato d’animo di Crespi: non era un combattente e, anche se era in grado di maneggiare agevolmente sia la spada che l’arco, non aveva alcuna dimestichezza con la lotta corpo a corpo. La freddezza sembrava essere l’arma migliore del mercante veneziano: aveva imparato che il mantenersi calmi davanti a un avversario poteva essere un ottimo sistema per cavarsela nelle situazioni difficili. E questa aveva tutta l’aria di essere una situazione difficile.
Adil — ormai Celeste si era abituata al nuovo nome e alla diversa identità — fu destato dal grido d’allarme di Crespi. Rapido si vestì e corse verso le scale. Quando le raggiunse rimase paralizzato dal terrore: sullo scalone si stava combattendo una battaglia all’ultimo sangue.
Humarawa brandiva la katana con la destra, e con la sinistra lo spadino. Anche Crespi presidiava da una posizione dominante l’ultimo scalino e la sua arma, leggera e maneggevole, pareva più efficace dei pesanti spadoni degli assalitori.
Wu, invece, agitava come una clava una trave di legno che aveva divelto dal montante di un mobile. La sua espressione e la sua mole costituivano da sole un ottimo deterrente per chi avesse avuto a che fare col gigantesco pirata cinese.
La prima carica venne respinta senza eccessivo sforzo: avere ragione di tre abili guerrieri come Crespi, Wu e soprattutto Humarawa, posti a difendere la sommità di una scala, era difficile come espugnare la più arroccata delle fortezze.
Due dei misteriosi assalitori, feriti, guadagnarono le retrovie, mentre i loro compagni si videro costretti a indietreggiare.
«Fermi», disse Humarawa nella sua lingua, «non dobbiamo perdere il vantaggio della nostra posizione sopraelevata. Aspettiamoli qui.»
Pochi istanti più tardi partì un secondo assalto.
Quello che sembrava il capo del manipolo stava per colpire Humarawa con lo spadone, ma il giapponese scartò di lato e il colpo andò a vuoto. Prigioniero del suo stesso impeto, l’uomo ruzzolò a terra, ai piedi di Humarawa. Il malvivente non ebbe il tempo di rialzarsi che la wakizashi , tenuta nella mano sinistra del giapponese, posò la sua lama affilata sul collo del nemico.
«Adesso voglio proprio sapere da che parrocchia provieni», sibilò Humarawa, premendo la lama sulla carotide dell’avversario.
«Fermo…» disse l’altro con voce tremante, «in nome della legge. Agiamo per conto del Consiglio dei Dieci.»
«Se l’eminentissimo Consiglio manda in giro nella notte uomini in tenuta da briganti a recare disturbo ai cittadini di Venezia, io sono autorizzato a tagliare la gola di persone armate che entrano nella mia casa nottetempo.»
Ma mentre Humarawa si preparava a infliggere il colpo mortale all’avversario, gli assalitori sferrarono un nuovo attacco. Crespi, per evitare un affondo, inciampò nel giapponese.
L’uomo che era stato atterrato da Humarawa menò un calcio al basso ventre al samurai e riuscì a divincolarsi dalla presa. In men che non si dica sgusciò via e si mise al riparo tra i suoi che, approfittando della situazione, avevano guadagnato qualche scalino. Uno degli aggressori si avventò con la spada sguainata sul giapponese che ancora si trovava sbilanciato. Con la rapidità di un gatto, Humarawa stava rimettendosi in posizione di combattimento quando sentì quella strana sensazione che non è ancora dolore vero e proprio, ma è simile all’indolenzimento e accompagna inizialmente ogni ferita: la spada gli aveva trafitto il fianco.
Come una tigre ferita Humarawa urlò di rabbia e dolore mentre estraeva la lama. Poi il furore si impadronì di lui.
Adil non riusciva a tenere aperti gli occhi. Humarawa sembrava trasformato in una macchina da guerra dotata di quattro armi micidiali: i suoi arti agivano simultaneamente e con letale precisione.
Tre degli assalitori caddero sotto i colpi della fiera, altri due ruzzolarono lungo le scale per mano di Crespi e di Wu. Malridotti, gli aggressori mossero in ritirata, attestandosi alla base della scala, quasi in penombra.
Solo allora Hito Humarawa si accasciò a terra. «Prendi il ragazzino e vattene, Wu», disse il giapponese al fedéle servitore.
«Alzati, signore. Stanno per tornare», disse il pirata con la voce rotta dall’angoscia più che dall’affanno.
«Non posso alzarmi. Sto per perdere i sensi. Ti ordino di lasciarmi qui e di mettere in salvo Adil.»
Gli occhi di Wu incontrarono quelli di Celeste. Wu l’afferrò e la pose a cavalcioni sul suo fianco sinistro, scambiò un gesto di intesa con Crespi, quindi il piccolo gruppo si diresse, nella penombra, verso il passaggio segreto dell’antico palazzo. Il buio facilitò la loro fuga.
Per la prima e unica volta nella vita Wu aveva disobbedito agli ordini del suo padrone: mentre correva verso la salvezza, il gigante cinese portava in braccio Adil e sulle spalle il corpo di Humarawa privo di conoscenza.
Marzo 2004
Deidra Blasey si massaggiò la gamba. Nonostante potesse essere più che soddisfatta dei suoi progressi, le fratture provocate dall’esplosione, parecchi mesi prima, le dolevano ancora. Aveva dovuto subire sei interventi, ma ora la convalescenza era finita e si sentiva quasi del tutto in forze, anche se sapeva bene che i segni lasciati dalla bomba sul suo corpo sarebbero stati indelebili.
Il colonnello dei marine entrò nel capannone numero 24 con passo lievemente claudicante. Appena giunta nell’ufficio ricavato in un angolo dell’hangar, il sergente Kingston le si parò davanti: «Il generale Grenshover ha chiesto di vederla, signore.»
Dopo circa una mezz’ora di anticamera Deidra Blasey entrava nella stanza del comandante di Fort Lejeune.
«Riposo, colonnello… riposo.» Quello era il modo in cui il vecchio ufficiale cercava di mettere le persone a proprio agio. «L’ho convocata per dirle che l’America non può dimenticarsi di persone come lei, persone che, più duramente di altre, hanno pagato il prezzo di essere al servizio della nostra nazione. Vedo però che la gamba va meglio, colonnello.»
«Grazie a Dio, signore, non sembra che abbia subito irreparabili conseguenze…» rispose Deidra, mentre il suo sesto senso le suggeriva di stare in guardia.
«Certo, certo, colonnello Blasey, anche se a seguito dell’incidente i medici le hanno assegnato un’invalidità pari al…» Il generale aprì il dossier che si trovava sul tavolo.
Читать дальше