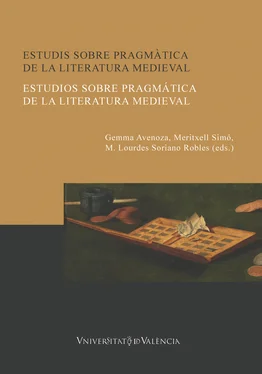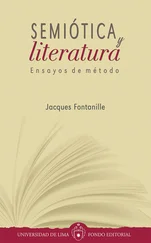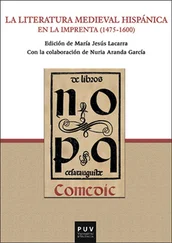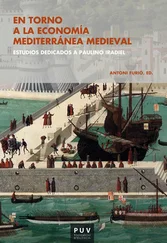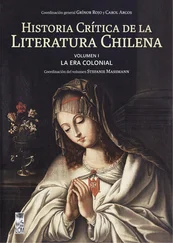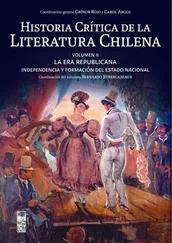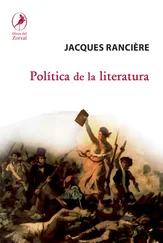La magistratura consolare rappresentantiva dell’ universitas della città, la comunità cittadina, gli «home de Montpellier», che aveva goduto nella prima metà del secolo di una relativa autonomia, diventa qui teatro del dispiegamento del rapporto di forza tra due regni: quello di Francia e quello d’Aragona. Questa storia esterna non può non essere rispecchiata nei libri del governo, memoria vivente della collettività cittadina sotto l’egida dei notai del consolato. Non è dunque un caso che il passaggio ad una vera e propria testualità narrativa avvenga in anni non lontani da questi. Nel manoscritto AA9 lo sviluppo narrativo si manifesta attraverso i parallelismi sintattici all’interno di una stessa unità narrativa e attraverso la variazione su uno stesso tema narrativo in unità successive.
Diamo un esempio dei parallelismi sintattici:
Item, en aquel an meteys a XII setembre que fon divenres, a lums atuzatz, cazet tan gran conglapi de peyras e tant abrivadas, am tant gran aondansa d’aigua, que tota la majer partida dels teules dels ostals de Monpeslier trenqueron las dichas peyras, car segon que comtavon alcus, lo casegron peyras que pezavon una lieura, et avia n’i que pezavon IIII lieuras e X lieuras e de XXV lieuras. E fon tan gran l’auratge que menet que derroquet lo cloquier de Sant Martin de Prunet et de Nostra Dona de Chaulet e derroquet gran multitut d’albres, de grans e de grosses a gran meravilhas e d’ostals. E foron tan gran aondansia d’ayguas que set bestias carguadas de trossels de draps que venian de la fieyra de Pezenas que passavon a la poncha Sant Cristol ne menet l’aygua entro al portalet de Sant Bertolmieu et aqui negueron. 8
Per i parallelismi tematici, bisognerà ricordare le innumerevoli processioni raccontate nella cronaca, dove la comunità cittadina (la universitas ) è definita dal percorrimento ritualizzato e sacralizzato della stessa città o ancora dalle tappe di un altro viaggio rituale sul quale ha attirato l’attenzione D. Gouiran in un recente convegno: quello di papa Urbano V, enfant du pays , scortato dalle galee genovesi difronte al quale si inginocchia l’ecumene.
L’esempio dei Thalami sembra illustrare in modo evidente il legame tra cambiamenti discorsivi e mutamento storico espresso consapevolmente dalle élites cittadine (notai consolari).
Quale è ora la relazione analogica che, con molta prudenza, possiamo stabilire con il canzoniere E ?
F. Zinelli (2002) ha ipotizzato nella tradizione manoscritta trobadorica due modelli di disposizione dei testi in prosa (le vidas e le razos appunto) rispetto ai testi in versi: mentre la maggior parte della tradizione manoscritta alterna il paratesto in prosa ai testi in versi, conseguenza logica di un’integrazione a testo di possibili note aggiunte in margine, RE e P 9 (ma anche a loro modo il Libre de Miquel e i canzonieri catalani Sg e V 10 ) tendono invece a autonomizzare i testi in prosa che costituiscono come si sa, sezioni anche codicologicamente separate nei canzonieri citati. Il senso della cronologia di quest’evoluzione vedrebbe il modello di REP come modello posteriore e innovativo rispetto a quello più tradizionale riflettuto dagli altri manoscritti.
Zinelli ipotizza per il canzoniere E , dotato di una sezione autonoma di vidas e razos , una genesi analoga di cui vedremmo soltanto la fine: il compilatore del canzoniere avrebbe liberato il paratesto in prosa del suo ruolo di commento, della sua funzione strumentale e subalterna di accessus ad auctorem . Le vidas sono redatte su due colonne esattamente come i testi in versi e non hanno alcuna relazione apparente con i testi poetici dei trovatori presenti nelle altre sezioni.
Al di là delle ricostruzioni erudite che permettono di separare un E lirico da un E biografico che rivelano le relazioni nascoste tra i canzonieri R et E , è necessario soffermarsi, nel nostro contesto, proprio sulla nascita di un discorso in prosa autonomo e innovante.
L’autonomizzazione di uno statuto testuale dipendente che passa da semplice commento a testo vero e proprio è un cambiamento discorsivo notevole di cui il canzoniere E ci rende partecipi. Al cambiamento dello statuto testuale si aggiunge anche l’amplificazione narrativa e ideologica.
La vida di Perdigon è un unicum dove l’autore introduce un discorso «di parte», una presa di posizione anti-francese, legata certo alla crociata della prima metà del secolo ma i cui riferimenti non potevano non richiamare la situazione in cui il canzoniere veniva assemblato.
Et estan en aquella honor et en aquel pretz, el anet ab lo primse d’Aurengua, en Guilem dels Baus, et ab En Folquet de Marceilla, evesque de Toloza, et ab l’abas de Sistel a Roma, sercan lo mal del comte de Toloza e per azordenar la crozada. Per que fon dezeretatz lo bos coms Raimons de Toloza; e sos neps, lo comps de Bezers, fon mortz, Tolzan e Caersin e Bederes e Albuges fon destruisitz; e mortz lo reis Peire d’Aragon ab mil cavaliers davan Murel e XX milia d’autres homes en foron mortz.
A totz aquestz faitz far e azordenar fon Perdigos, e.n fetz prezicansa en cantan; per que las gens se crozeron; e fes lauzor a Dieu, quar li Frances avion desconfit lo rei d’Aragon e mort, lo cals lo vestia ab se. Per qu’el descasec de pretz, d’onor e d’aver; e l’agr’en enequitat tug li valen home que remazeron viu, que no.l volgron vezer ni auzir.
E tug li baron de la soa amistat foron mort per la guerra: lo coms de Monfort e ‘N Guilem dems Baus e tug l’autre c’avian faita la crozada; e lo coms Raimons ac recobrada la terra.
Perdigons non auzet anar ni venir; el Dalfins d’Alvernhe li ac touta la terra e la renda qu’el l’avia dada. El s’en anet a Lombert de Monteill, qu’era genre d’en Guilem dels Baus, e preguet lo que lo fezes rendre en una maizo de l’ordre de Sistel, qu’a nom Silvabela. Et lo fes recebre en una morguia per morgue; e lai el definet.
Et aqui son escriutas de las soas cansos. 11
Il canzoniere E amplifica la vida duecentesca di Perdigon, piuttosto laconica e banale in altre fonti, aggiungendo particolari inediti. Insomma Perdigon, benché inizialmente sostenuto dal re d’Aragona, sarebbe passato dalla parte dei signori occitani che appoggiavano i francesi: della crociata, «e.n fetz prezicansa en cantan».
La figura di Perdigon permette il ritorno su avvenimenti ancora vicini e dolorosi, sopratutto tenendo conto dell’attualità di una Provenza diventata angioina. Il testo più tardo del canzoniere è la pastorella di Paulet de Marseille L’autrier m’anav’ab cor pensiu (BEDT 319,6), segnata da una forte presa di posizione anti-francese che rinvia, come i quattro unica del trovatore catalano Guillem Raimon de Gironela, all’ entourage del re d’Aragona. È sul padre del re d’Aragona del 1266, cioè su Pietro II
mortz lo reis Peire d’Aragon ab mil cavaliers davan Murel e XX milia d’autres homes en foron mortz
che si sofferma l’autore della biografia del canzoniere E e sappiamo quanto i trovatori abbiano cercato invano di suscitare la (ri)conquista aragonese dell’Occitania perduta a Muret con la morte di Pietro.
Non si è forse sufficientemente pensato al canzoniere E come a un tentativo programmatico di ricostruire la memoria poetica occitana ricorrendo a tutte le fonti possibili e rifondendole in una grafia unificata, immagine di una cultura che ricostruisce il suo passato per orientare il presente (ogni vera storia è storia contemporanea, secondo l’insegnamento non ancora superato di B. Croce). 12
Читать дальше