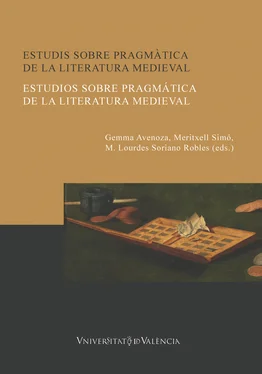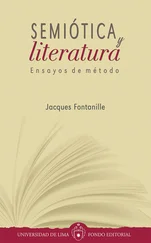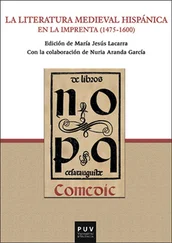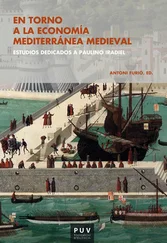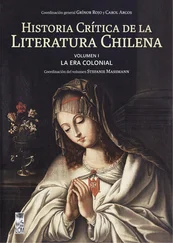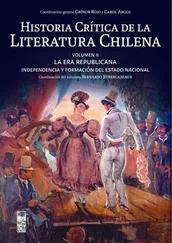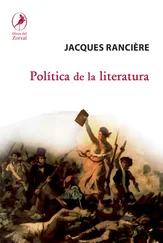Lo studio della variazione grafica della sezione storiografica dei Thalami di Montpellier costituisce un esempio notevole, facilmente databile e diacronico della scripta della città in anni cruciali per la stesura dei canzonieri trobadorici, redatti nella Linguadoca orientale. Il confronto tra la scripta di Montpellier e la grafia dei canzonieri della regione di Montpellier, o di quello che di essi resta, diventa dunque non solo possibile, ma persino auspicabile.
La prospettiva adottata porterà in un secondo momento sull’analisi degli statuti testuali della pagina manoscritta alla ricerca di elementi che possano indicare le modalità della genesi testuale della prosa. La questione della prosa occitana medievale potrà dunque essere affrontata anche da questo punto di vista e susciterà più ampie analogie.
2. LA SCRIPTA CONSOLARE DI MONTPELLIER
Cominciamo dalla tradizione manoscritta degli annali occitani di Montpellier (parte storiografica dei Thalami )
A. Arch. nat. de France, J 339, n.º 23
B. Arch. mun. de Montpellier, AA 4
C. Paris, NAF 4337
D. Bruxelles, KBR 20807-809
E. Paris, BnF fr. 14507
F. Paris, BnF fr. 11795
G. Montpellier, Bibliothèque de la Faculté de Médecine H119
H. Montpellier, Arch. Mun. AA9
I codici siglati A e B sono riservati ai Thalami in latino, detti «grandi», perché si ispirano maggiormente alle dimensioni del cartulario signorile, mentre i più piccoli, i Thalami parvi , redatti in occitano, si differenziano non solo per le dimensioni, ma anche per una più larga diffusione che giustifica la presenza di copie in gran parte perdute (Chastang, 2014: 124-130). Queste due tipologie di scrittura, i grandi e i piccoli Thalami , sono di per sé la testimonianza di una diversificazione degli usi della scrittura consolare a Montpellier. La ricostruzione della storia istituzionale a partire dalla struttura e dalla cronologia degli archivi «pietrificati» della città è di certo molto suggestiva, ma qui ciò che interessa è la scripta consolare come testimonianza unica nel suo genere di un livello di lingua estremamente elevato, che si prolunga per un lasso di tempo cruciale dal 1220 al 1426, per la parte storiografica dei Thalami . Ci serviremo dunque dello studio di Chastang come punto di partenza per andare verso lo studio della grafia dei codici.
È possibile dividere cronologicamente questi sei manoscritti in 4 fasi diverse.
Ogni coppia è stata datata a un decennio di distanza rispetto alla precedente. La prima coppia,
A. Arch. nat. de France, J 339, n.º 23
B. Arch. mun. de Montpellier, AA 4
unisce le due parti di uno stesso codice poi smembrato e catalogato in due unità diverse. Il codice A contiene solo le liste consolari: è stato redatto nel 1235, in latino. Il codice B contiene invece gli annali storiografici latini cominciati nel 1247. Si passerà in modo spettacolare all’occitano nel momento in cui si cominciano a scrivere in parallelo i nuovi codici, detti piccoli Thalami . Si tratta di:
C. Paris, NAF 4337
D. Bruxelles, KBR 20807-809
Essi rappresentano la fase più antica della scrittura consolare in occitano, il cui inizio è databile negli anni 1258-1260.
La terza coppia è rappresentata dai manoscritti:
E. Paris, BnF fr. 14507
F. Paris, BnF fr. 11795
redatti dopo il 1270; F è stato però continuato fino all’inizio del XIV secolo e presenta caratteristiche più vicine all’ultimo anello della catena, la coppia GH .
L’ultima coppia è stata appunto redatta a partire dall’ultimo decennio del XIII secolo: come per la coppia precedente, c’è un manoscritto che si ferma ( G ) e un altro che continua a essere oggetto di redazione fino all’inizio del XIV secolo ( H ).
G. Montpellier, Bibliothèque de la Faculté de Médecine H119
H. Montpellier, Arch. Mun. AA9
Sarà interessante vedere se questa datazione codicologica dello scritto pubblico di Montpellier può essere confermata e precisata dallo studio della variazione grafica dei codici. Rispetto allo stadio attuale delle ricerche, lo studio grafico dei codici può appoggiarsi solo sulla parte storiografica, che chiameremo delle Annales occitanes , la cui edizione è ormai terminata. Più ampi riscontri dovranno essere realizzati in futuro a partire dallo studio dei testi giuridici che sono ancora in fase di edizione.
Vediamo dunque quello che è possibile ricavare da una collazione grafica dei manoscritti al livello delle Annales dei Thalami .
È possibile identificare tratti grafici costanti in tutti i manoscritti, che rivelano una certa stabilità della scripta pre-diglossica, probabilmente confortata da abitudini grafiche già consolidate ( cf. infra ).
1. La dittongazione condizionata di o breve latina tonica ha curiosamente per esito grafico con pochissime occorrenze per che corrisponde invece secondo Mushacke (1884) all’esito attuale nella parlata di Montpellier [ɥɔ]; questo primo rilievo è particolarmente notevole perché sembra invertire la direzione dell’evoluzione del segmento [ɥɛ] > [ɥɔ] così come è stata in genere ricostruita (Ronjat: [ɥɔ] > [ɥɛ] (1930-1941, § 105).
2. L’affricata palatale sorda [ʧ] è rappresentata dalla (ex. Benezeg); di conseguenza il digramma viene a indicare l’occlusiva velare sonora [g] (ex. paguatz).
3. Il digramma è largamente maggioritario nella rappresentazione di n palatale [ɲ] fin dai manoscritti latini. Le grafie ibride rappresentano una percentuale trascurabile (Caiti-Russo 2014, 310).
4. La sibilante sorda [s] è rappresentata davanti alle vocali ,< i>, indifferentemente da o da . (ex. Marceilla pour Marseilla).
5. La sibilante sonora [z] è rappresentata maggiormente dal grafema .
È possibile rintracciare però anche almeno tre tratti grafici distintivi:
Il digramma per la palatale laterale [ʎ] appare una sola volta nei Thalami più antichi, mentre si generalizza a partire dal secondo codice della coppia EF che è il codice di transizione verso la coppia successiva ( ante 1270) ed è la sola possibilità data negli ultimi codici GH ( post 1290).
La palatale laterale [ʎ] è dunque rappresentata nei codici CDE con <(i) l(l)>. Esempi tratti da C : voilla de VOLIA*, conseill de CONSILIU*, fil de FILIU*.
Noteremo, d’altra parte, che la presenza del grafema per /i/ semiconsonantica in iato è costante per FGH mentre questo grafema è utilizzato solo per i nomi propri stranieri e, oltretutto, mai in iato nei manoscritti della serie CDE .
Parliamo infine dell’esito del suffisso latino –ARIU* che dà nella serie CDE <���–er> nei nomi propri ( Berenger de BERENGARIU*) confondendosi d’altronde con l’esito di –ERIU* ( Planter de PLANTERIU*) e <���–ier> nei nomi comuni (ex. USURARIU* > usurier ); il suffisso femminile – ARIA evolve in <���–eira> al femminile ( Madeira ). I tre manoscritti FGH presentano invece dovunque <���–ier> e vanno fino alla trittongazione <���–ieira> per il femminile. 2
Degli otto tratti grafici registrati, 5 sono comuni e 3 distintivi: se i primi permettono di seguire la continuità della scripta , gli ultimi ne definiscono, per così dire, l’evoluzione. Si definiscono così due modelli grafici con la loro possibile datazione: da un lato quello di CD + E (1258-1270) e dall’altra FGH ( post 1290). Sembrerebbe legittimo a questo punto confrontare i modelli grafici ottenuti per la scripta storiografica con quelli dei canzonieri composti in tempi e luoghi non troppo distanti da quelli dove hanno visto la luce i Thalami di Montpellier. Il confronto si giustifica, tanto più che si tratta, nel caso della storiografia consolare come in quello della poesia dei trovatori, di due livelli di lingua estremamente prestigiosi, entrambi carichi di valori simbolici legati a un patrimonio identitario. Bisogna anche ricordare che la scripta dei Thalami non è il riflesso della variante locale del diasistema:
Читать дальше