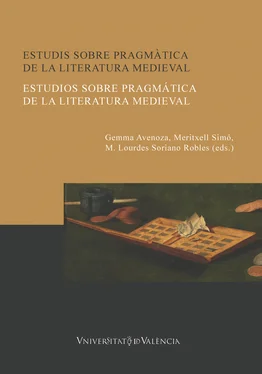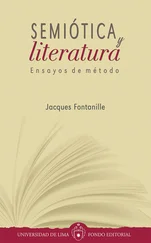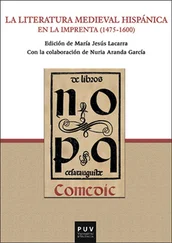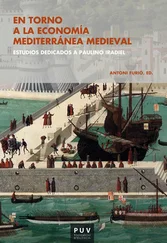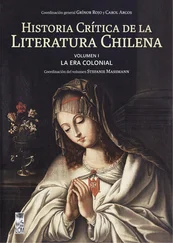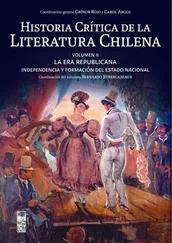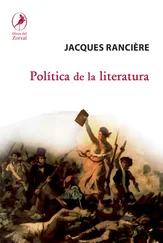Quel rapport cet occitan écrit entretient-il avec la forme orale telle que la parlent les Montpelliérains au Moyen Âge? Même s’il est difficile d’avoir une idée précise de ce que pouvait être l’occitan vernaculaire à Montpellier à cette époque, tout travail sur la langue ne doit pas se limiter à comparer la langue écrite du Petit Thalamus avec la seule forme dialectale dont nous ayons hérité aujourd’hui. Il ne faut pas tenter non plus de voir dans cet occitan écrit médiéval un simple reflet phonétique, lexical et syntaxique de l’occitan parlé à Montpellier du XIII eau XV esiècles bien que l’on puisse déceler ça et là quelques évolutions majeures du système linguistique que l’écrit enregistre, sans doute avec un certain retard sur les pratiques orales. La langue du droit et de l’administration n’est pas la langue du peuple et, aujourd’hui comme hier, le registre écrit officiel n’est pas représentatif des usages populaires d’une langue. Même si le travail de codification écrite de l’occitan au sein des Annales occitanes est bien loin d’avoir la rigidité d’une norme graphique comme nous la concevons aujourd’hui, il présente toutefois déjà des choix normatifs embryonnaires qui, comme le montrent certains indices (voir infra), établissent une distance claire avec la forme orale vernaculaire de l’époque. (Lieutard, 2017: 230).
Cominciamo con il Libre di Miquel de la Tor , dichiaratamente scritto «estant en Montpellier». Questo canzoniere, di cui si è perduto l’originale, è tuttavia ricostitutible anche graficamente (Careri, 1991 e 1996). Il suo sistema grafico è appunto per F. Zufferey da ricondurre senz’altro al canzoniere E (Paris, BnF fr. 1749) localizzato nella regione di Béziers-Montpellier «qui offre l’un des systèmes graphiques les plus cohérents qui soient» (Zufferey, 1985: 171).
A differenza degli altri due canzonieri linguadociani, C (Paris, BnF fr. 856) e R , (Paris, BnF fr. 22543), la cui variazione grafica ha sempre costituito un’evidenza, il canzoniere E ha operato una vera e propria normalizzazione grafica, rendendo più ardua la ricerca delle sue fonti risalenti ai rami ypsilon e epsilon . È importante anche notare che l’autore del canzoniere E è un native speaker libero dalle interferenze che potevano prodursi negli scriptoria italiani.
Può essere interessante paragonare il canzoniere E ai due modelli grafici definiti in precedenza a partire dalla tradizione manoscritta dei Thalami di Montpellier, scripta assolutamente legata a una città e databile con una certa precisione.
Nel canzoniere E non solo si ritrovano quelli che abbiamo definito come tratti della scripta storiografica montpellierana del XIII secolo, ma il manoscritto si posiziona chiaramente rispetto a quelli che abbiamo chiamato tratti distintivi (il grafema , l’evoluzione di –ARUM e la grafia della laterale palatale).
Il grafema è impiegato solo nella trascrizione di nomi stranieri mai in iato per indicare semiconsonantica: Ysac, Ypolite .
L’evoluzione del suffisso latino –ARUM è reso con / ou e <���–eira> (ex. ribeira ); non si registra nessuna occorrenza del suffisso tridittongato <���–ieira>.
La grafia etimologica <(i)l(l): es. meillor < MELIORE* e aussi filla < FILIA. Vi si trova persino la forma Orlac de ORLLACO, che figura nel thalamus C . Questi raffronti permettono dunque di confortare l’ipotesi legata alla provenienza della scripta , formulata da Zufferey e recentemente confermata da C. Menichetti, avvicinandola maggiormente agli usi scrittòri di Montpellier.
D’altra parte, la corrispondenza tra il modello grafico del canzoniere E e quello dei Thalami siglati CDE permette anche di ipotizzare per il canzoniere una possibile retrodatazione agli anni 1258-1270 (terzo quarto del 1200). Sono chiaramente necessari altri sondaggi per poter avvalorare con più certezza quest’ipotesi.
3. TRADIZIONE MANOSCRITTA, LANGUAGE-SHIFT
Il paragone tra il canzoniere E e la tradizione manoscritta dei Thalami può essere esteso, se si vuole, anche ad un’altra dimensione: quella dell’evoluzione degli statuti testuali. La tradizione storiografica di Montpellier potrebbe in effetti non essere priva di legami analogici con l’evoluzione delle vidas e razos in alcuni canzonieri tra cui appunto E .
La storica G. M. Spiegel 3 ha da tempo messo in evidenza come i language-shift , cioè i cambiamenti che caratterizzano la lingua, (come il passaggio dal latino al volgare) ma anche i procedimenti discorsivi, siano segni palpabili di cambiamenti storici profondi perché i gruppi sociali coinvolti in evoluzioni storiche significative tendono a utilizzare in modo consapevole modelli discorsivi alternativi.
Nella tradizione della parte storiografica dei Thalami di Montpellier, le tavole annalistiche, che elencano laconicamente le liste consolari anno dopo anno, evolvono progressivamente nell’ultimo manoscritto. È noto quanto l’uso della glossa in margine e la sua integrazione nella fase successiva della tradizione manoscritta abbiano permesso ai testi di espandersi per amplificatio ( Vid . Wolf-Bonvin, 1999).
Nella tradizione dei Thalami di Montpellier è possibile vedere in un solo codice quello che accade nelle amplissime tradizioni manoscritte dei testi letterari dotati di grande fortuna: il processo di evoluzione dello statuto testuale dal margine al corpo del testo. Tali menzioni narrative in margine prendono nel codice H il sopravvento sulle menzioni nominali annalistiche dando vita a un vero e proprio testo storiografico, che, non a caso, i primi editori critici del testo ( Vid. Pegat e Thomas, 1836-1840, vol. 4) avevano staccato dal resto della tradizione chiamandolo chronique romane .
La creazione di una testualità storiografica a partire da forme non-discorsive e arcaiche come gli annali carolingi e monastici non può non sfuggire a chi percorre la tradizione dei Thalami montpellierani (Cai-ti-Russo, 2017).
Il primo language-shift dei Thalami è costituito dal passaggio dal latino all’occitano, a partire dal 1258 per D , per B nel 1260. Questa prima data, il 1258, segna il rinnovato equilibrio tra magistratura consolare e autorità reale dopo una vera e propria ribellione all’autorità reale al suono della campana che chiama i cittadini alle armi. 4
Il secondo language-shift , discorsivo è costituito dal cambiamento di statuto testuale cioè dal passaggio dallo stato iniziale di tavole annalistiche storiografiche, elenchi di evenimentz e antiquitatz e liste consolari (è lo stadio dei codici più antichi) all’avvicinamento gerarchizzato delle due tipologie e alla migrazione progressiva delle glosse dal margine verso il corpo del testo, sede di una testualità sempre più complessa. La genesi di questa forma di testualità nuova avviene durante la lunga e incerta fase che segna l’evoluzione del consolato montpellierano. La morte di Giacomo nel 1276 segna il passaggio da Montpellier al regno di Maiorca con Giacomo II. 5 Anche qui la tensione tra il potere aragonese e la universitas di Montpellier è palpabile in seguito al giuramento prestato al sovrano che, al di là delle forme, non doveva per la città essere un atto di sottomissione. 6 Il 1280 è l’anno del tentato omicidio di Pierre de Clermont luogotenente del re di Maiorca. La città fa parte dello scacchiere continentale del conflitto franco-aragonese cominciato con i vespri siciliani ed è coinvolta nella crociata francese contro gli aragonesi. Nel 1282 Montpellier, dopo l’assedio della città da parte del senescalco di Beaucaire, riconosce la sovranità del re di Francia, al quale il re di Maiorca presenterà l’omaggio l’anno seguente. L’anno 1285 segna lo stabilirsi del dominio francese sul Rossiglione. 7
Читать дальше