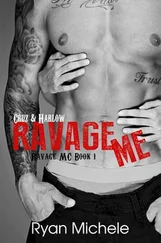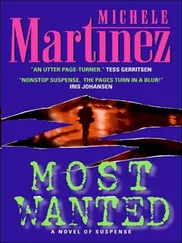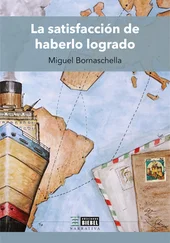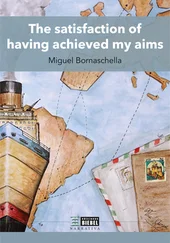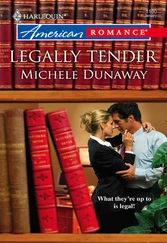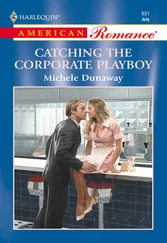In molte case si sentivano dire storie terribili, con epiloghi difficili da raccontare. Chi partiva per la guerra, sia durante la Prima che la Seconda, sottometteva la sua volontà alle esigenze e capricci del destino. A casa si perdeva la speranza di avere sue notizie, e così la sua posizione finiva per essere come il vento che passa senza che si sappia da dove viene o dove va. Poteva essere stato preso prigioniero e lavorare come tale in un altro paese, o essere un morto senza lapide, o forse aveva perso la memoria e non sapeva come tornare a casa. Ma se accadeva che la misericordia di Dio lo aiutasse a tornare, sospendendo l’oblio di anni della moglie e dei figli, la sua vecchia casa ormai non era più sua, perché i suoi figli ora condividevano la tavola con i nuovi figli che sua moglie aveva avuto, e sua moglie non era più sua perché, dato che lui non esisteva più, era diventata la moglie di qualcun altro che avrebbe potuto perfino essere stato suo vicino in passato, prima che la guerra avesse messo tutti sullo stesso gradino della tragedia.
I ricordi di mia madre mi hanno fornito anche i dettagli necessari per capire in quale forma e a qual punto la rassegnazione fosse penetrata nell’anima delle persone. Durante una delle offensive dei tedeschi, uno zio di mio padre, e altri vicini del paese, cercarono di respingere i nemici lanciando loro pietre e sassi dall’alto della montagna. Per tutta risposta i tedeschi usarono mitragliatrici. Le schegge lo ferirono a una gamba, ed egli, con un trattamento di emergenza e con la gamba sanguinante, tornò ai rifugi di fortuna nei boschi delle montagne, fino a quando, qualche giorno dopo, la Croce Rossa lo portò via per assisterlo in migliori condizioni, dato l’avanzare dell’infezione. La permanenza dello zio per più di sette mesi nel rifugio fu presa con rassegnazione, non ci furono né sorpresa né scossoni, né differenza tra la sua presenza e la sua assenza. Il prozio ritornò e la sua vita, così come quella nel rifugio, continuò come se il vuoto nella storia non fosse mai esistito, non per indifferenza o mancanza di affetto, ma per il puro sentimento di impotenza e dolore di tutti.
Quando i tedeschi decidevano di bombardare, la gente, nuda e in preda al panico, correva da una parte all’altra in cerca di rifugio in cavità e grotte nella montagna. In una di quelle fughe mio fratello Angelo informò mio padre di aver perso la scarpa sinistra. Mio padre voleva recuperarla, ma sarebbe stato meglio se mio fratello avesse segnalato il fatto non appena accaduto, tre chilometri prima. L’impresa di recuperare la scarpa era inutile e suicida, così il povero Angel visse i sei mesi seguenti con un pezzo di stoffa legato con corde attorno al piede e alla caviglia, in sostituzione della calzatura persa.
Terminata la seconda guerra mondiale, oltre alle ferite che si vedevano e quelle che non si vedevano, c’erano altre conseguenze più concrete e meno dolorose. A causa dello spostamento al nord, per la fretta necessaria o per il bisogno di proteggersi, durante la loro ritirata le truppe lasciarono diverse cose lungo la loro strada. Quando tornò la pace e il paese e dintorni non furono più occupati dalle truppe dell’una o dell’altra parte, si potevano trovare dappertutto resti dei loro averi ed effetti personali. Era molto comune trovare stivali, camicie sporche, così come grandi quantità di proiettili in sacchi di stoffa, pneumatici fuori uso, pezzi di jeep e camion delle truppe e persino un carro armato. I pezzi di ferro erano raccolti e venduti come rottami in diversi punti del paese. Così si riusciva a migliorare un po’ la condizione economica di ognuno. Coi copertoni degli pneumatici si realizzavano calzature casalinghe chiamate “scarponi”. Erano veri e propri certificati di povertà, ma, in mancanza d’altro, risultavano di grande utilità. Le gambe si coprivano dai piedi fino a sotto alle ginocchia, con un pezzo di stoffa di lino. Quindi si collocavano i pezzi di gomma, ben tagliati in base alle dimensioni del piede, lasciando un bordo ad ogni lato con dei piccoli fori dove si facevano passare delle stringhe di cuoio. Queste stringhe si incrociavano cercando di emulare quelle dell’ “età moderna”, e con lo stesso procedimento si continuava fino a sotto le ginocchia. Più fortunati erano coloro che trovavano le gomme delle moto, poiché, essendo più strette, si adattavano al piede in modo “anatomico”. Inoltre, l’uno o l’altro tipo di calzatura permetteva di non dover pensare a piccolezze come doverle lucidare o distinguere il sinistro dal destro.
Una volta, un compaesano e mio padre trovarono una ruota. Era gonfia e aveva persino il cerchione. Pronti a farsene i propri “scarponi”, l’aggredirono con il primo attrezzo che avevano a portata di mano. Così cercarono di attaccarla con un’ascia, ma la ruota, come se fosse viva, restituì loro il colpo facendoli a sua volta rimbalzare l’uno sull’altro. Non si diedero per vinti e con l’ascia e altri attrezzi, riuscirono a ferirla abbastanza perché esalasse la sua aria fino all’utilizzo desiderato.
Mio padre trovò anche un giaccone militare, molto utile durante l’inverno. Nel corso del rinvenire oggetti, la sorte gli concesse di incrociare il cammino con un’arma semiautomatica, che dai suoi racconti penso fosse una calibro 45. Per l’aspetto e la qualità, l’arma probabilmente era appartenuta ad un ufficiale di alto rango. Mio padre che sapeva utilizzarla, orgoglioso, insegnò a mia madre a valersene. Per i proiettili non c’era di che preoccuparsi, perché si trovavano senza difficoltà. I miei genitori mantennero il segreto sul ritrovamento, non la sfoggiavano né la mostravano, ma in un qualche modo era filtrata l’informazione e circolava la voce che c’era un’arma sofisticata per quei tempi e chi l’aveva. L’arma è sempre rimasta al sicuro, nascosta in un buco tra gli spessi muri della casa. Quando mio padre emigrò in Argentina, mia madre si fece carico dell’arma e del giaccone. In quei tempi di scarsità di cibo era normale che nei coltivi ci fossero alcuni atti di saccheggio e furti del raccolto, che, per quanto piccoli, in mezzo a tante ristrettezze, causavano grande danno. Per poterli portare a termine, alcuni rimanevano nei campi più degli altri o pernottavano nelle baracche vicine e al momento giusto facevano l’incursione nelle proprietà altrui. Mia madre, cui senza dubbio non mancavano risorse, tornava in valle con il giaccone e l’arma e sparava alcuni colpi come una raffica di mitragliera sorprendendo la tranquillità della valle e preavvisando chiaramente chiunque osasse toccare ciò che non gli apparteneva. L’eco dei colpi si propagava come un segnale d’avvertimento, e si sapeva benissimo da dove veniva, chi la portava e che giaccone la ricopriva. Il commissario insistette un paio di volte facendo visita a casa nostra, chiedendo dell’arma e reclamandone la consegna. Mia madre ha sempre negato la sua esistenza e il commissario finiva per accettare con rispetto la risposta.
Ma non era solo il commissario a rispettarla, quando le donne l’incrociavano e la vedevano vestita col giaccone la salutavano con riguardo e soprattutto gli uomini ancora di più. Dopo la nostra partenza per l’Argentina e passati un paio d’anni, nella casa di via Piano 4 furono necessari alcuni lavori di ristrutturazione, che comportarono l’abbattimento di un muro, e lì comparve l’arma. Si denunciò il fatto e il commissario potè finalmente chiudere il caso. Raccontano i presenti che con l’arma in mano disse con un sorriso nostalgico: “finalmente... dopo tante ricerche”.
Ciò che sopravvisse alle devastazioni della guerra, oltre alla vita di tutta la mia famiglia, fu il grande caseggiato. Devo riconoscere che dentro i limiti della povertà che regnava in paese, la nostra casa si distingueva dalle altre. Il mio bisnonno Giovanni Ricci veniva da una famiglia che stava un po’ meglio di altre. Il tutto grazie ad alcuni stratagemmi della madre. Lei si sposò con un Ricci con denaro, padre di Giovanni Ricci. All’epoca era abbastanza comune sistemare la questione con soluzioni diverse dall’amore. Si usavano le motivazioni più stravaganti sulla convenienza di stipulare il matrimonio dei figli. La madre di Ricci fece uso di un sogno che raccomandava il matrimonio, con quella persona che, “casualmente” apparteneva a una famiglia bene. Verità o menzogna, raccomandazione della provvidenza o argomento pratico, il fatto è che col tempo le nostre famiglie furono favorite da quella trovata. Grazie a quel matrimonio, poterono costruire una casa che finì per distinguersi in paese. La costruzione iniziò nel 1850 e finì nel 1855, come rimase inciso per sempre nell’arcata della porta principale. Così fu eretto il “palazzo, isolato”, come si chiamava quel tipo di edificio. Aveva uno spazio centrale, chiamato “cortile” circondato da diversi ambienti che erano assegnati, com’era tradizione all’epoca, ai differenti membri della famiglia, che a loro volta abitavano con le rispettive famiglie. Com’era logico e giusto, quindi, le proprietà si tramandavano di generazione in generazione, e siccome di solito nessun erede poteva comprare la parte che spettava all’altro, gli appartamenti venivano divisi tra tutti gli aventi diritto.
Читать дальше