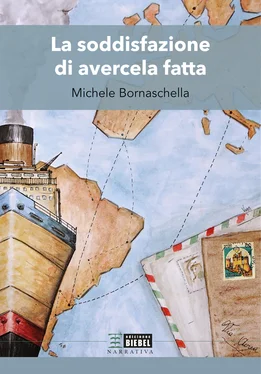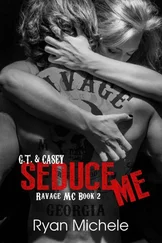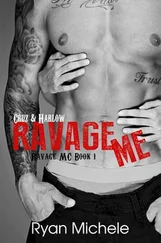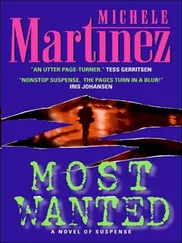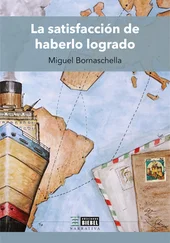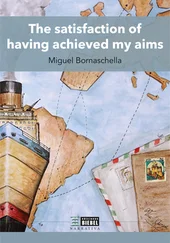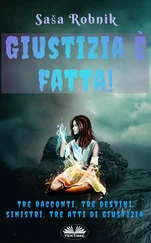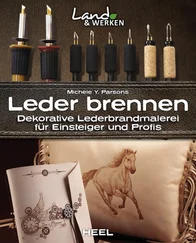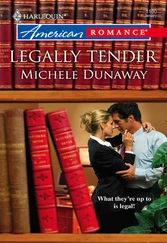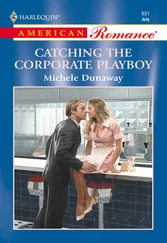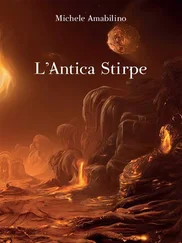Durante il corso dell’anno le famiglie allevavano il loro maiale per poterne ottenere la carne. Quindi si tagliava in porzioni abbastanza piccole e si metteva in grandi vasi di pietra chiamati “pila” ricoperti di grasso, nelle stanze destinate ai beni e le conserve, fino all’anno successivo. Tra le altre cose, lí si conservavano i pomodori secchi oppure le bottiglie con la salsa di pomodoro già lavorata dopo il rito del raccolto. Questa cerimonia era una specie di festa del paese in cui ognuno aiutava l’altro a trattare la sua produzione, e l’unica contropartita era la successiva collaborazione con chi aveva collaborato precedentemente, realizzando così uno scambio di profitto. Tutti i membri della famiglia partecipavano ed era considerato uno dei grandi eventi del paese. Lì non solo si preparano i pomodori, si sbucciava il grano ed il mais e si raccoglievano legumi. A lavoro ultimato, alcuni vicini iniziavano a suonare un po’ di musica e a ballare. Mio padre partecipava attivamente in ogni aspetto del lavoro. Era un gran lavoratore, instancabile ma anche famoso in paese per la sua abilità di suonare l’ organetto con otto bassi. Mia madre non ne era particolarmente entusiasta. Quando mi portava in grembo, non era facile per lui poter partecipare. Fu così che mio padre assieme ai suoi amici, montarono una commedia, credendo di essere originali, che consisteva nel fatto che loro andassero a chiamarlo e lui dovesse negarsi nel modo più convincente possibile. L’atto si svolse a tarda notte, gli amici in strada e mio padre da casa mia, rispondendo e ‘resistendo’. Mia madre li fece recitare per un po’, finché la pazienza glielo permise, e poi, facendogli credere che effettivamente l’avessero convinta, lo lasció andare. Ma a notte inoltrata, mio padre non tornava. Il tempo era scaduto e mia madre andò a cercarlo, immaginando ciò che stava accadendo: la famosa frase “chi suona, non balla mai”, non si adeguava alla situazione. Fu così che la fisarmonica, mamma e papà tornarono a casa. E la fisarmonica rimase rinchiusa per un bel po’ di tempo.
Con i frutti della terra raccolti e gli animali macellati, con i relativi baratti, con l’aggiunta del lavoro di preparazione e dopo aver razionato ed amministrato equamente tutto ciò che c’era, allora si poteva mangiare. La distribuzione che mia madre faceva all’ora di pranzo e di cena aveva la stessa equità di quella usata dalle persone in paese quando barattavano i loro beni. A casa la porzione di cibo era in base alla quantità di lavoro svolto. Nessuno aveva il diritto di discutere questa distribuzione, giacché l’unica a soffrirne le conseguenze era mia mamma, l’ultima a servirsi e con la porzione più piccola. Le ripercussioni di quella dieta rimasero impresse per sempre nella sua magra piccola figura, anche se in generale godette sempre di buona salute. Tranne che per il logico deterioramento causato dall’avanzare dell’età, non l’ho mai vista malata, né a letto, né in riposo, né lamentarsi o vantarsi di essere lei a prendere le decisioni a casa, né in Italia né in Argentina. Non si è mai ammalata perché lei stessa decideva di non farlo. L’idea di ammalarsi era come fermare gli ingranaggi di un orologio. Le passavano i raffreddori, l’influenza, i dolori alle ossa. Questi malanni le capitavano come a tutti, ma lei continuava nelle sue cose, senza lamentarsi di nulla. Negli ultimi anni della sua vita diceva che la gente la vedeva molto bene e la adulavano: “Sì, certo che mi hai sempre visto bene”, diceva sempre, “ma il fatto è che non mi sono mai lamentata, perché tanto le lamentele non cambiano mica le cose”.
Ha lavorato tanto quanto mio padre. La mattina presto mungeva la mucca e in seguito preparava la cagliata e il formaggio. Faceva la colazione per i suoi figli, tutte le mattine passava il mio latte da una tazza all’altra per raffreddarlo e poi mandava a scuola mio fratello e le mie sorelle. Un altro impegno quotidiano era andare alla fontana con una tinozza di rame, percorrendo trecento metri per poterla riempire dell’acqua che scorreva giù dalla cima della montagna attraverso una rete di condutture fino al centro del paese.
Durante l’inverno, e durante il disgelo, molto lento e graduale, l’acqua usciva fiaccamente dalla fontanella al termine del percorso, con un rivolo che non faceva che rallentare le attività del paese. Si formavano, infatti, lunghe code con molta (e alle volte non tanta) pazienza. Visto dal lato positivo, si realizzava un legame sociale che comportava il pretesto perfetto perché le ragazze dessero speranze ai giovanotti e germogliassero nuovi amori. Ma non tutte le relazioni erano così amichevoli. Le poche famiglie che potevano, pagavano i vicini perché facessero tutto questo lavoro di trasportare loro l’acqua. I problemi non tardavano ad arrivare, di tanto in tanto, e quando qualche tinozza superava abusivamente le altre, cominciavano delle belle risse, con tinozze prese a calci e ammaccate. Alla fine, mia madre tornava a casa con i venti litri d’acqua nella tinozza, portata sulla testa e ammortizzata da un panno attorcigliato a corona. La mamma non era estranea ai litigi e anche la sua tinozza aveva le corrispondenti ammaccature. Padroneggiava un’abilità senza pari e un saldo equilibrio perchè non traboccasse una sola goccia d’acqua, che così arrivava a casa, perché potessimo cucinare o lavarci.
I vestiti si lavavano nel fiume con il sapone che, non poteva essere altrimenti, anche quello faceva mia madre, cuocendo grasso di maiale e soda caustica. La sua routine proseguiva con la preparazione del pranzo che poi portava nel pezzo di terra dove lavorava mio padre. Mentre lui pranzava, lei proseguiva col lavoro del campo e quando finiva di pranzare continuava a lavorare. Tornava a casa per preparare la cena, aspettare mio padre e, se del caso, a tempo giusto, assolvere i doveri coniugali, ai quali, come raccontava a mia figlia Lorena, molti anni dopo, non era pensabile negarsi. Di nessuna di queste cose si è mai lamentata. La sua natura, il suo spirito, era quello del sacrificio con semplicità, e, in tante altre situazioni, l’accettazione di questo sacrificio senza dare la colpa a nessuno per tale sorte.
La guerra attraversò questo paese, come molti altri in Italia e in Europa, lasciando un solco di ricordi che si tramandavano di generazione in generazione, perché il dolore del cumulo di ferite non poteva essere taciuto. La storia, che in linea di principio appariva molto semplice e banale, negli occhi dei figli e nipoti prendeva nuovamente la dimensione della tragedia, che, pur ovvia, non fu facile da sopportare. Il luogo comune di dire che la sofferenza fu terribile, non era sufficiente come denuncia della sua dimensione reale, del suo scenario, della sua durata nel tempo e delle sue irrimediabili conseguenze. Cercare di raccontare sarebbe un compito che non avrebbe mai fine.
Nella prima guerra mondiale mio padre perse il suo all’età di sei anni. Non molto tempo fa ho potuto recuperare questi ed altri dati con più precisione. Fu così che ottenni una copia del suo certificato di decesso: Angelo Bornaschella morto il 19 Ottobre del 1918, qualche mese prima della fine della guerra a causa di una bronchite che esitò in un’infezione generalizzata. Morì nell’Ospedale da Campo numero 56, a Gubbio, nella regione montuosa di Zangolo. Seppi anche che il suo numero di matricola era 20562 e che aveva prestato servizio nella Seconda Compagnia della Brigata “Messina”.
Qualche tempo dopo la madre di mio padre sposò il fratello di mio nonno, Angelo. A quei tempi questo modo di riorganizzare le famiglie era qualcosa di naturale e necessario. Tra altre molte finalità naturali, c’era l’obiettivo di proteggere la donna, prendersi cura dei suoi figli e mantenere salda la famiglia. Sotto la protezione di questa nuova unione e di questo rinnovato amore, mio padre ebbe altri quattro fratelli. Ma non tutte le nuove organizzazioni familiari avevano lo stesso destino.
Читать дальше