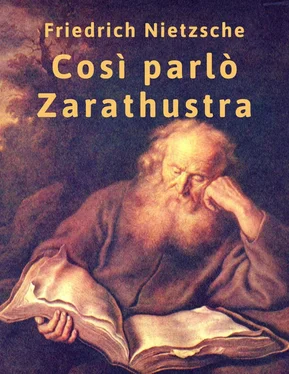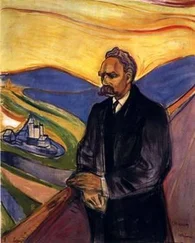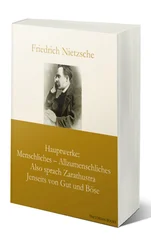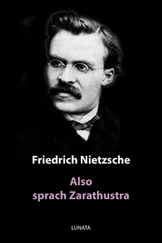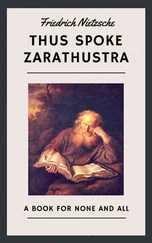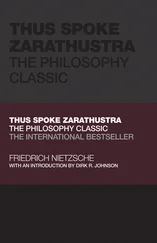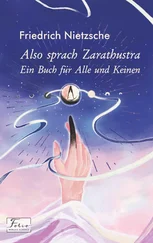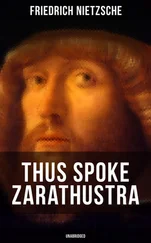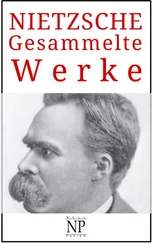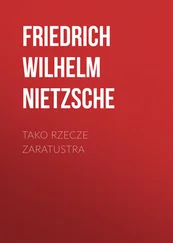Sils Maria, 26 agosto 1881».
In quell'estate del 1881, mio fratello si sentì nuovamente, dopo molti anni, più debole e peggio di un convalescente, e nella piena sensazione della sua precedente e ottima salute non nacque soltanto la «Gaia scienza», – che per la sua intonazione dev'essere considerata come un annunzio di Zarathustra, bensì la stessa opera di Zarathustra. Un destino crudele volle ora che, appunto al tempo della sua guarigione, gli sopraggiunsero molte dolorose esperienze personali. Egli sofferse profonde disillusioni nell'amicizia che teneva così alta e sacra, e per la prima volta sentì, in tutto il suo orrore, quella solitudine a cui è condannato ogni grande. L'abbandono è qualcosa che differisce interamente da una solitudine volontaria e beatificante. Come anelò allora al perfetto amico che lo comprendeva pienamente, al quale poteva dir tutto, e che credeva aver trovato fin dalla prima giovinezza e nei diversi periodi della sua vita! Ma ora che il suo sentiero diveniva sempre più scoseso e pericoloso, non trovava più alcuno che potesse andar con lui; così egli si creò nella figura ideale del filosofo regale il perfetto amico, e fece annunziare da lui i suoi scopi più alti e più sacri.
Chiedere se, senza le amare esperienze del tempo d'intervallo, egli avrebbe portato a compimento il primo abbozzo di «Così parlò Zarathustra» nell'estate del 1881, e vi avrebbero dominato quelle tonalità di gioia che conosciamo dallo schema, è adesso una domanda oziosa. Ma forse possiamo dire con Meister Eckardt, anche nel rispetto di Zarathustra: «L'animale più svelto che vi conduce alla perfezione è il dolore».
Mio fratello scrive, circa il sorgere della prima parte di Zarathustra: «L'inverno 1882-1883 vissi in quell'ameno quieto golfo di Rapallo, non lungi da Genova, che s'interna tra Chiavari e le alture di Portofino. La mia salute non era ottima; l'inverno era freddo e oltre misura piovoso; l'albergo piccolo dava immediatamente sul mare, così che di notte non si poteva dormire; ed avevo quasi in tutto l'opposto di ciò che sarebbe stato desiderabile. Malgrado questo, e quasi a dimostrazione della mia frase che ogni cosa decisiva accade «non ostante tutto» fu in quell'inverno e in quelle condizioni sfavorevoli che nacque il mio Zarathustra. La mattina salivo verso il sud prendendo la strada magnifica che mena a Zoagli, costeggiata dai pini e che domina il mare lontano; il pomeriggio, appena lo consentiva la mia salute, facevo il giro del golfo da Santa Margherita sino a Portofino. Questa località e questo paesaggio m'è ancor più caro per il grande amore portatogli dall'imperatore Federico III; nell'autunno circa del 1886 io ero di nuovo su quella spiaggia quand'egli visitò per l'ultima volta quel piccolo dimenticato regno di felicità. Mi venne così in mente, per queste ragioni, l'intero primo Zarathustra, sopratutto Zarathustra stesso, quale tipo; o piuttosto egli stesso m'afferrò...».
Questa prima parte di «Zarathustra» fu scritta in appena dieci giorni, dal principio fin verso la metà del febbraio 1883. «La parte di chiusa fu appunto ultimata nell'ora sacra in cui morì a Venezia R. Wagner».
Mio fratello indicò quel tempo, ad eccezione dei dieci giorni nei quali scrisse «Zarathustra», come il più cattivo per la sua salute; ma non intende con ciò le sue precedenti condizioni di salute, bensì una forte influenza che lo colpì a Santa Margherita e lo oppresse ancora per molte settimane a Genova. Ma intendeva sopratutto lo stato dell'anima sua, quell'indescrivibile abbandono per il quale aveva trovato parole di così lacerante dolore in Zarathustra.
Anche l'accoglienza che trovò la prima parte di Zarathustra fra conoscenti ed amici fu molto opprimente, giacchè non si sentì compreso da coloro ai quali la diede. «Per molte cose che avevo detto non trovai alcuno maturo; Zarathustra è una dimostrazione che si può parlare con la maggior chiarezza senza essere intesi da nessuno». Mio fratello fu grandemente scoraggiato da questa incomprensione; e siccome al medesimo tempo si disabituava con gran forza di volontà al sonnifero cloralio, ch'egli aveva usato al tempo dell'influenza, la primavera seguente, (1883), che passò in Roma, fu piuttosto triste. Egli scrive intorno a ciò: «Seguì una triste primavera a Roma, dove conducevo la mia vita, che non era facile. In fondo mi urtava quel luogo indecoroso per il poeta di Zarathustra, che non avevo scelto fra gli altri di mia volontà; volevo andare ad Aquila, l'opposto di Roma, fondata appunto per inimicizia a Roma come io fonderò un giorno un luogo in ricordo di un ateo e nemico comme il faut della chiesa, mio vicino parente, il grande Hohenstaufen – l'imperatore Federico II. Ma fu un destino per tutti: dovetti tornare indietro. Infine mi acquetai in piazza Barberini, dopo d'essermi stancato nell'affannosa ricerca di una contrada anticristiana. Temo d'aver chiesto una volta, per evitare cattivi odori, se ci fosse stata una tranquilla camera per un filosofo nello stesso palazzo del Quirinale. Sopra una loggia, in alto, su questa piazza dalla quale si vede la città e si ode il mormorio della fontana; fu composta quella canzone così solitaria come non era ancor mai stata pensata, del canto notturno; a quel tempo avevo sempre nella fantasia una melodia di tristezza indicibile di cui ritrovavo il ritornello nelle parole: morto d'immortalità ».
Quella primavera noi restammo un po' troppo a Roma; e sotto l'influsso del tempo afoso e opprimente ch'era sopraggiunto allora, e dello scoraggiamento cui accennai, mio fratello decise di non scrivere più affatto, e ad ogni modo di non continuar Zarathustra, sebbene io mi fossi offerta di togliergli ogni pena per la stampa e l'editore. Ma quando, il 17 giugno, ritornammo in Isvizzera ed egli visse di nuovo a contatto della familiare salubre aria dei monti, si risvegliò allora tutta la sua gioconda volontà di creazione, ed egli mi scrisse circa un futuro manoscritto in preparazione: «Ho affittato qui per tre mesi: in realtà sono il più gran pazzo se mi lascio scoraggiare a cagione dell'aria italiana. Di quando in quando mi sorge il pensiero: che avviene dopo ? Il mio «avvenire» è per me la cosa più oscura del mondo; ma siccome ho ancora molte cose da compiere, dovrei pensare solo ad esse come al mio avvenire e lasciare il resto a te e agli dèi».
La seconda parte di Zarathustra fu scritta tra il 26 giugno e il 6 luglio a Sils-Maria: «Tornato, l'estate, nel sacro luogo dove mi balenò alla mente la prima idea di Zarathustra, io trovai la seconda parte dell'opera. Dieci giorni furono sufficienti; non ne bisognai di più in nessun caso, nè per la prima nè per la terza o per l'ultima parte».
Egli parlò spesso dello stato di rapimento durante il quale scrisse Zarathustra, come fosse propriamente assalito da una folla di pensieri lungo le sue passeggiate girovaghe, e potesse solo prenderne, in fretta, alcuni appunti a lapis, nel suo taccuino; appunti che egli, ritornando, scriveva poi in inchiostro, fino a tarda notte. Egli mi dice in una lettera: «Tu non puoi farti facilmente un giusto concetto della veemenza di queste formazioni»; e descrive con entusiasmo appassionato, nel Ecce Homo (autunno 1883) l'incomparabile stato d'animo in cui fu creato Zarathustra:
«V'è qualcuno, alla fine del secolo XIX, che abbia un concetto chiaro di ciò che i poeti dei vecchi tempi chiamavano ispirazione? In caso contrario voglio descriverlo. Con un briciolo di superstizione si potrebbe infatti appena negare l'idea di essere soltanto incarnazione, strumento, medium di forze prepotenti. Il concetto di rivelazione nel senso che d'improvviso, con indicibile sicurezza e profondità, qualcosa si palesi, si faccia sentire, e agiti, e scuota, nel più profondo, descrive semplicemente la consistenza del fatto. Si sente – non si cerca; si prende, – non si chiede chi dia; un pensiero lampeggia imperioso senza indugio, – io non ho mai avuto possibilità di scelta. Un rapimento la cui tensione si risolve in una crisi di lagrime, e durante il quale il passo ora involontariamente freme, ora diviene lento; una perfetta estrinsecazione con la più distinta coscienza d'infiniti sottili brividi e tremiti fino alla punta dei piedi; una profondità di gioia nella quale ciò che v'è di più doloroso e di più cupo non agisce quale contrasto ma come una tinta, richiesta e necessaria, in una tale esuberanza di luce, un istinto di ritmiche condizioni teso sul grande spazio delle forme (la lunghezza, il bisogno di un ritmo più teso, è quasi la misura per la forza dell'ispirazione, una specie di compenso per la sua pressione e la sua tensione). Tutto accade, nel punto culminante, involontariamente, ma come in un uragano di sentimenti di libertà, di cose incondizionate, di potenza, di divinità. L'involontarietà delle imagini, delle similitudini è il fatto più meraviglioso; non si ha più concetto alcuno di ciò che sia imagine, similitudine, tutto si presenta come l'impressione più vicina, più giusta, più semplice. Sembra, in realtà, per ricordare una parola di Zarathustra, come se le stesse cose potessero essere similitudini: «Qui tutte le cose giungono carezzevoli alla tua parola e ti allettano, perchè vogliono cavalcar sul tuo dorso. Per questa similitudine tu cavalchi a quella verità. Qui ti si rivelano le parole di tutto l'essere e gli scrigni segreti delle parole; ogni esistenza vuol qui divenir parola, ogni divenire vuole imparare da te a parlare». Questa è la mia esperienza dell'ispirazione; io non dubito che si debbano risalire dei secoli per trovare qualcuno che mi possa dire: è pure la mia».
Читать дальше